|
27 agosto
PRECARI In affitto dall'agenzia «Interim 25»,
rispondono per la Tim. Ma dopo due mesi non hanno ancora
visto un euro
Call center
Atesia, adesso i problemi toccano agli interinali
Antonio Sciotto
ROMA
Vuoi o non vuoi ad Atesia, il call center più grande
d'Italia, c'è sempre qualche problema. Dopo l'abbondante
stabilizzazione dei precari storici - con luci e ombre,
nel corso del 2007 - adesso tocca agli interinali. Presi
in affitto attraverso le agenzie Metis, Adecco e Interim
25, ad alcuni capita di lavorare senza venire
retribuiti. In particolare, ci occupiamo di quelli della
Interim 25, società che ha sede legale a Bari, ma che
quest'anno aveva trovato una novantina di persone per
l'emergenza estiva attraverso la filiale di Roma. Tutti
lavoratori da impiegare al 119 della Tim. I novanta
hanno fatto un corso di 15 giorni che avrebbe dovuto
essere retribuito intorno ai 300 euro, con relativo
attestato finale. Circa la metà di loro ha passato la
selezione di fine corso e ha regolarmente preso servizio
dal 7 luglio, per un contratto di due mesi: e il primo
stipendio sarebbe dovuto arrivare già a inizio agosto.
Ma siamo costretti a tutti questi condizionali perché
dei soldi non s'è vista traccia e, come se non bastasse,
la Interim 25 di Roma dopo alcune telefonate di protesta
ha deciso di non rispondere più, lasciando un numero
affisso in bacheca: per info contatta la sede di Bari.
Noi ieri pomeriggio abbiamo provato ripetutamente a
chiamare, sia Roma che Bari, ma non ci ha risposto
nessuno.
«Ormai sono quasi due mesi che lavoro ma non ho ricevuto un euro - ci spiega un operatore, che per motivi comprensibili lasciamo nell'anonimato - Siamo esasperati, dobbiamo pagare affitti, bollette, abbiamo problemi persino con la spesa. Abbiamo chiamato decine di volte la Interim 25 ma ormai alla sede di Roma non ci rispondono più. A Bari abbiamo trovato qualcuno che ci ha ascoltato, ma non ci ha dato risposte esaurienti». E così, quasi per un crudele contrappasso, gli addetti al call center hanno dovuto attaccarsi a un altro call center per ottenere il loro salario. Almeno 800 euro per il solo luglio, senza contare le maggiorazioni per domeniche e notti; e gli straordinari: per alcuni sono più di 20 ore. Un po' il fatto che i dipendenti di Atesia sono in ferie, un po' le campagne estive, il lavoro non manca. E anche i 300 euro del corso: per ora nisba. E dire che si è svolto con tutti i crismi nella sede di Atesia, con una formatrice della Tim. Alla faccia, è tutto gratis? Per il momento, pare di sì, anche se gli operatori annunciano vertenze a raffica: «Noi non ci arrendiamo, non è giusto lavorare e non essere pagati nelle scadenze giuste. E' una questione di correttezza. E poi con cosa viviamo?». Si tratta di contratti da 30 ore settimanali, quasi un full time, e dunque praticamente l'unica fonte di sostentamento per la gran parte dei lavoratori. A 30 ore settimanali, comunque, arriveranno gradualmente anche i dipendenti di Atesia, grazie a un accordo di giugno: chi ne farà richiesta, potrà passare da 20 (o 25) a 30 ore. Il tutto in 3 anni, i primi 450 operatori già in settembre. Ma nonostante questo, Atesia continua a pescare nelle agenzie interinali. Per tutti, comunque, va ricordato l'appuntamento del prossimo 19 settembre: a Roma si terrà la prima manifestazione nazionale dei call center.
Gran
Bazar Mussolini
di Ilvo Diamanti
Domenica scorsa, tardo pomeriggio, sono passato per
Rimini con la famiglia. Il tempo di una vasca lungo le vie
parallele al lungomare, in attesa di recarci a cena da amici. Ci
siamo, così, tuffati in mezzo ai turisti che, di ritorno dalla
spiaggia, sciamavano, in massa, costeggiando un'infinita teoria
di botteghe, bar, ristoranti, pizzerie, minimarket, fast-food,
gelaterie, pasticcerie, piadinerie. Come in ogni città turistica
che si rispetti. E Rimini non è "una", ma "la" città turistica
del lungomare di Romagna. Una città speciale, capace di non
perdere la propria identità.
Se dedico una Bussola a questo
argomento, tuttavia, non è per manifestare indignazione. Anche
se lo spettacolo mi ha dato fastidio. (Ma se infastidisce solo
me, che problema c'è?). Tanto meno per sollecitare provvedimenti
restrittivi e proibizionisti. Probabilmente non servono,
sicuramente non mi piacciono. Neppure per sollevare polemiche
sul revisionismo dilagante, sul rischio di un "nuovo fascismo" o
sul silenzio della memoria democratica. Questioni troppo
impegnative per inseguirne le tracce a partire da cavatappi,
magliette, bottiglie e sottobicchieri. (E poi non scrivo mica su
Famiglia Cristiana...).
E' probabile, peraltro, che si tratti di un fenomeno più esteso. A Rimini (città di centrosinistra) appare più evidente perché luogo ad alta intensità turistica. Non lontano dalla terra del duce. I riminesi, che evitano le vie più affollate dai turisti, forse, non ci hanno fatto caso. Comunque, nel passato, in alcuni mercati si incontravano (e ho incontrato) stand specializzati, che esponevano bottiglie fasciste, affiancate ad altre soviet-comuniste. Mussolini e Stalin vicini, in nome del vino. Poi, Stalin è scomparso. Mussolini, invece, resiste. E oggi fa concorrenza a Che Guevara (da tempo icona consumista, consumata negli accendini usa e getta e sulle copertine dei diari scolastici). Nessuno scandalo. Anzi. Proprio questo mi ha colpito maggiormente: la "normalità" (neppure la normalizzazione) del fenomeno, ormai sospeso fra ideologia popolare e senso comune, fra politica e costume. La "banalizzazione del fascismo", commercializzato come un prodotto qualsiasi. Un consumo nazionalpopolare (nazipop?). L'immagine di Benito impressa su una t-shirt - accanto a quella di James Dean, George Clooney, Ronaldinho e Homer Simpson. Un gadget. Fra una piadina, una crescia, una birra e una coca-cola. Una porchetta e un sangiovese. Nell'aria echeggia la voce di De André ... "E un errore ho commesso - dice - un errore di saggezza abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini tra i gelati e le bandiere non fate più scommesse sulla figlia del droghiere". Coro: "Ri-mi-ni".
Zona verde, acqua nera
di Claudio Pappaianni e Paolo Tessadri
Coliformi fecali in un terzo dei rubinetti delle case
campane. Idrocarburi in quelli di Vicenza. E nelle basi Usa
scattano i divieti
Ma i primi risultati ufficiali sono inquietanti: nel 30 per cento dei casi analizzati, si registra un'elevata eccedenza di contaminazione batteriologica. Valori di coliformi totali anche 50 volte superiori la norma e la presenza massiccia di coliformi fecali. Si tratta di batteri presenti nelle feci animali e umane: è come dire che dal rubinetto di casa scorre acqua di fogna. A scoprirli sono stati i test ordinati dalle Forze armate statunitensi, sempre e solo loro, che già un mese fa avevano riscontrato in sette case abitate da loro connazionali presenze 'inaccettabili' di sostanze chimiche nell'acqua da rubinetto potenzialmente cancerogene come la diossina. Allarme in caserma Ma la scorsa settimana, nella guerra dell'ambiente che i generali americani stanno combattendo in Italia per tutelare la salute dei loro militari (ed evitare richieste di risarcimenti record), si è aperto un secondo fronte. Nella contestatissima base di Vicenza gli esami hanno rilevato quantità anomale di idrocarburi. È scattato subito il divieto di bere e di cucinare con quell'acqua, disponendo la distribuzione gratuita di bottiglie di minerale per tutti i 1.200 soldati. Ma quale emergenza Napoli, Caserta, Vicenza: rubinetti avvelenati per i marines e i parà a stelle e strisce ma ottimi per gli italiani. Possibile che solo la loro acqua sia sporca e contaminata? O che i loro laboratori siano meno capaci di nostri? Nella città veneta i tecnici della municipalizzata e quelli centro idrico di Novaledo negano emergenze e puntano il dito sui pozzi che alimentano parte della base statunitense. Ricordano poi la grande falla nell'oleodotto Nato che a marzo provocò una perdita di kerosene nel terreno alle porte dell'installazione militare: ma all'epoca era stata esclusa la contaminazione dell'acqua cittadina. Potrebbe quindi trattarsi, secondo loro, di un problema di manutenzione di depositi e condotte della caserma Ederle, base dei parà della 173ma brigata appena rientrati dall'Afghanistan, che hanno subìto lavori proprio nelle scorse settimane. Ma i tubi della base sono connessi a quelli della città: anche un problema interno al fortino può allargarsi a tutto il comune. Ancora più difficile circoscrivere il problema campano. Anche perché gli esami fanno parte di una grande campagna sull'inquinamento di aria, terra e, appunto, acqua nella zona compresa tra Napoli e Caserta dove vivono circa 10 mila tra militari e civili statunitensi. Dal comando della Sesta Flotta, dopo i primi imbarazzati silenzi e le stizzite repliche alle indiscrezioni, trapelate sulla rivista 'Star & Stripes', ora arrivano conferme. Segno che il dato è più preoccupante di quanto si potesse immaginare e ci sia poco da nascondere. Le analisi batteriologiche, condotte tra lo US Naval Hospital di Napoli e i centri specializzati in Virginia, parlano di contaminazione delle acque in 48 dei primi 160 appartamenti monitorati. Può essere anche in questo caso un problema di pozzi e cisterne, ma difficile pensare che i batteri preferiscano gli americani ai napoletani. E a preoccupare di più, ora, sembrano essere i dati delle analisi chimiche commissionate a un laboratorio in Germania. Allacci abusivi I 48 'casi' riscontrati dallo studio americano riguardano una decina di comuni, perlopiù casertani: Caserta, Casal di Principe, Casapesenna, Gricignano d'Aversa, Pozzuoli, San Maria Capua Vetere, San Cipriano D'Aversa, Villa di Briano e Villa Literno. E, oltre ai cittadini statunitensi, in quell'area vivono almeno 300 mila persone, tutte potenzialmente a rischio. Dai loro rubinetti potrebbero uscire le stesse sostanze che la 'Phase One' della ricerca ha evidenziato. Ma nessuno controlla. O, almeno, chi dovrebbe garantire la qualità di quell'acqua, evidentemente non lo fa fino in fondo. Tutti dichiarano di effettuare puntuali verifiche: dal gestore del servizio (in molti dei casi in esame sono i Comuni, ndr), alle Aziende sanitarie locali, alla Regione attraverso l'Agenzia regionale per l'Ambiente. Ma, intanto, dai tubi sbuca di tutto ed è un palleggio continuo di responsabilità. L'acqua fornita da Acquacampania, società dell'Eni che gestisce l'Acquedotto della Campania Occidentale, è controllata costantemente anche grazie a uno degli impianti tecnologicamente più avanzati in Italia. C'è voluto lo studio americano per rovesciare un pentolone che nessuno aveva osato nemmeno scoperchiare: dopo un anno di emergenza rifiuti continua, il rischio sanitario in Campania è ormai reale. Diossina sprigionata dai roghi di spazzatura, moltiplicarsi di insetti e ratti, percolato che penetra nei terreni fino a inquinare la falda acquifera. Secondo dati ufficiali dell'Arpa Campania, solo il 18 percento delle acque sotterranee presenta una qualità 'elevata', a fronte di un 40 percento definita 'scarsa'. Investimenti colabrodo Questo, nonostante in Campania sul sistema integrato delle acque la Giunta Bassolino abbia investito, dal 2000 a oggi, oltre 265 milioni di euro di fondi europei e altri 270 sono previsti per i prossimi cinque anni. Soldi, i primi, gestiti senza soluzione di continuità da uomini imposti da Clemente Mastella. Almeno fino allo scorso gennaio, quando l'ultimo assessore all'Ambiente indicato da Ceppaloni, Luigi Nocera, è finito agli arresti nell'ambito dell'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere che ha decapitato il Campanile e portato alla caduta del governo Prodi. Il suo posto in giunta è stato preso da Walter Ganapini, impegnato in questi mesi quasi esclusivamente sul fronte rifiuti. Ma nulla è cambiato nella macchina amministrativa. E nemmeno nella gestione delle acque e degli appalti di manutenzione in Campania, che sembrano il vero assillo di Palazzo Santa Lucia. Più che la qualità delle acque, si bada alla quantità degli interventi. L'ultimo appena una settimana fa. Per due giorni e due notti gli operai delle ditte incaricate dalla Regione Campania hanno lavorato alla condotta DM 1300, una sorta di autostrada dell'acqua partenopea che in un anno aveva ceduto ben 52 volte, praticamente una volta a settimana. Un intervento programmato, che ha interessato una quindicina di comuni vesuviani e costretto mezzo milione di cittadini, anche nella Costiera amalfitana, a file interminabili davanti alle autobotti nelle giornate più torride dell'anno. Un mese prima era andata peggio. Il guasto alle condutture era stato improvviso e il black-out idrico inatteso. In poche ore i prezzi di taniche e bottiglie di minerale erano schizzati in l'alto come un indice di Borsa impazzito.
EVO: VITTORIA PAGATA
CARA
Maurizio Matteuzzi
Evo ha vinto, anzi stravinto. E, nel referendum revocatorio
di domenica, è stato confermato alla grande presidente della
repubblica (fu lo stesso per Hugo Chávez in Venezuela nel
2004). Ha avuto quasi il 10% in più che nel dicembre 2005,
quando si abbatté a valanga sul Palazzo Quemado di La Paz.
Il primo presidente indigeno in 500 anni di storia
boliviana. Come già in passato, la guerra sempre più
frontale dell'ambasciatore Usa a La Paz - prima del suo
avvento conosciuto semplicemente come «il viceré» e ora
costretto a tornare sulla terra -, ha finito per giovargli
anziché danneggiarlo.
Ma anche la destra «autonomista» delle regioni dell'oriente ricco di gas - Tarija - e di terre fertili - Santa Cruz -, ha vinto. Le due Bolivie contrapposte e nemiche, quella bianca dell'oriente e quella india dell'altipiano, da domenica non sono più vicine. Semmai ancor più lontane. Il «pareggio» alla lunga potrebbe rivelarsi catastrofico. E le pulsioni autonomiste, teoricamente legittime, potrebbero alla fine rivelarsi per quello che - forse - sono sempre state: prove di separatismo. I cambas dell'oriente «democratico» e capitalista per la loro strada, che è la strada della globalizzazione, i collas dell'occidente comunitario e «statalista» per un'altra strada, che è quella dell'impossibile ritorno alle glorie dei regni quechua e aymara di prima della conquista spagnola. Perdendo quelle risorse naturali - le ultime rimaste dopo il saccheggio dell'argento e dello stagno - che fanno della poverissima Bolivia uno dei paesi più ricchi del mondo. Un'ipotesi inaccettabile e assurda che potrebbe divenire drammaticamente attuale. Non solo in Bolivia. Con il referendum revocatorio Evo Morales ha messo sul tavolo la presidenza e sperato di assestare una botta secca ai governatori delle regioni ribelli, anch'essi costretti a rimettersi in gioco. Ma sia lui sia i suoi avversari di destra hanno superato la prova (tranne quello di Cochabamba). Alla fine entrambe hanno vinto, entrambe hanno perso. Ora le due Bolivie sono obbligate a cercare un'intesa che nessuna delle due vuole. Storicamente e politicamente Evo ha ragione e la destra «autonomista» ha torto. 500 anni di apartheid sociale ed economica, politica e razziale (il governatore di Santa Cruz ancora ieri ha chimato Evo «macaco»), bastano e avanzano. La «rivoluzione democratica e culturale» di cui Evo è il portabandiera è un obiettivo sacrosanto che nessuno gli può chiedere di fermare. Ma Evo dovrà dimostrare una grande capacità tattica e strategica per impedire che la destra riesca a realizzare i suoi obiettivi. Perché la destra boliviana non è sola. E può ostentare un'aura di «modernità», economica e politica, che cozza contro la «antichità» della proposta indigena e dei rigurgiti statalisti. Nel 2004 Chávez vincendo il referendum revocatorio riuscì a ingliggere un colpo da ko a un'opposizione recalcitrante e golpista, e ad aumentare il suo peso interno e internazionale. In Bolivia non è stato così. Perché se Evo ha vinto, la destra non ha perso. Se Morales dovesse cadere, qualunque fosse il modo, non cadrebbe solo la Bolivia. E non sarebbero solo «i radicali» Chávez in Venezuela e Correa in Ecuador a dover temere l'onda d'urto.
INFLAZIONE
Il salasso
quotidiano
Istat: indice dei prezzi al +4,1%. Beni ad alta
frequenza d'acquisto: +6,1%
Carlo Leone Del Bello
Confermato il dato Istat sull'inflazione: a luglio i
prezzi al consumo sono cresciuti del 4,1% rispetto allo
scorso anno e di mezzo punto percentuale rispetto a
giugno. L'aumento dei prezzi non era così sostenuto dal
1996, cioé prima delle strette monetarie imposte da
Maastricht. Tuttavia, come ben sa chi fa la spesa tutti
i giorni, i rincari più sostenuti si sono verificati per
i beni che maggiormente incidono sul bilancio quotidiano
delle famiglie. Lo dimostrano anche l'istituto di
statistica: i beni ad «alta frequenza di acquisto» sono
cresciuti del 6,1% rispetto al luglio del 2007. A
risultare più colpiti dall'inflazione, come al solito, i
percettori di reddito fisso, in particolare i
pensionati.
I responsabili dell'aumento dei prezzi sono sempre gli stessi capitoli di spesa: trasporto (+0,9% rispetto a giugno) e bollette di acqua, luce e gas (+1,5%). Sorprendentemente inferiore alla media è invece l'aumento congiunturale dei prodotti alimentari, +0,1%, anche se l'incremento annuale rimane molto alto con un +6,3%. Rimangono fermi, o quasi, i prezzi di abbigliamento e calzature, di servizi sanitari e medicinali. Unico comparto che vede scendere nettamente i prezzi medi, quello delle telecomunicazioni: -0,7% congiunturale e -3,2% tendenziale. Tra i capoluoghi italiani con i più alti tassi di inflazione ci sono Ancona e Cagliari (+0,7%). Irrisorio l'aumento mensile dei prezzi a Roma (+0,1%), che rimane anche la città dove i prezzi sono cresciuti di meno nel corso dell'ultimo anno: +3,3%. Merita una menzione l'andamento dell'inflazione «di fondo», l'equivalente dell'inflazione core calcolata negli Usa, ovvero l'aumento dei prezzi dei beni esclusi alimentari ed energetici. Anche senza questa componente «volatile», l'indice dei prezzi in Italia è cresciuto del 2,8% in un anno e dello 0,4% rispetto a giugno. Potrebbe trattarsi degli effetti di «secondo round» tanto temuti dalla Bce. La conferma e la spiegazione a ciò che gli italiani già sanno, e che cioé l'inflazione reale «sembra» più alta di quella ufficiale, viene però dall'indice dei prezzi dei beni ad alta frequenza di acquisto, calcolato dall'Istat. Questo paniere «speciale» altro non fa che analizzare gli andamenti dei prezzi dei beni acquistati almeno una volta al mese, ovvero generi alimentari, bevande alcoliche e analcoliche, tabacchi, spese per l'affitto, prodotti per la casa, carburanti, trasporti urbani, giornali e periodici, servizi di ristorazione, spese di assistenza. L'aumento di questi prezzi è stato dello 0,4% su giugno, del 6,1% su luglio del 2007 e, nonostante pesino per circa il 40% sul paniere Istat, il loro contributo all'inflazione annuale è stato del 2,35%. Praticamente, oltre la metà dell'aumento medio dei prezzi è stato causato da questo tipo di acquisti. Ovviamente, per tutti coloro i quali il peso relativo degli acquisti ad alta frequenza è maggiore, l'impatto sul reddito mensile è devastante, soprattutto se lo stipendio è fisso e ancorato a inflazioni irrealistiche quali quella programmata. Dello stesso avviso è Agostino Megale della Cgil, secondo il quale per le categorie a basso reddito, fra le quali ci sono 10 milioni di pensionati a meno di 800 euro al mese e quasi un milione di precari, l'inflazione è proprio fra il 6 e il 7%. A questo si aggiunge la mancata restituzione del fiscal drag, che aumenterà la pressione fiscale dello 0,6% nel 2008. Secondo le proiezioni effettuate da Adusbef e Federconsumatori, l'aumento dei prezzi comporterà per le famiglie una spesa annuale maggiorata di 2.182 euro in media. Se chi è abbastanza fortunato da andare in vacanza se la vede con i consistenti aumenti degli stabilimenti balneari (+8%), chi rimane cerca di modificare le abitudini di consumo, per spendere di meno riempiendo ugualmente la pancia. Secondo la Cia (Confederazione italiana agricoltori) oltre il 60% delle famiglie sta cambiando o ha già cambiato comportamento di spesa a causa del caro-alimenti. Si risparmia sul pane (-2,5% di consumi a fronte di un aumento di prezzo del 12%) magari evitando di buttarlo e congelandolo, sulla carne bovina (-3%, sostituita dal pollo +6,6%), su frutta e ortaggi (-2,6% e -2,8% rispettivamente). In controtendenza la pasta, che vede aumentare il consumo (+1,4%) nonostante gli aumenti folli (+25% annuale).
In Italia metà degli infortuni mortali sul lavoro
avviene sulle strade
Una volta su due gli autisti fermati vengono trovati con qualche irregolarità
Turni massacranti e
pochi controlli
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fronte del porco
Alla
ricerca del cibo «low cost». Crollano gli
acquisti degli italiani anche nella grande
distribuzione. La crisi avanza. Prezzi alle
stelle, le famiglie rinunciano al «lusso»
persino negli alimentari.
Alessandro Braga Del maiale, si sa, lo dice anche un vecchio adagio, non si butta via niente. Soprattutto, se è concesso il bisticcio letteral-zoologico, in tempi di vacche magre. Non meravigliano quindi gli ultimi dati sui consumi delle famiglie italiane che confermano, ancora una volta se fosse necessario, quello che si va dicendo da tempo. Ossia che nell'ormai ex Belpaese sono in moltissimi a far fatica ad arrivare a fine mese. E allora, per preservare l'incolumità di portafogli sempre meno gonfi, a fronte di costi sempre più elevati, si taglia dove si può, anche in settori una volta considerati di prima necessità. A lanciare l'allarme, ieri, le rilevazioni fatte da Iri-Infoscan, società che monitora oltre settemila punti vendita tra ipermercati, supermercati e simili. La grande distribuzione italiana, nel bimestre maggio-giugno del 2008, ha fatto registrare un calo dello 0,7% delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Era dal bimestre gennaio-febbraio del 2007 che non si assisteva a una decrescita nel settore. Crisi che colpisce, in maniera pesante, anche il settore alimentare di qualità. La denuncia arriva dalla Coldiretti, che analizza come cambia la composizione del carrello degli italiani: per risparmiare, mangiano meno carne bovina, -3%, poca frutta, a meno che non sia di stagione (-2,6%), e si buttano a capofitto sulle offerte e sulle carni considerate più abbordabili. In particolare il maiale, nelle sue parti «meno nobili», seppur succulente: braciole («Che almeno costano mediamente 6-7 euro al chilo», fa notare una massaia all'uscita di un grande supermercato), salsicce e mortadella (al pan di magùtt, il pane dei muratori, si dice a Milano). Niente fettine di vitello, né tantomeno prosciutto crudo. E manco a pensarci di riempire il carrello con i prodotti tipici regionali, come formaggi sardi, bresaola della Valtellina e simili. Un ritorno, più o meno obbligato insomma, alla cucina tradizionale dei nonni. A volare, letteralmente, le carni bianche, con la carne di pollo che segnala un vero boom con un +6,6%, in totale controtendenza con i diretti concorrenti. A patire il contraccolpo della crisi c'è anche il pane. Se ne compra meno, una famiglia tipo dimezza addirittura il suo consumo di pane quotidiano e, se proprio si deve acquistare, allora si punta su quello «povero», il casereccio, rinunciando a quelli più elaborati. Niente focaccine o pane all'olio, per capirci. Ma se l'inflazione corre e il carrello della spesa, inevitabilmente, a poco a poco si svuota, le famiglie italiane cercano stratagemmi per riuscire, nei limiti del possibile, a mantenere inalterati i loro consumi. Rinunciando ad esempio ai prodotti di marca, i brand più noti anche a causa delle martellanti campagne pubblicitarie, e acquistano prodotti simili, ad esempio i cosiddetti private label, ossia quelli che espongono il marchio del supermercato stesso. Questi ultimi infatti, contro un calo delle vendite dei prodotti di marca costante negli ultimi tre mesi (-2,7% ad aprile, -2,5% a maggio e -0,9% a giugno) registrano un continuo aumento, seppur meno velocemente rispetto ai mesi scorsi: a giugno +5,1%, contro un +10,8 del mese di maggio. A pesare sul calo dei consumi, ovviamente, il caro prezzi che, sempre secondo i dati forniti dall'indagine Iri-Infoscan, per i beni di largo consumo è schizzato al 4,6%. E, aggiungono gli analisti, fino a settembre «c'è da aspettarsi una tendenza rialzista». Immediate, le reazioni delle associaizoni di consumatori: Adusbef e Federconsumatori chiedono immediatamente iniziative concrete per sostenere il potere di acquisto delle famiglie italiane. «Simili provvedimenti - dicono - non sono più procrastinabili. Anzi, siamo già in ritardo, se non ci si muove si rischia il collasso». E preoccupato è anche Paolo Landi, di Adiconsum: «E' colpa del prezzo del petrolio - dice - mediamente una famiglia ha perso nell'ultimo anno, come potere di acquisto, circa una mensilità. Se si pensa poi a chi ha dovuto accendere un mutuo a tasso variabile, la media arriva a due mensilità». Insomma, tutti sono d'accordo, la recessione è vicina.
La morte di Bianzino non si
può archiviare»
Il gip respinge la richiesta del pm
Emanuele Giordana
Come morì Aldo Bianzino, l'ebanista di
Pietralunga entrato in perfetto stato di salute
in carcere il 12 ottobre dell'anno scorso e
uscito senza vita dalla casa circondariale di
Perugia due giorni dopo? La domanda, cui la
richiesta di archiviazione del pm Giuseppe
Pietrazzini, sembrava aver dato una risposta
definitiva con la richiesta di archiviazione,
rimbalza adesso nuovamente su una vicenda sin
dall'inizio apparsa oscura e piena di misteri.
Il gip Massimo Ricciarelli, cui diverso tempo fa
i famigliari presentarono opposizione in sede
civile, ha deciso di accogliere adesso anche
l'opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata in luglio dall'avvocato dei genitori
di Aldo - Giuseppe e Maura - e di Roberta
Radici, la compagna di Bianzino con lui
arrestata e poi rilasciata senza che nemmeno le
fosse stato detto, se non all'uscita dal
carcere, che Aldo era morto.
Si deve alla caparbietà dei famigliari dunque se il caso non si chiude in uno scaffale degli uffici giudiziari perugini e se le eccezioni sollevate dal legale, l'avvocato Massimo Zaganelli, ricostruiscono un percorso di dubbi e interrogativi non ancora sciolti che il magistrato ha evidentemente considerato validi, quantomeno a non far diventare la storia di Aldo un semplice faldone di carte polverose. La ricostruzione della parte civile mette in fila tutte le contraddizioni di quelle terribili ore a cominciare dalla mattina di domenica 14 ottobre quando Aldo è rinvenuto, inanimato, sulla branda superiore del suo letto. I suoi indumenti si trovano, ordinati, su quella inferiore. La finestra della cella è aperta seppure sia ottobre inoltrato e Aldo indossi solo una maglietta a maniche corte. Per il resto è nudo. Il corpo viene prelevato dagli agenti, trasportato subito fuori della cella e deposto sul pavimento del corridoio dell'infermeria, sita a pochi metri. Viene innalzato un lenzuolo così che gli altri detenuti nulla possono vedere. Si tenta la rianimazione, effettuando il massaggio cardiaco sul corpo inanimato. Uno dei medici dirà che «non so spiegarmi per quale motivo il detenuto sia stato portato sul pianerottolo davanti alla porta dell'infermeria ancora chiusa poiché (in altri casi) il nostro intervento avveniva direttamente in cella». Le indagini riveleranno «lesioni viscerali di indubbia natura traumatica (lacerazione del fegato) e a livello cerebrale una vasta soffusione emorragica subpiale, ritenuta al momento di origine parimenti traumatica». Ma poi le ricerche si esauriscono con l'acquisizione dei filmati estratti dalle videocamere dell'istituto di pena mentre viene aperto procedimento penale nei confronti di una guardia per omissione di soccorso. La richiesta di archiviazione per il reato di omicidio viene formulata dal pm nel febbraio scorso con la conclusione che Aldo è morto non per trauma ma per un aneurisma cerebrale; la lesione epatica viene ritenuta estranea all'evento letale facendo escludere « l'esistenza di aggressioni del Bianzino». Motivazioni «assertive e generiche» che, secondo i legali della famiglia, sono «insostenibili» e frutto di un'«istruttoria lacunosa». Valga per tutto una perizia medico legale secondo cui «la lacerazione epatica deve essere ritenuta conseguenza di un valido trauma occorso in vita e certamente non può essere ascrivibile al massaggio cardiaco, in riferimento al quale vi è prova certa che avvenne a cuore fermo». Il commento, che Roberta Radici ha affidato al quotidiano La Nazione, è lapidario: «Una scheggia di luce per il mio piccolo Rudra», il figlio di Aldo e Roberta rimasto orfano del padre a soli 13 anni. Nessuno in famiglia si è mai arreso all'archiviazione: non gli altri due figli, Aruna Prem ed Elia con la madre Gioia (che hanno presentato l'altra istanza di opposizione), né i genitori e il fratello di Aldo. Il padre, Giuseppe, domenica scorsa è salito sul palco del Goa Boa, il festival per i diritti umani organizzato dalla Tavola della pace a Genova: di fronte a 15 mila persone, convenute anche per il concerto di Manu Chao e quello di Tonino Carotone, Bianzino ha ricordato il valore anche civile della difesa dei diritti umani. Aveva rivolto un suo personale appello al giudice perché non archiviasse il caso. Appello accolto.
La verità su
Shiwashan
|
|||||||||||||||||
| I due elicotteristi rimpatriati dall’Afghanistan raccontano la loro versione | |||||||||||||||||
|
|
|
 Cosa
sia accaduto il 9 luglio nei cieli afgani di
Shiwashan, sette chilometri da Herat, da oggi non
sarà più un mistero. Perché attraverso una fonte
militare arrivano i dettagli di quella sera, i fatti
come sono descritti da chi era lì e decise di non
sparare, nonostante fosse aggredito da 'fuoco
ostile', per la presenza di civili nelle case da
dove partivano colpi di armi leggere. Cosa
sia accaduto il 9 luglio nei cieli afgani di
Shiwashan, sette chilometri da Herat, da oggi non
sarà più un mistero. Perché attraverso una fonte
militare arrivano i dettagli di quella sera, i fatti
come sono descritti da chi era lì e decise di non
sparare, nonostante fosse aggredito da 'fuoco
ostile', per la presenza di civili nelle case da
dove partivano colpi di armi leggere.
Domenico Leggiero, responsabile del
comparto Difesa dell'Osservatorio militare, è noto
per le sue battaglie a favore dei militari affetti
da patologie legate all'esposizione all'uranio
impoverito in teatri di guerra. Leggiero è in grado
di riportare la versione dei due piloti di
elicottero, protagonisti della notte del 9 luglio,
che dopo aver passato alcuni giorni all'ospedale
militare romano del Celio, sono stati rispediti
nella base del 7° Reggimento Aviazione ‘Vega’
dell’Esercito, a Rimini.
Erano due i Mangusta, in appoggio a
un'operazione medevac (evacuazione medica), con un
elicottero spagnolo che era intervenuto dopo
un'imboscata in cui erano rimasti intrappolati due
blindati italiani “Lince”. Le uniche notizie
diffuse riguardavano il rifiuto di uno dei due
Mangusta di aprire il fuoco, con il conseguente
ricovero dei piloti per sindrome da stress
post-traumatico.
 Una
lucida decisione.
Secondo la versione dei protagonisti – riportata da
Leggiero – quella sera l'intervento riguardò la
copertura dell'elicottero medico che evacuò due
soldati italiani. Ma dopo l'imboscata, avvenuta
all’estrema periferia di Herat, e durante
l’operazione di evacuazione medica dei nostri feriti
– il tenente Gabriele Rame e l’aviere Francesco
Manco – da un palazzo abitato della zona vennero
esplosi numerosi colpi di armi leggere. Il timone di
coda dell'eliambulanza venne 'sviolinato',
graffiato, senza far danni. È proprio a quel punto
che i due piloti italiani, ognuno alla cloche di un
Mangusta, hanno valutato che rispondere al fuoco con
i potenti cannoncini rotanti da 20 millimetri
avrebbe significato distruggere l’edificio
provocando sicuramente pesanti perdite tra i civili.
Quindi hanno optato per una manovra di disimpegno e
hanno fatto ritorno alla base. Il comando spagnolo
non gradì. Di lì la lamentela con il comandante
italiano ad Herat per la mancata copertura di fuoco
da parte dei Mangusta. I due piloti, convocati dal
comandante per chiarimenti, hanno spiegato di aver
lucidamente preso la decisione di non rispondere al
fuoco in accordo con le regole d’ingaggio di una
missione ufficialmente di pace, non di guerra, che
consentono di sparare se attaccati, ma solo se c’è
la ragionevole certezza di non provocare vittime
civili. Una
lucida decisione.
Secondo la versione dei protagonisti – riportata da
Leggiero – quella sera l'intervento riguardò la
copertura dell'elicottero medico che evacuò due
soldati italiani. Ma dopo l'imboscata, avvenuta
all’estrema periferia di Herat, e durante
l’operazione di evacuazione medica dei nostri feriti
– il tenente Gabriele Rame e l’aviere Francesco
Manco – da un palazzo abitato della zona vennero
esplosi numerosi colpi di armi leggere. Il timone di
coda dell'eliambulanza venne 'sviolinato',
graffiato, senza far danni. È proprio a quel punto
che i due piloti italiani, ognuno alla cloche di un
Mangusta, hanno valutato che rispondere al fuoco con
i potenti cannoncini rotanti da 20 millimetri
avrebbe significato distruggere l’edificio
provocando sicuramente pesanti perdite tra i civili.
Quindi hanno optato per una manovra di disimpegno e
hanno fatto ritorno alla base. Il comando spagnolo
non gradì. Di lì la lamentela con il comandante
italiano ad Herat per la mancata copertura di fuoco
da parte dei Mangusta. I due piloti, convocati dal
comandante per chiarimenti, hanno spiegato di aver
lucidamente preso la decisione di non rispondere al
fuoco in accordo con le regole d’ingaggio di una
missione ufficialmente di pace, non di guerra, che
consentono di sparare se attaccati, ma solo se c’è
la ragionevole certezza di non provocare vittime
civili.
Contro i due piloti non è stata
avviata alcuna procedura disciplinare: i comandi
hanno preferito rimpatriarli e ricoverarli per
alcuni giorni all’ospedale militare del Celio, dando
in pasto alla stampa la storia dello stress.
 Nessuno
stress. La questione,
come si evince dalle differenze con le versioni
ufficiali diffuse fino a oggi, è quanto mai
delicata. I due Mangusta, e non solo uno, optarono
per la manovra di disimpegno senza aprire il fuoco.
E non lo fecero degli equipaggi ‘stressati’, ma
consapevoli di fare una precisa scelta, nonostante
le raffiche dirette verso di loro. “La loro
decisione – afferma Leggiero – è stata un atto di
alto profilo etico e morale, che come pilota mi
sento di condividere al cento per cento”. Nessuno
stress. La questione,
come si evince dalle differenze con le versioni
ufficiali diffuse fino a oggi, è quanto mai
delicata. I due Mangusta, e non solo uno, optarono
per la manovra di disimpegno senza aprire il fuoco.
E non lo fecero degli equipaggi ‘stressati’, ma
consapevoli di fare una precisa scelta, nonostante
le raffiche dirette verso di loro. “La loro
decisione – afferma Leggiero – è stata un atto di
alto profilo etico e morale, che come pilota mi
sento di condividere al cento per cento”.
Il secondo punto delicato riguarda
direttamente la politica e la propaganda dello Stato
Maggiore italiano. L'immagine dei due piloti
circolata sui mezzi di informazione è quella di due
traumatizzati, quindi colpiti da una sindrome che
viene affiancata al fatto stesso di non aver voluto
aprire il fuoco. Sono più o meno sottili
accostamenti che sortiscono un effetto immediato
nella ricezione di una notizia. Dai resoconti
diretti, invece, la situazione appare ben diversa,
con una scelta che poco ha a che spartire con il
logoramento psico-fisico. Ma che risponde, invece, a
una presa di coscienza nella difficile decisione di
aprire o meno il fuoco su un palazzo abitato.
Per di più il nostro ordinamento
militare, aggiungono le nostre fonti in ambito
militare e giudiziario,
non ha previsto figure di aiuto psicologico
direttamente sul teatro di guerra.
Cosa succederà adesso ai due piloti,
ormai rientrati alla base in Italia, passando per il
Celio? L'unica certezza delle nostre fonti è che non
li attende un roseo avvenire: in campo militare – ci
dicono – queste scelte si pagano. E la vendetta è un
piatto che, in quel mondo, viene servito freddo.
|
| Cessate il fuoco |
| Il bollettino settimanale delle guerre e dei conflitti in corso n. 29 - 2008 dal 24/7/2008 al 31/07/2008 |
|
|
|
|
Nell'ultima settimana, in
tutti i Paesi in guerra, sono morte
almeno 828 persone
Iraq
Nell'ultima settimana sono morte almeno 147 persone Dall'inizio dell'anno i morti sono almeno 8343
Sri Lanka
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 208 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 5.699
Afghanistan
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 233 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 3.513
Pakistan
talebani
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 90 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 1.604
Somalia
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 28 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 859
Sudan
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 3 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 815
Turchia
Nell'ultima settimana sono morte almeno 5 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 432
Ciad
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 3 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 533
India
Nordest
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 20 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 438
Israele -
Palestina
Nell'ultima settimana sono morte almeno 10 persone Dall'inizio dell'anno i morti sono almeno 400
India
Naxaliti
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 5 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 378
Nord
Caucaso
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 10 persone
dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 353
India
Kashmir
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 12 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 317
Thailandia del sud
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 4 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 233
Colombia
Nell'ultima settimana sono morte almeno 10 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 164
Filippine
Npa
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 4 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 159
Pakistan
Balucistan
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 1 persona
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 146
Algeria questa settimana sono morte almeno 4 persone dall'inizio dell'anno i morti sono almeno 120
Nigeria
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 10 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 125
Burundi
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 2 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 100
Filippine
Abu Sayyaf/Milf
Nell'ultima settimana è morta almeno
9 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 90
Uganda
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 5 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 88
Nepal
Nell'ultima settimana è morta almeno
1 persona
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 52
Bangladesh
Nell'ultima settimana sono morte
almeno 4 persone
Dall'inizio dell'anno i morti sono
stati almeno 32
|
| Adelante, senza giudizio |
| Il Texas sta per mettere a morte un messicano, portando allo scontro Usa e Corte mondiale |
|
|
|
|
Un immigrato ispanico
reo confesso, lo stato Usa che più ricorre alla pena
capitale, il difficile rapporto tra Usa e Messico,
l'insofferenza americana verso le convenzioni
internazionali. Non potevano unirsi meglio i vari
elementi del controverso caso di José Medellin, un
messicano condannato a morte per lo stupro di gruppo
e l'omicidio di due adolescenti texane nel 1993, e
destinato a morire per iniezione letale il prossimo
5 agosto, nonostante un ordine in senso contrario
emesso dalla Corte internazionale di giustizia.
 Il
caso. L'affaire Medellin, insieme ai casi
di altri cinquanta cittadini messicani attualmente
nel braccio della morte in carceri statunitensi,
rientra in un contenzioso tra i due Paesi in atto da
anni. L'arresto di queste persone non fu notificato
ai consolati messicani negli Usa, un obbligo fissato
dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari. In passato, Washington ha riconosciuto le
violazioni del trattato internazionale e si è
scusata con le autorità messicane. Non soddisfatte,
queste hanno però portato il caso davanti alla Corte
internazionale di giustizia (Icj), che nel 2004
diede ragione a Città del Messico, ordinando ai
tribunali Usa di stabilire se la mancata
comunicazione ai consolati rendesse invalidi i
processi, dato che pregiudica il diritto alla
difesa. Dopo quella decisione, il governatore
dell'Oklahoma trasformò in ergastolo la condanna a
morte del messicano Osvaldo Torres. Il
caso. L'affaire Medellin, insieme ai casi
di altri cinquanta cittadini messicani attualmente
nel braccio della morte in carceri statunitensi,
rientra in un contenzioso tra i due Paesi in atto da
anni. L'arresto di queste persone non fu notificato
ai consolati messicani negli Usa, un obbligo fissato
dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari. In passato, Washington ha riconosciuto le
violazioni del trattato internazionale e si è
scusata con le autorità messicane. Non soddisfatte,
queste hanno però portato il caso davanti alla Corte
internazionale di giustizia (Icj), che nel 2004
diede ragione a Città del Messico, ordinando ai
tribunali Usa di stabilire se la mancata
comunicazione ai consolati rendesse invalidi i
processi, dato che pregiudica il diritto alla
difesa. Dopo quella decisione, il governatore
dell'Oklahoma trasformò in ergastolo la condanna a
morte del messicano Osvaldo Torres.
Scontro legale.
Ma il Texas ha un'idea diversa. I tribunali dello
stato hanno stabilito che il 33enne Medellin non ha
diritto a veder rivista la sua pena. Il principale
organo giudiziario delle Nazioni Unite ha però
ordinato comunque una nuova udienza per il
condannato, che vive negli Usa da quando aveva tre
anni ma non ha mai ottenuto la cittadinanza. Nello
scontro tra Texas e Icj è intervenuto il presidente
George W. Bush, che ha esortato lo stato a dare
retta alla corte dell'Onu, ma è andato incontro a un
altro rifiuto. Lo scorso marzo, la Corte Suprema
statunitense ha dato ragione al Texas, definendo non
vincolanti le decisioni dell'Icj e di Bush, che
avrebbe dovuto passare prima per il Congresso.
Un'ultima richiesta in tal senso dell'Icj, per
sospendere l'applicazione della pena a Medellin e ad
altri quattro messicani la cui data dell'esecuzione
non è ancora stata fissata, è stata respinta dal
governatore Rick Perry a metà luglio. Le famiglie
delle due vittime, ragazze di 14 e 16 anni, premono
affinché l'esecuzione si compia.
 Un
precedente scomodo. La questione preoccupa però
gli esperti legali americani, perché il mancato
rispetto delle disposizioni della Corte
internazionale di giustizia creerebbe un precedente
scomodo per qualsiasi cittadino Usa all'estero. “Gli
americani arrestati all'estero potrebbero perdere la
protezione legale dell'accesso ai consolati
statunitensi”, ha scritto di recente Lucy Reed,
presidente dell'American Society of International
Law, in una lettera al Congresso, chiedendo a
senatori e rappresentanti di intervenire. Ma a pochi
giorni dall'esecuzione, il destino di Medellin pare
segnato. Potrebbe salvarlo solo un intervento di
urgenza del Congresso che però, a pochi mesi dalle
elezioni, difficilmente vorrà mettere il dito in una
faccenda che lo farebbe percepire “debole” in
materia di lotta al crimine. Ci sarebbe anche una
mozione Medellin già presentata in aula, ma non è
stata neanche discussa. E nessun analista prevede
che verrà messa al voto nei pochi giorni che mancano
all'esecuzione. Un
precedente scomodo. La questione preoccupa però
gli esperti legali americani, perché il mancato
rispetto delle disposizioni della Corte
internazionale di giustizia creerebbe un precedente
scomodo per qualsiasi cittadino Usa all'estero. “Gli
americani arrestati all'estero potrebbero perdere la
protezione legale dell'accesso ai consolati
statunitensi”, ha scritto di recente Lucy Reed,
presidente dell'American Society of International
Law, in una lettera al Congresso, chiedendo a
senatori e rappresentanti di intervenire. Ma a pochi
giorni dall'esecuzione, il destino di Medellin pare
segnato. Potrebbe salvarlo solo un intervento di
urgenza del Congresso che però, a pochi mesi dalle
elezioni, difficilmente vorrà mettere il dito in una
faccenda che lo farebbe percepire “debole” in
materia di lotta al crimine. Ci sarebbe anche una
mozione Medellin già presentata in aula, ma non è
stata neanche discussa. E nessun analista prevede
che verrà messa al voto nei pochi giorni che mancano
all'esecuzione. |
All'ombra dei rifiuti c'è il re di Malagrotta
Uno scenario di fronte al quale l'emergenza rifiuti della Campania sembrerebbe una passeggiata tra i colori e i profumi del Golfo, mentre le immagini del Colosseo inondato dai sacchetti spopolerebbero su Internet e sui telegiornali di tutto il mondo. Così, perfino Silvio Berlusconi, il premier che ha dichiarato di aver già ripulito Napoli, sarebbe costretto ad andare in pellegrinaggio dal signor Manlio Cerroni da Pisoniano, borgo di 700 anime arrampicato sui monti Prenestini, a una cinquantina di chilometri dalla capitale.
Tutto questo per fortuna non accadrà mai, almeno finché Cerroni continuerà a comportarsi da imprenditore responsabile e avveduto. E finché la regione Lazio (nonostante le prediche e le multe minacciate da Bruxelles) consentirà alla discarica di Malagrotta di operare oltre il termine di saturazione, che dal 2005 continua provvidenzialmente a slittare. Tuttavia, lo scenario apocalittico della spazzatura che assedia il Cupolone e copre Piazza Navona aiuta a capire perché Cerroni sia diventato uno degli uomini più potenti d'Italia. Un personaggio con il quale i politici romani fanno i conti silenziosamente fin dal 1975, anno in cui si narra abbia esordito con lo smaltimento dei rifiuti del mattatoio di Testaccio, ma con il quale devono ormai misurarsi anche il governo nazionale e chiunque sia interessato alla gran corsa all'oro rappresentata dai nuovi termovalorizzatori.
Fuori dai confini laziali, l'ottavo
re di Roma continua ad essere conosciuto solo dagli addetti
ai lavori. Merito soprattutto della riservatezza con la
quale Re Manlio ha saputo costruire sulla spazzatura e sui
fanghi di scarto un impero gigantesco, capace di operare a
Brescia come in Australia, a Perugia come in Romania, in
Puglia come in Albania. E poi Francia, Brasile e Norvegia,
perché sul suo impero non tramonta mai il sole. Il tutto
senza una holding di controllo, senza una banca di
riferimento, senza una sola poltrona accettata nel mondo
della finanza o della politica.
Cerroni ha messo su un impero a ragnatela,
con decine di società che fatturano almeno 800 milioni
l'anno, ma poi lo trovi socio di riferimento solo della metà
di Malagrotta e di poco altro. Per il resto, preferisce
operare in consorzi locali dove compaiono le varie
municipalizzate dei rifiuti e dell'energia, dove è
complicatissimo capire chi comanda a termine di codici, ma
dove a mezza bocca tutti dicono che comanda sempre lui. E
dove non c'è lui ci sono le figlie (a Perugia e a Brescia) o
collaboratori legati da rapporti ultratrentennali. Secondo
stime ufficiose che circolano in ambienti bancari, l'impero
di Cerroni varrebbe oltre due miliardi. Ma non essendosi né
quotato né indebitato, sono cifre molto aleatorie.
La sua forza non è solo l'evidente potere che gli conferisce
il fatto di essere presente in mezzo mondo e di essere "il
monopolista assoluto dello smaltimento rifiuti" nei comuni
di Roma, Ciampino, Fiumicino e della Città del Vaticano
(come ha scritto nel 2004 la commissione parlamentare
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti). La sua abilità è anche
quella di non aver mai frequentato quei salotti della
capitale dove il potere romano si annusa, si struscia,
ammicca, si esibisce e alla fine si mescola in una macedonia
ricca più di veleni che di vitamine.
Al massimo 'l'Avvocato', come lo chiamano con deferenza i
suoi dipendenti senza stare tanto a sottilizzare se alla
laurea in legge sia seguita anche l'abilitazione
professionale, lo puoi incontrare a piedi per l'Eur o sul
suo Suv, mentre controlla personalmente le discariche di
Malagrotta (con i suoi 250 ettari, la più grande d'Europa) o
i terreni di Albano laziale (ai Castelli), dove tutto è
pronto per costruire un nuovo termovalorizzatore. E se gli
altri suoi nomignoli locali sono 'il Re della monnezza' o
'il Signore di Malagrotta' è solo perché giusto ai nomignoli
bisogna affidarsi.
Il suo volto non dice nulla né ai romani né agli
italiani. Nessuno lo ha mai visto fare anticamere
nei ministeri, né battere i corridoi dei palazzi regionali,
del ministero dell'Ambiente o mostrarsi in foto o in tivù.
Non rilascia interviste neppure al canale 'Roma Uno Tv', che
pure gli appartiene. Non ne ha bisogno. È così ricco che se
volesse potrebbe salvare senza fatica la Roma dai 300 e
passa milioni di debiti che soffocano il suo vecchio amico
Franco Sensi con l'ex Banca di Roma.
Ma, anche se Cerroni è un supertifoso dei giallorossi,
neppure Cesare Geronzi potrebbe mai chiederglielo sul serio
perché lui non deve nulla a nessuno. L'unica debolezza, se
proprio la si vuol chiamare tale, è quella per Pisoniano,
del quale è un benefattore riconosciuto. Tempo fa ha salvato
anche la locale squadra di pallone, ma senza impegnarsi
direttamente: pure al suo paese ha preferito mandare avanti
un giovane avvocato romano di sua fiducia. Bastavano pochi
soldi (la squadra milita in serie D), eppure li ha fatti un
po' sudare. Forse non a caso Pisoniano è dominato da un
monte di nome Guadàgnalo.
Guadagnare consensi, al centro come a destra e sinistra, non
è mai stato un problema per Cerroni. Nessuno conosce con
esattezza le sue attuali idee politiche e neppure se ne
abbia. Così si è sussurrato che fosse vicino ad Andreotti
solo perché ha fatto fortuna nella zona dove meglio regnava
il Divo Giulio, ovvero Roma e il basso Lazio. Ma tra le
poche confidenze politiche mai sfuggitegli c'è semmai quella
di una stima sconfinata per Alcide De Gasperi. Poi si è
mormorato di una sua vicinanza alla Margherita e al
centro-sinistra in generale, visto che gli impianti dove
tratta i rifiuti sono in gran parte dislocati in aree
amministrate da giunte di quel colore. Però è anche un fatto
che non ha mai avuto problemi ad andare d'accordo con
Francesco Storace, esattamente come non ne ha con Piero
Marrazzo e con chiunque ne prenderà il posto alla regione
Lazio nel 2010.
Pare che il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, non lo ami
particolarmente, come neppure il neosenatore del Pdl
Giuseppe Ciarrapico, che con i suoi giornali si diverte a
punzecchiarlo. Ma anche nel centrodestra riconoscono
a 'Re Manlio' equidistanza e professionalità.
Certo, si potrebbe osservare che se nel Lazio la raccolta
differenziata rimane a livelli da ridere (più o meno il 15
per cento), una qualche responsabilità l'avrà anche Cerroni.
Ma a chi a quattr'occhi gli fa notare la faccenda, lui
risponde con due dati di fatto e una cifra tutta sua: il
gruppo da trent'anni smaltisce tutto quello che la città gli
chiede di smaltire e applica tariffe tra le più economiche
d'Italia "grazie alle quali Roma ha risparmiato negli anni
oltre un miliardo". Intanto, Cerroni guarda al futuro: tanto
che sta già investendo milioni nei termovalorizzatori di
domani. Perché i rifiuti (e i politici) passano, Re Manlio
no.
1 agosto
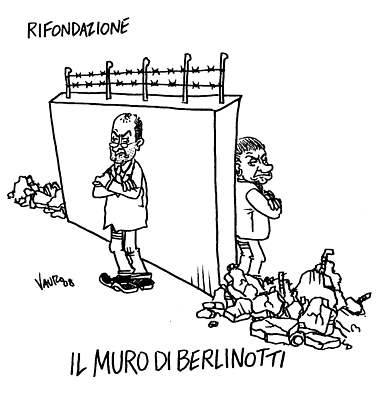
Piccole vittime senza nome
Due bambini crivellati a un checkpoint della Nato
Non sappiamo i nomi dei due bambini
afgani uccisi domenica dalle raffiche di mitra dei soldati della
Nato – i morti stranieri non meritano tale umana attenzione.
Sappiamo solo che domenica si trovavano a Kandahar, a bordo di
un’automobile che non si è fermata subito all’alt di un checkpoint
Isaf. I militari, per ragioni di sicurezza, hanno aperto il fuoco. I
due bambini sono stati crivellati di colpi e sono morti dissanguati.
Ferito gravemente il guidatore.
Il giorno prima, nella vicina provincia di Helmand, quattro civili
avevano perso la vita nella stessa identica maniera, tre rimangono
feriti.
Nelle stesse ore, altri tre civili erano morti sotto un
bombardamento dell’artiglieria Usa nella provincia orientale di
Paktika, mentre nove agenti di polizia afgani erano stati uccisi
“per errore” in un bombardamento aereo statunitense nella provincia
occidentale di Farah, sotto comando italiano.
Escalation di stragi. Quest’anno il numero di civili afgani
uccisi dalle forze Nato ha registrato una drammatica impennata, con
“incidenti” ormai quotidiani e sempre più sanguinosi. Tra giugno e
luglio si sono verificate delle vere e proprie stragi. Come quella
del 6 luglio, quando i caccia della Nato hanno bombardato un corteo
nuziale sulle montagne della provincia di Nangarhar, ammazzando
quarantadue donne e bambini, tra cui la giovanissima sposa, una
ragazzina di nome Ruhmina.
Solo due giorni prima, ventidue civili sono rimasti uccisi in un
bombardamento aereo Usa nella provincia orientale del Nuristan. Il
governatore provinciale che ha denunciato il massacro è stato
destituito pochi giorni dopo da Karzai.
Il 10 di giugno, trentatré civili sono morti sotto le bombe
sganciate dai caccia statunitensi su un villaggio della provincia di
Paktika.
Piccole vittime. Dei tanti – impuniti – crimini di guerra
commessi dagli Stati Uniti e dalla Nato in Afghanistan, quelli
contro i bambini sono certamente i più odiosi.
Lo scorso 21 marzo, il nostro Venerdì Santo, le bombe Nato sganciate
su un villaggio nella provincia centrale di Uruzgan uccisero e
ustionarono diversi bambini. Altri ne morirono dopo il ricovero
all’ospedale di Emergency a Lashkargah.
Nella stessa clinica pochi giorni prima era stata ricoverata una
donna, Halima, che aveva appena perso i suoi due bambini, uccisi
dalla mitragliatrice di un elicottero Apache assieme ad altri dodici
suoi familiari nel villaggio di Haydarabad, in provincia di Helmand.
Tornando indietro negli anni, fino alle stragi del dicembre 2003 a
Hutala e Gardez, l’elenco degli episodi che hanno visto la morte di
bambini afgani per mano delle truppe Usa e Nato è lunghissimo, e
dovrebbe far riflettere.
Enrico Piovesana
Roma, chiude l'ospedale dei poveri
Cura migranti e precari, ma il decreto taglia Ici uccide l'Inmp
«Riusciremo a proseguire le nostre attività fino ad ottobre, poi saremo costretti a chiudere». È un'altra conseguenza del decreto taglia Ici: la chiusura dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp). Inaugurato solo nel gennaio scorso come fiore all'occhiello della sanità pubblica italiana alla presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l'Inmp ha raccolto l'esperienza lunga 25 anni del prestigioso ospedale San Gallicano di Roma. Qui, nel cuore di Trastevere, l'Inmp è diventato il punto di riferimento delle fasce più deboli e povere della popolazione, come immigrati e anziani ma anche, in misura sempre più crescente, giovani disoccupati e precari. «Solo nell'ultimo anno - racconta il direttore Aldo Morrone - abbiamo dato assistenza a 20.000 persone, di cui il 10% bambini. Immigrati, ma anche, e sempre di più, cittadini italiani con redditi bassi, circa il 40% dei nostri pazienti. Sono pensionati, ma anche tantissimi giovani precari: come ad esempio i precari dei call-center che non hanno i mezzi per rivolgersi altrove». Talmente importante il lavoro dell'Inmp, che nel giro di pochi mesi ha aperto centri regionali di riferimento anche in Sicilia e in Puglia. Il decreto taglia Ici ha cancellato i 20 milioni di finanziamento stanziati dal precedente ministro della salute Livia Turco per il biennio 2008-2009, mentre nel 2007 l'istituto aveva potuto usufruire di 5 milioni di euro. Ma Morrone, che spiega come l'assistenza alle donne immigrate aveva , per esempio, fatto ridurre il numero di aborti, non molla: «Ho scritto a tutti, da Berlusconi a Tremonti e Letta: nessuna risposta salvo che da parte del sottosegretario alla salute Eugenia Roccella che ha detto di apprezzare la nostra attività ma il bilancio impone la cancellazione dei fondi. Spero non ci siano elementi di xenofobia in tale decisione e lancio un appello a governo e Parlamento».
Aiuti allo sviluppo, indietro come i gamberi
La Finanziaria taglia 170 milioni di euro per la cooperazione internazionale
Indietro come i gamberi. L'Italia
diminuisce ancora la quota degli aiuti allo sviluppo. La retromarcia
è stata innestata la settimana scorsa, quando la Camera dei Deputati
ha approvato un taglio di 170 milioni di euro nel Decreto di
programmazione economica e finanziaria (Dpef).
Al di sotto delle aspettative. Con la misura, conentuta
nell'articolo 60, comma 11 del disegno di legge, nel triennio
2009-2011 (dopo il passaggio in Senato) si diminuirà, anzichè
aumentare come previsto dagli obiettivi fisssati dall'Unione Europea
e dalle Nazioni Unite, la percentuale di prodotto interno lordo
destinata ad aiutare i Paesi poveri a migliorare la loro crescita.
L'Italia tira a fondo l'Europa, confermandosi il fanalino di coda
per allocazioni alla cooperazione internazionale: solo lo 0,19 del
Pil. Secondo quanto calcolato dall ong Oxfam-Ucodep, per rispettare
gli impegni sottoscritti in varie sedi internazionali, l'Italia
dovrebbe stanziare 6,403 miliardi di euro entro il 2010, pari allo
0,51 percento del Pil (112 euro per ogni abitante). Meno della metà
di quanto gli italiani spendono in calzature (260 per abitante),
barbiere e parrucchiere (185 euro) o acque minerali e bibite (127
euro). Avendo stanziato finora 2,471 miliardi di euro, entro il 2010
i fondi per lo sviluppo dovrebbero ammontare a 2,932 miliardi di
euro. "Ci auguriamo che il governo stanzi nuovi fondi per rispettare
gli impegni" esorta Farida Bena, responsabile ufficio campagne dell'Oxfam-Ucodep.
 Pochi
spiccioli. Il primo ministro Silvio Berlusconi ha annunciato al
G8 giapponese che l'Italia, che ospiterà il summit il prossimo anno,
stanzierà 1,57 miliardi per la salute globale nell'arco di cinque
anni, ma non è ancora chiaro a quali risorse attingere per
assicurare tale somma. Ciò che è certo è che dei quasi tre miliardi
di euro del 2007, solo 71 milioni sono transitati alle
organizzazioni non governative. Mancando una comunicazione
trasparente da parte del governo, per verificare gli stanziamenti
reali occorre fare come ha fatto l'Ocse (Organizzazione europea per
la cooperazione e lo sviluppo), che ogni anno pubblica un rapporto
sulla cooperazione italiana. In quello del 2006 (dove il totale era
di 2,3 miliardi di euro) risultava che un miliardo è 'virtuale',
riferendosi alla cancellazione del debito. Ottocento milioni sono
andati alla Commissione europea come contributo annuale. La cifra
che l'Italia ha investito direttamente in cooperazione è stata di
461 milioni. Pochi spiccioli alle ong, e il resto 'spalmato' tra
varie istituzioni internazionali, tra cui Banca mondiale, banche
regionali di sviluppo, agenzie delle Nazioni Unite o governi dei
Paesi destinatari dell'aiuto.
Pochi
spiccioli. Il primo ministro Silvio Berlusconi ha annunciato al
G8 giapponese che l'Italia, che ospiterà il summit il prossimo anno,
stanzierà 1,57 miliardi per la salute globale nell'arco di cinque
anni, ma non è ancora chiaro a quali risorse attingere per
assicurare tale somma. Ciò che è certo è che dei quasi tre miliardi
di euro del 2007, solo 71 milioni sono transitati alle
organizzazioni non governative. Mancando una comunicazione
trasparente da parte del governo, per verificare gli stanziamenti
reali occorre fare come ha fatto l'Ocse (Organizzazione europea per
la cooperazione e lo sviluppo), che ogni anno pubblica un rapporto
sulla cooperazione italiana. In quello del 2006 (dove il totale era
di 2,3 miliardi di euro) risultava che un miliardo è 'virtuale',
riferendosi alla cancellazione del debito. Ottocento milioni sono
andati alla Commissione europea come contributo annuale. La cifra
che l'Italia ha investito direttamente in cooperazione è stata di
461 milioni. Pochi spiccioli alle ong, e il resto 'spalmato' tra
varie istituzioni internazionali, tra cui Banca mondiale, banche
regionali di sviluppo, agenzie delle Nazioni Unite o governi dei
Paesi destinatari dell'aiuto.
L'esperto. Abbiamo chiesto a Sergio Marelli, presidente
dell'associazione delle Ong italiane, una valutazione sui tagli agli
aiuti. "E' un segnale che esprime un forte allarme. Non solo fa
sprofondare l'Italia in fondo alla media europea, ma soprattutto
disattende gli impegni formali che il nostro Paese ha sottoscritto
con la comunità internazionale".
Quali sono i Paesi più virtuosi in Europa?
Quelli che hanno già superato la soglia dello 0,7 precento indicata
dalle Nazioni Unite come necessaria per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo del millennio: Svezia, Olanda e Lussemburgo.
Noi risultiamo lontani anche da quei Paesi di fascia media che, pur
non raggiungendo gli obiettivi, hanno sviluppato politiche reali di
investimento, come la Spagna, un Paese che potremmo considerare
accomunabile all'Italia, in termini economici, che ha raddoppiato i
fondi per la cooperazione internazionale.
Quali strumenti si possono adottare per migliorare la situazione,
a quali fonti 'alternative' attingere per aumentare gli
stanziamenti?
Lo 0,7 percento è solo una parte del problema. Ma non è l'unico. C'è
la questione di come vengono spesi questi soldi. A settembre, ad
Accra, mi recherò a un'imporante conferenza internazionale delle
Nazioni Unite dove verrà discussa la cosiddetta qualità degli aiuti
e la loro efficacia. Anche qui l'Italia non brilla nello scenario
internzionale. Pensiamo all''aiuto allegato', ovvero l'erogazioni di
aiuti ai Paesi poveri solo a condizione che le commesse e i
fornitori siano di provenienza del Paese donatore. L'Italia registra
le percentuali più alte d'Europa, perchè al netto della
cancellazione del debito, i due terzi delle risorse allocate
dall'Italia soggiacciono a questo meccanismo. Ancora: per i servizi
fondamentali si era deciso alla conferenza di Copenhagen che il 20
percento delle risorse dovessero andare a educazione, sanita ecc...
L'Italia è al di sotto del 5 percento. Infine, il governo potrebbe
incentivare l'intervento del privato sociale, delle ong, con misure
concrete. Per esempio la defiscalizzazione dei volontari, che sono
paradossalmente considerati soggetti d'imposta. Il rimborso che
viene loro erogato è soggetto a tassazione come se fossero dei
lavoratori dipendenti. Poi si dovrebbe rendere più efficace e snello
il meccanismo del 5 per mille, oppure investire le tasse di scopo,
come la carbon tax, nello sviluppo. Infine, ed è forse la causa
principale del disequilibrio a livello mondiale (e io penso anche
dell'impennata dei prezzi alimentari), i fenomeni speculativi
internazionali, anche quelli andrebbero tassati. C'è qualcuno che
sta giocando sui mercati, a danno dei più deboli e dei più poveri.
L'instabilità di borsa generata da questi fenomeni a noi toglie
qualche spicciolo dalle tasche, mentre sulle economie fragili dei
Paesi in via di sviluppo ha un impatto devastante.
Luca Galassi
Poveri nel mirino. Preti e casalinghe senza assegni sociali
Carlo Lania
ROMA
A rischio sono le fasce più deboli
della popolazione, quelle che già oggi faticano ad arrivare alla
fine del mese. Casalinghe, pensionati con il minimo dei contributi,
ma anche sacerdoti, suore e immigrati. Tutte persone che legano la
propria sopravvivenza all'assegno sociale percepito ogni mese, messo
oggi pesantemente in pericolo dal decreto legge sulla finanziaria
del governo Berlusconi che, restringendo i requisiti necessari per
vedersi riconsciuto il sussidio, colpisce duramente proprio chi ha
più bisogno. «Se la norma sugli assegni sociali non sarà modificata
in Senato, ci troveremo di fronte alla distruzione del nostro
sistema assistenziale», denuncia Morena Piccinini, segretaria
confederale della Cgil. E insieme ai sindacati protestano anche i
partiti di opposizione e le associazioni, dalle Acli alla
Federcasalinghe. Al punto che in serata il ministro del Welfare
Sacconi è costretto a intervenire promettendo di correggere la norma
incriminata nel futuro ddl sulla manovra che verrà discusso nei
prossimi mesi.
Per essere un governo che si vanta di mettere in atto politiche di
sinistra, come afferma Berlusconi, non c'è davvero male. Oggi
l'assegno sociale di 380 euro viene riconosciuto agli
ultrasessantacinquenni che, non avendo contributi, non hanno diritto
alla pensione. Norma che però viene cambiata sostanziamente e più
volte dal decreto legge. L'ansia xenofa della maggioranza punta
infatti ad escludere gli immigrati dal beneficio attraverso una
serie di emendamenti che, oltre all'età minima di 65 anni,
introducono un criterio nuovo, legato questa volta al reddito.
L'ultima versione dell'articolo spiega infatti che ha diritto al
sussidio solo chi ha lavorato legalmente - e quindi versato i
contributi - per almeno dieci anni in Italia e con un salario pari
almeno all'ammontare del reddito sociale. Una condizione che
ovviamente non esclude solo gli immigrati, ma soprattutto una grossa
fetta di italiani.
Tra i primi a protestare ci sono proprio infatti le casalinghe, a
lungo corteggiate dal premier Berlusconi in tempo di campagna
elettorale. «Se c'è una categoria che ha diritto all'assegno è
proprio quella della calinghe, che dopo aver dedicato la vita alla
famiglia si ritrovano senza reddito. La povertà è donna», dice
Federica Rossi Gasparrini, presidente dei Federcasalinghe, che non
rinuncia a una sottacata polemica: «E' paradossale - dice infatti -
che le casalinghe vengano penalizzate proprio dal governo che hanno
votato». «Si tratta di una modifica maldestra oltre che ingiusta»,
fanno eco le Acli, mentre per il Pd Luigi Bobba «con un colpo di
mano notturno, la maggioranza ha cancellato di fatto 800 mila
assegni sociali». D'accordo sulla necessità di rimettere mano
all'articolo anche il presidente della commissione Lavoro della
Camera Giuliano Cazzola: «Stando al formulazione attuale - ammette -
l'assegno cambia natura e non sarà più percepito neanche da tanti
cittadini italiani».
E' bravo, mandiamolo via
di Daniela Minerva
Aveva messo le briglie alle aziende. Imponendo prezzi più bassi. Così Nello Martini, direttore dell’Agenzia del farmaco, è stato licenziato. E ora gli scienziati insorgono
Troppo potere in una sola persona: è
questo il commento di molti addetti ai lavori alla notizia del
licenziamento di Nello Martini dalla direzione generale dell'Aifa,
l'agenzia preposta all'autorizzazione e commercializzazione dei
farmaci in Italia, e quindi a gestire un business da 17 miliardi di
euro, di cui 16 per la sola parte pubblica. Per come è congegnata l'Aifa,
e per come è fatto Martini, questa fetta della torta negli ultimi
quattro anni è stata nelle mani dei tecnici dell'agenzia, che hanno
deciso tutto, dal tipo di farmaci in vendita al prezzo.
Oggi a dirigerla è Guido Rasi, professore di microbiologia,
consigliere di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità, in
quota ad An. E il governo si avvia a una "riorganizzazione"
dell'agenzia, con una divisione delle competenze che molti chiamano
smantellamento. Troppo potere, in una sola persona senza un definito
colore politico e in un solo organismo tecnico. Sulla carta, però,
Nello Martini è caduto sotto i colpi dell'inchiesta del giudice
torinese Raffaele Guariniello che, nel maggio scorso, ha ipotizzato
il reato di corruzione per Pasqualino Rossi e Antonella Bove,
funzionari dell'Aifa, e per sei lobbisti incaricati da diverse
aziende farmaceutiche di ammorbidire i funzionari dell'agenzia. E ha
accusato Martini di «disastro colposo» per aver tardato a aggiornare
22 foglietti illustrativi sui possibili effetti collaterali dei
farmaci. Ma l'accusa sembra flebile alla luce del parere, che
"L'espresso" è in grado di rivelare, redatto per il collegio di
difesa di Martini da nove esperti tra i più autorevoli d'Italia:
cinque farmacologi (Montanaro, Tognoni, De Ponti, Caputi,
Tagliamonte) e quattro clinici (Pagliaro, Del Favero, Bobbio,
Brignoli). Gli scienziati hanno concluso che l'aggiornamento dei 22
foglietti era «spesso solo di riformulazione stilistica».
E negano che i ritardi «abbiano costituito un pericolo per la salute
pubblica ». In particolare, scrivono gli esperti: «Le valutazioni
della professoressa Adriana Ceci (la farmacologa perito di parte
dell'accusa, ndr) rilevano una mancata padronanza dei princìpi alla
base della valutazione del profilo rischio-beneficio dei farmaci.
Ella sembra ritenere che la menzione degli effetti indesiderati dei
farmaci in una data forma piuttosto che in un'altra, formalmente
diversa ma identica nel significato, possa scongiurarne l'eventuale
comparsa».
Non solo, aggiungono: «Adriana Ceci, nella sua perizia, giunge a
argomentazioni e valutazioni sull'organizzazione complessiva dell'Aifa
e della direzione generale, andando oltre il mandato ricevuto e
rivelando un'animosità che non sembra compatibile con l'imparzialità
propria del consulente d'ufficio e compromette gravemente la
validità dell'impianto complessivo della relazione». Periti di
parte, si dirà. Ma a confermare il giudizio complessivo è persino la
commissione convocata dallo stesso ministro del Welfare e della
Salute che ha destituito Martini, Maurizio Sacconi, per decidere se
è in atto il "disastro colposo", che ha deliberato: pericoli non ce
ne sono per nessuno.
Così, come un mantra, ritorna quel «troppo potere in una sola
persona», a suggerire che l'inchiesta di Guariniello, meritoria
nell'individuare alcune mele marce dentro l'Aifa, ha finito per dare
l'occasione che tutti aspettavano da anni. Levare di mezzo Martini,
il ras dell'Agenzia, lo schivo veronese che nessuno ha mai
incontrato in nessun salotto, il più bipartisan dei gran commis,
l'amico di Rosy Bindi che Girolamo Sirchia ha nominato all'Aifa. Ma,
nei fatti, l'uomo che ha tagliato i prezzi dei farmaci del 15 per
cento in quattro anni (l'Aifa è nata nel 2004). E che ha costretto i
lobbisti di Big pharma a ore di anticamera per entrare nella sala
delle negoziazioni, l'incubo degli uomini delle aziende, dove, a
colpi di studi clinici, di dati epidemiologici, ma anche di
blandizie e minacce, le due parti arrivavano a definire il prezzo di
un farmaco; sempre troppo basso e frutto di intollerabili aut aut di
Martini, a sentire i lobbisti. Che poi salivano e scendevano col
cappello in mano le scale di via della Sierra Nevada, per avere
informazioni sulle registrazioni, sugli iter, su tutto, insomma.
Perché i funzionari erano blindatissimi e per sapere a che punto
erano le procedure, i controlli e le autorizzazioni, per avere delle
indiscrezione sulla linea che intendeva tenere Martini nelle
negoziazioni, gli uomini delle industrie erano costretti a decine di
telefonate e a dispensare sorrisi, inviti a pranzo, come anche, a
sentire il giudice Guariniello, regalini a Rossi.
L'Agenzia di Martini era come un bunker dove la stragrande
maggioranza delle decisioni passava sul tavolo del direttore. Il
comandante ombroso che sorrideva a tutti, ma riceveva solo chi
pareva a lui, ovvero chi dava garanzie di abbassare i prezzi e la
cresta. E la cresta le aziende in questi anni l'hanno abbassata:
«Martini non lo riceve, » si sussurrava Da sinistra: l'ex capo dell'Aifa,
Nello Martini; il ministro del Welfare Maurizio Sacconi; due fasi
del processo produttivo in un'industria farmaceutica di questo o
quel manager farmaceutico, e subito le nuvole si addensavano sulla
sua testa. E le case madri di New York o Londra si rabbuiavano: che
razza di lobbista sei se Martini non ti riceve? È stato come
assistere a un match durato anni, con le aziende da una parte e il
gran commis dall'altra.
Il ministro del Welfare Maurizio
Sacconi
Impegnato a mettere ordine nel
delirante mercato dei farmaci italiano, frutto di una storia e di un
sistema che hanno spinto duplicazioni e sprechi per anni. E dove
raramente i numeri della diffusione di una malattia coincidono con
quelli dei farmaci per curarla, a dimostrare inequivocabilmente che
molti prendono medicine non necessarie che lo Stato paga.
Impossibile controllare fino in fondo il rapporto tra medici di
base, che prescrivono le medicine, e gli uomini delle aziende, che
li convincono a prescrivere. E così, nella Finanziaria 2007, compare
il pugno duro di Martini: da oggi sarà l'Aifa a decidere quanto può
fatturare un'azienda, assegnandole un budget complessivo basato sul
fatturato dell'anno precedente più un incremento fisiologico. Con
una clausola di questo genere l'intera macchina del marketing
subisce un colpo durissimo.
Non solo: a mettere le briglie a un'altra voce discutibile dei
bilanci farmaceutici arriva, nei mesi scorsi, l'algoritmo per
definire esattamente cosa rende un farmaco davvero innovativo, e
quindi meritorio di prezzi più alti e accesso al mercato. Spiega
Montanaro, lo scienziato che lo ha messo a punto: «Per la prima
volta si è definito con esattezza un metodo, condiviso con
l'industria, per decidere quali farmaci rappresentano una vera
innovazione terapeutica. E questo ci permette di mettere a
disposizioni dei pazienti medicine davvero utili, scremandole dalle
tante novità che arrivano sul mercato e sono per lo più innovazioni
di marketing». Insomma, tutti reputano grandi onori all'Aifa,
governo e industriali in testa. E allora, molti si chiedono se i
regalini presi da Rossi (una finestra, un mobile, un migliaio di
euro in contanti) e altre furfanterie riscontrate dagli
investigatori ma senza un qualche impatto sulla salute pubblica,
come rileva la commissione del ministro Sacconi, siano sufficienti a
giustificare il licenziamento di Martini e lo smantellamento
dell'Agenzia. Ma l'occasione è ghiotta e irripetibile.
Perché Martini sembrava inamovibile: weltanschauung democristiana,
grande diplomatico, invisibile e onnipresente; il Gianni Letta della
sanità, come è chiamato, ha bastonato gli industriali, accentrato
tutti i poteri nelle sue mani creandosi non pochi nemici interni,
imposto agli italiani di usare i farmaci generici che non piacciono
a nessuno. Eppure ha costruito una rete bipartisan di amicizie
politiche solidissime che l'ha tenuto in sella per anni, a
prescindere dai governi in carica. E con lui in sella l'operazione
annunciata di fare a pezzi l'Aifa sarebbe difficilmente andata in
porto.
Il sottosegretario Ferruccio Fazio ha detto che l'Agenzia sarà
organizzata diversamente, anche «attraverso una chiara suddivisione
dei compiti e delle responsabilità». Una suddivisione dei poteri,
insomma. Più poltrone che contano, a gestire settori milionari. Più
potere per i partiti che piazzeranno i loro uomini. Ma in molti si
chiedono se con tanti piccoli ras in azione non si moltiplichino i
rischi di corruzione che in questo settore sono sempre in agguato.
E, in sintesi, ciò che sfugge alla comprensione dell'opinione
pubblica è: se l'Aifa ha abbassato i prezzi, garantito i farmaci
utili, e limitato a episodi risibili la corruzione, perché cambiare?
Troppo lunghi i tempi di registrazione, è l'accusa degli
industriali, del governo (nelle parole di Fazio) e di molte
associazioni di consumatori. Ma c'è chi, come il farmacologo Silvio
Garattini, non manca di ripetere a ogni occasione che più lunghi
sono i tempi, maggiori sono le garanzie che un farmaco non abbia
effetti collaterali disastrosi e sia davvero utile. E qualcosa di
vero nelle sue parole ci deve essere se gli americani, di fronte
agli scandali che hanno travolto la loro agenzia, la Fda, accusata
di aver licenziato troppo rapidamente delle medicine che poi hanno
ucciso, ora fanno marcia indietro e stanno allungando le procedure,
chiedendo dossier più accurati e più accurate sperimentazioni. Ma
certo le industrie non ne sono contente.
![]()
Mesi precedenti
> Giugno
> Maggio
Anni precedenti
![]()


 Naturalmente
il governo non vedrà alcun legame tra il rilancio
dell’azione terrorista e la politica che ha permesso
al terrorismo di recuperare i suoi mezzi tecnici e
finanziari, di rinforzare i suoi effettivi e che ha
permesso ai suoi padrini islamisti di rifarsi una
verginità politica. Eppure la relazione di causa ed
effetto è di evidenza eclatante: privilegiando la
pratica dell’accordo a quella dell’autodifesa, lo
Stato ha sostituito un’atmosfera di permissività
allo slancio di resistenza. Il terrorismo islamista,
come si vede, non si è fatto pregare per sfruttare
l’evoluzione politica e psicologica in suo favore.
Naturalmente
il governo non vedrà alcun legame tra il rilancio
dell’azione terrorista e la politica che ha permesso
al terrorismo di recuperare i suoi mezzi tecnici e
finanziari, di rinforzare i suoi effettivi e che ha
permesso ai suoi padrini islamisti di rifarsi una
verginità politica. Eppure la relazione di causa ed
effetto è di evidenza eclatante: privilegiando la
pratica dell’accordo a quella dell’autodifesa, lo
Stato ha sostituito un’atmosfera di permissività
allo slancio di resistenza. Il terrorismo islamista,
come si vede, non si è fatto pregare per sfruttare
l’evoluzione politica e psicologica in suo favore.
 Il
terrorista immunizzato e ricompensato, di un
analfabetismo notorio almeno quanto il suo talento
criminale, trova da qualche giorno spazio nella
stampa per diffondere le sue “rivelazioni” e le sue
“riflessioni”. Il generale Nezzar risponde, a sua
volta, facendo delle precisazioni aneddotiche la cui
futilità è pari solo alla gravità del fatto che sia
possibile un tale téte-à-téte.
Il
terrorista immunizzato e ricompensato, di un
analfabetismo notorio almeno quanto il suo talento
criminale, trova da qualche giorno spazio nella
stampa per diffondere le sue “rivelazioni” e le sue
“riflessioni”. Il generale Nezzar risponde, a sua
volta, facendo delle precisazioni aneddotiche la cui
futilità è pari solo alla gravità del fatto che sia
possibile un tale téte-à-téte.  La
debolezza degli alleati. Gli Stati Uniti,
con Bush ormai a fine corsa e le elezioni in vista,
non hanno la forza politica di dare una svolta
militare al conflitto, disimpegnandosi decisamente
dal fronte iracheno per impegnarsi su quello afgano.
Gli alleati della Nato, tranne la Francia di Sarkozy,
hanno chiaramente dimostrato di non avere alcuna
intenzione di farsi carico di questa guerra: anche
Gran Bretagna e Canada, i due paesi che finora hanno
dato di più sul fronte afgano, mostrano segni di
stanchezza. Il risultato, sul terreno, è la sempre
più evidente incapacità dei
La
debolezza degli alleati. Gli Stati Uniti,
con Bush ormai a fine corsa e le elezioni in vista,
non hanno la forza politica di dare una svolta
militare al conflitto, disimpegnandosi decisamente
dal fronte iracheno per impegnarsi su quello afgano.
Gli alleati della Nato, tranne la Francia di Sarkozy,
hanno chiaramente dimostrato di non avere alcuna
intenzione di farsi carico di questa guerra: anche
Gran Bretagna e Canada, i due paesi che finora hanno
dato di più sul fronte afgano, mostrano segni di
stanchezza. Il risultato, sul terreno, è la sempre
più evidente incapacità dei
 La
retrovia pachistana. A peggiorare
drasticamente la situazione, a tutto vantaggio dei
talebani, è intervenuta negli ultimi mesi la crisi
politica pachistana. L'uscita di scena del generale
Musharraf, che negli anni passati aveva tenuto
militarmente impegnati i talebani rifugiati nelle
Aree Tribali pachistane, ha permesso a questi ultimi
di usufruire di una tregua che ha consentito loro di
riorganizzarsi e di concentrarsi totalmente sul
fronte afgano, portando la guerra fino alle porte di
Kabul. Adesso è nella retrovia pachistana che gli
Stati Uniti si giocano l’esito della guerra in
Afghanistan, spingendo l’esercito di Islamabad a
reimpegnare i talebani nelle Aree Tribali, dove
infatti da due settimane il generale pachistano
Kyani ha scatenato una nuova offensiva, che ha già
provocato cinquecento morti e 200mila sfollati.
La
retrovia pachistana. A peggiorare
drasticamente la situazione, a tutto vantaggio dei
talebani, è intervenuta negli ultimi mesi la crisi
politica pachistana. L'uscita di scena del generale
Musharraf, che negli anni passati aveva tenuto
militarmente impegnati i talebani rifugiati nelle
Aree Tribali pachistane, ha permesso a questi ultimi
di usufruire di una tregua che ha consentito loro di
riorganizzarsi e di concentrarsi totalmente sul
fronte afgano, portando la guerra fino alle porte di
Kabul. Adesso è nella retrovia pachistana che gli
Stati Uniti si giocano l’esito della guerra in
Afghanistan, spingendo l’esercito di Islamabad a
reimpegnare i talebani nelle Aree Tribali, dove
infatti da due settimane il generale pachistano
Kyani ha scatenato una nuova offensiva, che ha già
provocato cinquecento morti e 200mila sfollati.  I
fatti. Al centro della questione
fondamentalmente ci sono due persone: Evo Morales,
presidente indigeno e il prefetto della regione di
Santa Cruz, la più ricca del Paese, l'agguerrito
Ruben Costas. Contrario a ogni decisione governativa
in materia di economia nazionale, Costas ha sfidato
più volte Morales chiamando la popolazione ad
esprimersi per mezzo di votazioni sull'autonomia
regionale. Non solo. Costas ha lanciato il guanto
della sfida a Morales mettendo da parte il capo
della polizia della regione, uomo voluto dal
governo. Inoltre, ultima delle sue azioni, ha
indetto per oggi un nuovo sciopero generale, con
relativo blocco stradale. Dunque dalla mezzanotte di
oggi tre dipartimenti (Pando, Beni e Santa Cruz) si
fermeranno, le strade saranno bloccate e il traffico
su ruota, il più importante del Paese, probabilmente
verrà paralizzato. I leader dei dipartimenti di
Tarija e Chuquisasca, invece, decideranno solo oggi
se aggregarsi alle proteste o definire nuove misure
di lotta.
I
fatti. Al centro della questione
fondamentalmente ci sono due persone: Evo Morales,
presidente indigeno e il prefetto della regione di
Santa Cruz, la più ricca del Paese, l'agguerrito
Ruben Costas. Contrario a ogni decisione governativa
in materia di economia nazionale, Costas ha sfidato
più volte Morales chiamando la popolazione ad
esprimersi per mezzo di votazioni sull'autonomia
regionale. Non solo. Costas ha lanciato il guanto
della sfida a Morales mettendo da parte il capo
della polizia della regione, uomo voluto dal
governo. Inoltre, ultima delle sue azioni, ha
indetto per oggi un nuovo sciopero generale, con
relativo blocco stradale. Dunque dalla mezzanotte di
oggi tre dipartimenti (Pando, Beni e Santa Cruz) si
fermeranno, le strade saranno bloccate e il traffico
su ruota, il più importante del Paese, probabilmente
verrà paralizzato. I leader dei dipartimenti di
Tarija e Chuquisasca, invece, decideranno solo oggi
se aggregarsi alle proteste o definire nuove misure
di lotta. Pressioni.
Al centro del contendere c'è la richiesta delle
regioni ricche della restituzione dell'Idh (Impuesto
Directo a los Hidrocarburos). Il governo, infatti,
ha deciso di abbassare la quota di proventi in
arrivo dalla tassa sugli idrocarburi promessa alle
zone della produzione. Ma l'abbassamento della quota
non è un'idea campata in aria. Morales, infatti, ha
deciso di finanziare un progetto per gli anziani
boliviani che vivono in situazione di estrema
povertà. Una decisione, quella del presidente che ha
fatto storcere il naso ai prefetti ribelli. E non
sono mancate le violenze: già nella giornata di ieri
gruppi di giovani armati di bastoni appartenenti
all'Union Juvenil Crucenista hanno causato numerosi
incidenti scontrandosi con i fedelissimi del
presidente. Alto il bilancio dei feriti a fine
giornata. Inoltre, nel popoloso quartiere Plan 3000
alcuni giornalisti e fotografi sono stati
selvaggiamente malmenati e le loro auto distrutte.
Pressioni.
Al centro del contendere c'è la richiesta delle
regioni ricche della restituzione dell'Idh (Impuesto
Directo a los Hidrocarburos). Il governo, infatti,
ha deciso di abbassare la quota di proventi in
arrivo dalla tassa sugli idrocarburi promessa alle
zone della produzione. Ma l'abbassamento della quota
non è un'idea campata in aria. Morales, infatti, ha
deciso di finanziare un progetto per gli anziani
boliviani che vivono in situazione di estrema
povertà. Una decisione, quella del presidente che ha
fatto storcere il naso ai prefetti ribelli. E non
sono mancate le violenze: già nella giornata di ieri
gruppi di giovani armati di bastoni appartenenti
all'Union Juvenil Crucenista hanno causato numerosi
incidenti scontrandosi con i fedelissimi del
presidente. Alto il bilancio dei feriti a fine
giornata. Inoltre, nel popoloso quartiere Plan 3000
alcuni giornalisti e fotografi sono stati
selvaggiamente malmenati e le loro auto distrutte. Il
governo. Dialogo, dialogo
e ancora dialogo. Sembra essere questa la strada che
seguirà l'esecutivo boliviano, nonostante tutto. Il
ministro Alfredo Rada ha condannato gli episodi di
violenza di ieri e l'annuncio di un imminente nuovo
sciopero previsto per oggi. “Abbiamo sentito minacce
contro la sicurezza e contro la tranquillità e la
convivenza pacifica” ha detto Rada che ha aggiunto:
“Adesso si mettono a dire che bloccheranno
nuovamente le strade del Paese. Queste non sono
misure utile alla nazione che ha bisogno di estrema
tranquillità e non di scontri fisici e verbali”.
Il
governo. Dialogo, dialogo
e ancora dialogo. Sembra essere questa la strada che
seguirà l'esecutivo boliviano, nonostante tutto. Il
ministro Alfredo Rada ha condannato gli episodi di
violenza di ieri e l'annuncio di un imminente nuovo
sciopero previsto per oggi. “Abbiamo sentito minacce
contro la sicurezza e contro la tranquillità e la
convivenza pacifica” ha detto Rada che ha aggiunto:
“Adesso si mettono a dire che bloccheranno
nuovamente le strade del Paese. Queste non sono
misure utile alla nazione che ha bisogno di estrema
tranquillità e non di scontri fisici e verbali”.  Perseguitato
politico. Luis Mayusa
aveva 46 anni ed era padre di quattro bambini.
Secondo quanto informa la famiglia era uscito di
casa per accompagnare i figli a una visita medica.
Al ritorno, a pochi passi dalla sua abitazione, è
stato raggiunto da vari proiettili sparati da
ignoti.
Perseguitato
politico. Luis Mayusa
aveva 46 anni ed era padre di quattro bambini.
Secondo quanto informa la famiglia era uscito di
casa per accompagnare i figli a una visita medica.
Al ritorno, a pochi passi dalla sua abitazione, è
stato raggiunto da vari proiettili sparati da
ignoti. Sterminio.
La Unión Patriótica nacque in seguito a un
processo di pace tra le Farc e il governo del
conservatore Belisario Betancur. Molti attivisti
politici, entrati nelle Farc per sfuggire agli
assassinii politici, abbandonarono la lotta armata,
e entrarono nella Up, convinti che fosse finito il
ciclo di violenza politica che li aveva costretti
alla clandestinità e che ci fossero le condizioni
per ritornare a fare politica a viso aperto nella
società civile. Ma cosí non era e quando la
Unión Patriótica iniziò a ottenere rilevanti
successi elettorali, venne fermata a colpi di arma
da fuoco. Piú di 4000 omicidi tra cui 2 candidati
presidenziali, 21 parlamentari, 11 sindaci, 70
consiglieri e migliaia di militanti e semplici
simpatizzanti.
Sterminio.
La Unión Patriótica nacque in seguito a un
processo di pace tra le Farc e il governo del
conservatore Belisario Betancur. Molti attivisti
politici, entrati nelle Farc per sfuggire agli
assassinii politici, abbandonarono la lotta armata,
e entrarono nella Up, convinti che fosse finito il
ciclo di violenza politica che li aveva costretti
alla clandestinità e che ci fossero le condizioni
per ritornare a fare politica a viso aperto nella
società civile. Ma cosí non era e quando la
Unión Patriótica iniziò a ottenere rilevanti
successi elettorali, venne fermata a colpi di arma
da fuoco. Piú di 4000 omicidi tra cui 2 candidati
presidenziali, 21 parlamentari, 11 sindaci, 70
consiglieri e migliaia di militanti e semplici
simpatizzanti.  "Arrivano
le Auc". L’omicidio
infatti è avvenuto proprio in una regione, Arauca,
che segna il record quanto a militarizzazione: tra
polizia ed esercito si conta un membro della forza
pubblica ogni sette abitanti. Una forza militare
dispiegata dal governo Uribe per proteggere le
installazioni petrolifere e gli oleodotti. Ma che
non riesce a proteggere la vita della popolazione e
i diritti civili e politici: nelle prime due
settimane di agosto solo in Saravena sono state
uccise altre sei persone oltre a Luis Mayusa. E in
città si moltiplicano graffiti con scritte come
“Arrivano le Auc” (paramiltari delle Autodifese
Unite di Colombia).
"Arrivano
le Auc". L’omicidio
infatti è avvenuto proprio in una regione, Arauca,
che segna il record quanto a militarizzazione: tra
polizia ed esercito si conta un membro della forza
pubblica ogni sette abitanti. Una forza militare
dispiegata dal governo Uribe per proteggere le
installazioni petrolifere e gli oleodotti. Ma che
non riesce a proteggere la vita della popolazione e
i diritti civili e politici: nelle prime due
settimane di agosto solo in Saravena sono state
uccise altre sei persone oltre a Luis Mayusa. E in
città si moltiplicano graffiti con scritte come
“Arrivano le Auc” (paramiltari delle Autodifese
Unite di Colombia).  Lo
scorso 8 agosto un cittadino saudita,
impiegato nel ministero per la
Promozione della Virtù e la Prevenzione
del Vizio, ha ucciso sua figlia
accusandola di essersi convertita al
cristianesimo. I nomi di padre e figlia
non sono stati divulgati ma la notizia,
lanciata dal sito di news Saudi Al
Ukhdoud, ha sollevato rabbia e
indignazione dentro e fuori dal regno.
La vittima frequentava siti web e blog
come Free Copts, copti liberi, e il
fratello aveva recentemente scoperto
tracce del suo interesse nel computer di
casa. Da allora sua vita era diventata
impossibile, raccontava ai suoi amici
telematici, fino alla scorsa settimana,
quando il padre le ha tagliato la lingua
e le ha dato fuoco, uccidendola. Ora
l'uomo è in carcere e verrà giudicato
per un crimine legato al Diritto
D'onore, una pratica ancora tristemente
attuale in diversi paesi islamici.
Tuttavia è improbable che riceva una
pena severa, del resto la maggior parte
dei religiosi sauditi mette in guardia
contro i siti cristiani e i canali
televisivi occidentali, considerati a
pieno titolo minacce contro l'islam.
Lo
scorso 8 agosto un cittadino saudita,
impiegato nel ministero per la
Promozione della Virtù e la Prevenzione
del Vizio, ha ucciso sua figlia
accusandola di essersi convertita al
cristianesimo. I nomi di padre e figlia
non sono stati divulgati ma la notizia,
lanciata dal sito di news Saudi Al
Ukhdoud, ha sollevato rabbia e
indignazione dentro e fuori dal regno.
La vittima frequentava siti web e blog
come Free Copts, copti liberi, e il
fratello aveva recentemente scoperto
tracce del suo interesse nel computer di
casa. Da allora sua vita era diventata
impossibile, raccontava ai suoi amici
telematici, fino alla scorsa settimana,
quando il padre le ha tagliato la lingua
e le ha dato fuoco, uccidendola. Ora
l'uomo è in carcere e verrà giudicato
per un crimine legato al Diritto
D'onore, una pratica ancora tristemente
attuale in diversi paesi islamici.
Tuttavia è improbable che riceva una
pena severa, del resto la maggior parte
dei religiosi sauditi mette in guardia
contro i siti cristiani e i canali
televisivi occidentali, considerati a
pieno titolo minacce contro l'islam. Un
altro episodio, avvenuto pochi giorni
dopo, vede protagonista un uomo di 50
anni che ha regolarmente contratto
matrimonio con una bambina di cinque
anni. Il padre della sposa-bambina aveva
acconsentito all'unione in cambio di una
cospicua dote. La vicenda, avvenuta
nella provincia di Al Qasim, è stata
divulgata dal magazine locale Okaz. La
madre della bambina, però, ha deciso di
denunciare il marito e chiedere a un
tribunale l'annullamento del matrimonio
della figlia: “Quell'uomo è già sposato
con due donne” ha spiegato. Secondo
esperti di diritto familiare islamico,
nei tribunali sauditi si presentano
spesso cause di questo tipo, e non è
affatto scontato che a vincere sia la
madre della bambina. Una vicenda del
tutto simile, infatti, è già in fase di
processo nella provincia di Asir, a sud
della Mecca, dove un settantenne è stato
denunciato dopo aver sposato una bambina
di 10 anni. In Arabia Saudita non ci
sono leggi che determinino un'età minima
per sposarsi e anche l'approvazione
della donna, formalmente necessaria,
spesso non viene nemmeno chiesta.
Un
altro episodio, avvenuto pochi giorni
dopo, vede protagonista un uomo di 50
anni che ha regolarmente contratto
matrimonio con una bambina di cinque
anni. Il padre della sposa-bambina aveva
acconsentito all'unione in cambio di una
cospicua dote. La vicenda, avvenuta
nella provincia di Al Qasim, è stata
divulgata dal magazine locale Okaz. La
madre della bambina, però, ha deciso di
denunciare il marito e chiedere a un
tribunale l'annullamento del matrimonio
della figlia: “Quell'uomo è già sposato
con due donne” ha spiegato. Secondo
esperti di diritto familiare islamico,
nei tribunali sauditi si presentano
spesso cause di questo tipo, e non è
affatto scontato che a vincere sia la
madre della bambina. Una vicenda del
tutto simile, infatti, è già in fase di
processo nella provincia di Asir, a sud
della Mecca, dove un settantenne è stato
denunciato dopo aver sposato una bambina
di 10 anni. In Arabia Saudita non ci
sono leggi che determinino un'età minima
per sposarsi e anche l'approvazione
della donna, formalmente necessaria,
spesso non viene nemmeno chiesta. L'11
agosto, nella regione di Qatif, nella
parte orientale del paese, la polizia
religiosa arrestava Rueida, una donna di
47 anni, per avere infranto il divieto
di guidare l'auto. La donna, scoperta
grazie alla segnalazione indignata di
alcuni astanti, è stata arrestata e
verrà processata. In Arabia Saudita non
ci sono leggi che proibiscano di guidare
al gentil sesso, ma c'è una lunga
tradizione di religiosi Wahabiti che
insistono, anche emettendo delle fatwa,
che guidare per le donne sia un peccato.
In passato le manifestazioni di protesta
contro questa limitazione sono state
represse, le donne attiviste arrestate
e, per punizione ulteriore, espulse dal
lavoro o dall'università. Rueida è stata
rilasciata su cauzione, ma il giorno
dopo, il quotidiano Al Riad svelava: la
donna alla guida stava compiendo un atto
eroico. Rueida era stata costretta a
violare la norma religiosa per salvare i
familiari coinvolti in un incendio, che
le era divampato in casa. Il padre e i
fratelli erano rimasti feriti, non erano
in grado di guidare, e lei, che aveva
imparato a portare l'auto dentro la
fattoria dei genitori, aveva dovuto
accompagnarli all'ospedale. Secondo la
stampa del regno, sono molte le donne
che, per ragioni impellenti, si mettono
alla guida sfidando i precetti islamici
e sperando di non incontrare la polizia
religiosa. Spesso la fanno franca ma,
per i religiosi sauditi, quello che
conta è la possibilità di continuare a
vietare e punire.
L'11
agosto, nella regione di Qatif, nella
parte orientale del paese, la polizia
religiosa arrestava Rueida, una donna di
47 anni, per avere infranto il divieto
di guidare l'auto. La donna, scoperta
grazie alla segnalazione indignata di
alcuni astanti, è stata arrestata e
verrà processata. In Arabia Saudita non
ci sono leggi che proibiscano di guidare
al gentil sesso, ma c'è una lunga
tradizione di religiosi Wahabiti che
insistono, anche emettendo delle fatwa,
che guidare per le donne sia un peccato.
In passato le manifestazioni di protesta
contro questa limitazione sono state
represse, le donne attiviste arrestate
e, per punizione ulteriore, espulse dal
lavoro o dall'università. Rueida è stata
rilasciata su cauzione, ma il giorno
dopo, il quotidiano Al Riad svelava: la
donna alla guida stava compiendo un atto
eroico. Rueida era stata costretta a
violare la norma religiosa per salvare i
familiari coinvolti in un incendio, che
le era divampato in casa. Il padre e i
fratelli erano rimasti feriti, non erano
in grado di guidare, e lei, che aveva
imparato a portare l'auto dentro la
fattoria dei genitori, aveva dovuto
accompagnarli all'ospedale. Secondo la
stampa del regno, sono molte le donne
che, per ragioni impellenti, si mettono
alla guida sfidando i precetti islamici
e sperando di non incontrare la polizia
religiosa. Spesso la fanno franca ma,
per i religiosi sauditi, quello che
conta è la possibilità di continuare a
vietare e punire.  Il
piano. Secondo il
progetto, l'esercito di Kabul verrebbe portato a
120mila uomini dai circa 63mila attuali. Gli Stati
Uniti forniranno anche addestramento,
equipaggiamento, cibo e strutture abitative per i
militari afghani. Inoltre, il leader del Pentagono
ha intenzione di modificare le strutture di comando
delle due missioni a guida straniera in Afghanistan,
dando al generale David McKieran – già alla guida
della forza Nato da 45mila uomini, di cui 15mila
soldati statunitensi – anche il comando delle 19mila
truppe americane che al momento operano in una
missione separata. L'ordine con le nuove
disposizioni dovrebbe essere firmato alla fine di
agosto.
Il
piano. Secondo il
progetto, l'esercito di Kabul verrebbe portato a
120mila uomini dai circa 63mila attuali. Gli Stati
Uniti forniranno anche addestramento,
equipaggiamento, cibo e strutture abitative per i
militari afghani. Inoltre, il leader del Pentagono
ha intenzione di modificare le strutture di comando
delle due missioni a guida straniera in Afghanistan,
dando al generale David McKieran – già alla guida
della forza Nato da 45mila uomini, di cui 15mila
soldati statunitensi – anche il comando delle 19mila
truppe americane che al momento operano in una
missione separata. L'ordine con le nuove
disposizioni dovrebbe essere firmato alla fine di
agosto. Riorganizzazione
dei comandi. Gli
Stati Uniti fanno da tempo pressioni sugli alleati
della Nato, affinché si assumano maggiori
responsabilità in Afghanistan, in sostanza inviando
più uomini e liberandosi dalle restrizioni
legislative che impediscono ad alcuni Paesi, tra cui
l'Italia, di partecipare ad aperte operazioni di
guerra. La missione Nato, che nel 2006 ha preso in
mano la gestione della ricostruzione e del
mantenimento della sicurezza in aree che si
consideravano relativamente pacificate, è andata in
realtà incontro a una violenza maggiore rispetto
alle previsioni. La missione guidata dagli Usa,
invece, ha avuto da subito come priorità quella di
combattere i militanti talebani. La ristrutturazione
voluta da Washington, hanno precisato alcuni
ufficiali del Pentagono, non significa comunque che
le due missioni verrano unificate.
Riorganizzazione
dei comandi. Gli
Stati Uniti fanno da tempo pressioni sugli alleati
della Nato, affinché si assumano maggiori
responsabilità in Afghanistan, in sostanza inviando
più uomini e liberandosi dalle restrizioni
legislative che impediscono ad alcuni Paesi, tra cui
l'Italia, di partecipare ad aperte operazioni di
guerra. La missione Nato, che nel 2006 ha preso in
mano la gestione della ricostruzione e del
mantenimento della sicurezza in aree che si
consideravano relativamente pacificate, è andata in
realtà incontro a una violenza maggiore rispetto
alle previsioni. La missione guidata dagli Usa,
invece, ha avuto da subito come priorità quella di
combattere i militanti talebani. La ristrutturazione
voluta da Washington, hanno precisato alcuni
ufficiali del Pentagono, non significa comunque che
le due missioni verrano unificate.
 Il
grosso delle forze armate impiegate a Diyala
appartiene alla 19ma brigata dell'esercito
iracheno, mentre le forze Usa sono rimaste
in disparte, limitandosi a coordinare alcune
delle brigate. Il governo di Baghdad ha però
voluto che fosse anche un'operazione di
immagine, per questo, assieme ai soldati
sono giunti nella provincia anche giudici,
commandos del ministero dell'interno,
polizia stradale e persino membri dei
dipartimenti deputati alle forniture
elettriche, idriche e sanitarie. La notizia,
però, è che accanto ai soldati iracheni
hanno combattuto anche le milizie Sahwa,
quelle dei Consigli del risveglio tribali.
90mila uomini che non avevano un buon
rapporto con le forze armate , perlomeno,
fino a quando il premier Al Maliki non ha
promesso l'assunzione nell'esercito per
3mila di loro. Secondo il reporter Usa Dahar
Jamail, gli stessi Consigli del risveglio
avrebbero consegnato al generale Ali Gaidan,
comandante delle forze terrestri irachene,
una lista di nomi dei militanti Qaedisti
della provincia. L'operazione Bashaer al
Kheir, infatti, puntava proprio a
eliminare dalla provincia le milizie di Al
Qaeda, in parte le stesse che erano fuggite
dalla “bonifica” dell'Al Anbar, attuata
anch'essa con l'aiuto delle milizie tribali
sunnite. Da mesi la provincia era diventata
una roccaforte di Al Qaeda ed era stata
teatro di numerosi attentati suicidi, alcuni
dei quali, recentemente portati a termine da
donne.
Il
grosso delle forze armate impiegate a Diyala
appartiene alla 19ma brigata dell'esercito
iracheno, mentre le forze Usa sono rimaste
in disparte, limitandosi a coordinare alcune
delle brigate. Il governo di Baghdad ha però
voluto che fosse anche un'operazione di
immagine, per questo, assieme ai soldati
sono giunti nella provincia anche giudici,
commandos del ministero dell'interno,
polizia stradale e persino membri dei
dipartimenti deputati alle forniture
elettriche, idriche e sanitarie. La notizia,
però, è che accanto ai soldati iracheni
hanno combattuto anche le milizie Sahwa,
quelle dei Consigli del risveglio tribali.
90mila uomini che non avevano un buon
rapporto con le forze armate , perlomeno,
fino a quando il premier Al Maliki non ha
promesso l'assunzione nell'esercito per
3mila di loro. Secondo il reporter Usa Dahar
Jamail, gli stessi Consigli del risveglio
avrebbero consegnato al generale Ali Gaidan,
comandante delle forze terrestri irachene,
una lista di nomi dei militanti Qaedisti
della provincia. L'operazione Bashaer al
Kheir, infatti, puntava proprio a
eliminare dalla provincia le milizie di Al
Qaeda, in parte le stesse che erano fuggite
dalla “bonifica” dell'Al Anbar, attuata
anch'essa con l'aiuto delle milizie tribali
sunnite. Da mesi la provincia era diventata
una roccaforte di Al Qaeda ed era stata
teatro di numerosi attentati suicidi, alcuni
dei quali, recentemente portati a termine da
donne. Inizialmente
le milizie tribali avevano duramente
criticato il largo preavviso concesso ai
miliziani prima dell'inizio delle manovre,
ma dal ministero dell'Interno iracheno si
replica che “abbiamo intenzionalmente dato
ai miliziani la possibilità di fuggire, allo
scopo di creare una frattura con i loro
leader una volta che fosse scoppiato il
caos”. Una risposta nuova per una strategia
che è stata adottata sin dall'inizio del
conflitto. A quanto pare, però, il caos
previsto non è scoppiato. Le forze armate
hanno imposto il coprifuoco in tutta la
provincia, hanno condotto perquisizioni casa
per casa e imposto check point per le
strade, apparentemente senza commettere
gravi abusi. Secondo alcune interviste
raccolte a Baquba, la capitale della
provincia, da Jamail, che normalmente non
risparmia critiche a nessuno, la violenza
temuta dalla popolazione rimasta in città
non c'è stata. Qualcuno parla delle buone
maniere dei soldati, qualcun'altro racconta
pure che la gente offriva loro cibo e acqua.
Uno degli obiettivi dell'operazione era
estirpare le infiltrazioni dei miliziani
dalle forze di sicurezza provinciali, e dopo
pochi giorni gli agenti arrestati erano già
un centinaio.
Inizialmente
le milizie tribali avevano duramente
criticato il largo preavviso concesso ai
miliziani prima dell'inizio delle manovre,
ma dal ministero dell'Interno iracheno si
replica che “abbiamo intenzionalmente dato
ai miliziani la possibilità di fuggire, allo
scopo di creare una frattura con i loro
leader una volta che fosse scoppiato il
caos”. Una risposta nuova per una strategia
che è stata adottata sin dall'inizio del
conflitto. A quanto pare, però, il caos
previsto non è scoppiato. Le forze armate
hanno imposto il coprifuoco in tutta la
provincia, hanno condotto perquisizioni casa
per casa e imposto check point per le
strade, apparentemente senza commettere
gravi abusi. Secondo alcune interviste
raccolte a Baquba, la capitale della
provincia, da Jamail, che normalmente non
risparmia critiche a nessuno, la violenza
temuta dalla popolazione rimasta in città
non c'è stata. Qualcuno parla delle buone
maniere dei soldati, qualcun'altro racconta
pure che la gente offriva loro cibo e acqua.
Uno degli obiettivi dell'operazione era
estirpare le infiltrazioni dei miliziani
dalle forze di sicurezza provinciali, e dopo
pochi giorni gli agenti arrestati erano già
un centinaio.  Mercoledì
6 agosto, l'operazione pareva vicina alla
conclusione. Il ministero della Difesa
irachena annunciava l'arresto di 483 persone
tra cui alti esponenti della “rete del
terrore” e persino una donna considerata
responsabile del reclutamento delle
kamikaze. Lo stesso giorno, il New York
Times pubblicava un articolo proprio sulla
19ma brigata dell'esercito iracheno,
sostenendo che, nonostante la buona volontà,
gran parte dei battaglioni iracheni non era
in grado di agire senza il coordinamento con
i cosiddetti Transition Team
statunitensi. Anche il Nyt, però, conferma
che in quest'operazione gli Usa hanno
limitato di molto il loro apporto, sia
logistico che strategico, alle forze armate
di Baghdad. Ufficiali e soldati iracheni
ammettono carenze di equipaggiamento di
preparazione e coordinamento tra i reparti.
Sostengono insomma che senza gli Stati Uniti
l'esercito iracheno non ce la possa ancora
fare. Ma forse, alla luce dei risultati di
Diyala, l'allenza con le milizie Sahwa
potrebbe ricevere maggiore considerazione:
90mila uomini che parlano arabo, sanno
combattere ma anche rispettare la gente
potrebbero essere più efficaci dei marines,
che notoriamente incutono timore e odio nei
civili. Martedì 5 agosto il premier al
Maliki ha annunciato un'amnistia per i
miliziani ancora presenti nella provincia
che consegneranno le armi entro sette
giorni. Se anche quell'inziativa avrà
successo, allora la provincia potrà davvero
dirsi sicura. Ci vorrà del tempo insomma per
sapere se le nuove strategie sono davvero
state utili, e se Bashaer al Kheir
significa davvero bella speranza.
Mercoledì
6 agosto, l'operazione pareva vicina alla
conclusione. Il ministero della Difesa
irachena annunciava l'arresto di 483 persone
tra cui alti esponenti della “rete del
terrore” e persino una donna considerata
responsabile del reclutamento delle
kamikaze. Lo stesso giorno, il New York
Times pubblicava un articolo proprio sulla
19ma brigata dell'esercito iracheno,
sostenendo che, nonostante la buona volontà,
gran parte dei battaglioni iracheni non era
in grado di agire senza il coordinamento con
i cosiddetti Transition Team
statunitensi. Anche il Nyt, però, conferma
che in quest'operazione gli Usa hanno
limitato di molto il loro apporto, sia
logistico che strategico, alle forze armate
di Baghdad. Ufficiali e soldati iracheni
ammettono carenze di equipaggiamento di
preparazione e coordinamento tra i reparti.
Sostengono insomma che senza gli Stati Uniti
l'esercito iracheno non ce la possa ancora
fare. Ma forse, alla luce dei risultati di
Diyala, l'allenza con le milizie Sahwa
potrebbe ricevere maggiore considerazione:
90mila uomini che parlano arabo, sanno
combattere ma anche rispettare la gente
potrebbero essere più efficaci dei marines,
che notoriamente incutono timore e odio nei
civili. Martedì 5 agosto il premier al
Maliki ha annunciato un'amnistia per i
miliziani ancora presenti nella provincia
che consegneranno le armi entro sette
giorni. Se anche quell'inziativa avrà
successo, allora la provincia potrà davvero
dirsi sicura. Ci vorrà del tempo insomma per
sapere se le nuove strategie sono davvero
state utili, e se Bashaer al Kheir
significa davvero bella speranza.
 ROMA
- Il 46 per cento delle classi non ha rispettato il tetto di spesa
per i libri scolastici che il ministero dell'Istruzione ha deciso di
adottare per il prossimo anno. La maggiore spesa che le famiglie
saranno costrette ad affrontare ammonta a 14 milioni di euro. E'
quanto risulta da un'indagine effettuata dall'associazione
Altroconsumo sulle prime classi di 276 istituti scolastici in tutte
le Regioni italiane. Un dato vicino a quello di un'analoga indagine
effettuata meno di un mese fa da Repubblica.it. Di conseguenza,
Altroconsumo ha inviato oggi una diffida al ministero
dell'Istruzione, richiedendo un intervento, presso i presidi delle
scuole che hanno sforato i tetti previsti, affinché rivedano le
adozioni dei testi scolastici.
ROMA
- Il 46 per cento delle classi non ha rispettato il tetto di spesa
per i libri scolastici che il ministero dell'Istruzione ha deciso di
adottare per il prossimo anno. La maggiore spesa che le famiglie
saranno costrette ad affrontare ammonta a 14 milioni di euro. E'
quanto risulta da un'indagine effettuata dall'associazione
Altroconsumo sulle prime classi di 276 istituti scolastici in tutte
le Regioni italiane. Un dato vicino a quello di un'analoga indagine
effettuata meno di un mese fa da Repubblica.it. Di conseguenza,
Altroconsumo ha inviato oggi una diffida al ministero
dell'Istruzione, richiedendo un intervento, presso i presidi delle
scuole che hanno sforato i tetti previsti, affinché rivedano le
adozioni dei testi scolastici.  Lo
dice il Censis: è di gran lunga il Paese europeo dove si muore di
più sul lavoro.
Lo
dice il Censis: è di gran lunga il Paese europeo dove si muore di
più sul lavoro.  Negare
l'evidenza. "Gli Stati uniti
non hanno mai trasportato nessuno in un
Paese dove i prigionieri hanno subito
torture. Gli Stati Uniti non usano lo
spazio aereo o gli aeroporti di alcun
Paese per trasferirli in altri Paesi
dove verranno torturati". Questa era
stata la dichiarazione di Condoleezza
Rice nel 2005. Il presidente Usa Bush,
due anni dopo, dietro pressione di
numerosi rapporti di organizzazioni per
la tutela dei diritti umani e
interrogazioni parlamentari di numerosi
Paesi europei e dello stesso Parlamento
europeo, aveva invece ammesso
l'esistenza di un programma della Cia in
cui compagnie aeree private
trasportavano sospetti in prigioni
segrete intorno al mondo. I centri
individuati alcuni anni fa erano circa
una decina: uno in Iraq, sette in
Afghanistan, uno in Pakistan, uno in
Giordania, un altro alla base di Diego
Garcia, nonché due su altrettante navi
militari della marina statunitense.
Successivamente, emersero testimonianze
sull'esistenza di segrete anche nel
territorio europeo, in Polonia e
Romania.
Negare
l'evidenza. "Gli Stati uniti
non hanno mai trasportato nessuno in un
Paese dove i prigionieri hanno subito
torture. Gli Stati Uniti non usano lo
spazio aereo o gli aeroporti di alcun
Paese per trasferirli in altri Paesi
dove verranno torturati". Questa era
stata la dichiarazione di Condoleezza
Rice nel 2005. Il presidente Usa Bush,
due anni dopo, dietro pressione di
numerosi rapporti di organizzazioni per
la tutela dei diritti umani e
interrogazioni parlamentari di numerosi
Paesi europei e dello stesso Parlamento
europeo, aveva invece ammesso
l'esistenza di un programma della Cia in
cui compagnie aeree private
trasportavano sospetti in prigioni
segrete intorno al mondo. I centri
individuati alcuni anni fa erano circa
una decina: uno in Iraq, sette in
Afghanistan, uno in Pakistan, uno in
Giordania, un altro alla base di Diego
Garcia, nonché due su altrettante navi
militari della marina statunitense.
Successivamente, emersero testimonianze
sull'esistenza di segrete anche nel
territorio europeo, in Polonia e
Romania.  Situation
Room.
Attraverso un ufficiale Usa oggi in
pensione, il Time Magazine conferma che
nell'isola di Diego Garcia, nel 2002 e
nel 2003, vennero imprigionati e
interrogati sospetti terroristi. Il
militare, dietro l'anonimato, partecipò
a numerose riunioni della 'Situation
Room' della Casa Bianca, il centro
nevralgico decisionale sulle questioni
legate alla lotta al terrorismo dopo
l'11 settembre. La fonte racconta che
durante un incontro, un agente della Cia
parlò espressamente dell'utilizzo
dell'isola per la detenzione e
l'interrogatorio di uno o più
prigionieri 'di grande importanza', che
in alcuni casi vennero anche interrogati
sulle navi che stazionavano nelle acque
territoriali dell'isola, la cui
sovranità è britannica.
Situation
Room.
Attraverso un ufficiale Usa oggi in
pensione, il Time Magazine conferma che
nell'isola di Diego Garcia, nel 2002 e
nel 2003, vennero imprigionati e
interrogati sospetti terroristi. Il
militare, dietro l'anonimato, partecipò
a numerose riunioni della 'Situation
Room' della Casa Bianca, il centro
nevralgico decisionale sulle questioni
legate alla lotta al terrorismo dopo
l'11 settembre. La fonte racconta che
durante un incontro, un agente della Cia
parlò espressamente dell'utilizzo
dell'isola per la detenzione e
l'interrogatorio di uno o più
prigionieri 'di grande importanza', che
in alcuni casi vennero anche interrogati
sulle navi che stazionavano nelle acque
territoriali dell'isola, la cui
sovranità è britannica. Al
di sopra del diritto.
Per avere conferma della rivelazione
dell'ufficiale contattato dal Time, il
magazine statunitense ha intervistato
Richard Clarke, ex consulente speciale
di Bush sulla Sicurezza nazionale e il
contro-terrorismo. "La possibilità di
utilizzare la base di Diego Garcia - ha
detto Clarke - per la detenzione di
terroristi di primo piano è stata più
volte discussa in mia presenza. Dato ciò
che sappiamo circa l'approccio
dell'amministrazione Bush, in termini
legali, di fronte a questi problemi,
ritengo che la possibilità dell'uso
della Diego Garcia sia stato
assolutamente verosimile". Clarke, da
sempre critico della gestione della
guerra al terrore da parte
dell'amministrazione Bush, ha dichiarato
che utilizzare l'isola senza
l'autorizzazione del governo britannico
rappresenta una 'violazione non solo
della legge britannica, ma anche
dell'accordo bilaterale che disciplina
la gestione del suo territorio'.
Al
di sopra del diritto.
Per avere conferma della rivelazione
dell'ufficiale contattato dal Time, il
magazine statunitense ha intervistato
Richard Clarke, ex consulente speciale
di Bush sulla Sicurezza nazionale e il
contro-terrorismo. "La possibilità di
utilizzare la base di Diego Garcia - ha
detto Clarke - per la detenzione di
terroristi di primo piano è stata più
volte discussa in mia presenza. Dato ciò
che sappiamo circa l'approccio
dell'amministrazione Bush, in termini
legali, di fronte a questi problemi,
ritengo che la possibilità dell'uso
della Diego Garcia sia stato
assolutamente verosimile". Clarke, da
sempre critico della gestione della
guerra al terrore da parte
dell'amministrazione Bush, ha dichiarato
che utilizzare l'isola senza
l'autorizzazione del governo britannico
rappresenta una 'violazione non solo
della legge britannica, ma anche
dell'accordo bilaterale che disciplina
la gestione del suo territorio'. Medici
per i diritti umani.
Sulla questione è intervenuta anche
l'organizzazione umanitaria statunitense
Physicians for Human Rights (Medici per
i diritti umani), che ha lanciato un
appello per un'inchiesta
'transatlantica' da parte del Congresso
Usa e del Parlamento britannico che
faccia luce sull'utilizzo della Diego
Garcia come centro di detenzione
segreto. "Il trattamento dei detenuti e
le pratiche di interrogatori
dell'amministrazione Bush hanno
danneggiato la reputazione della nostra
nazione come leader nel campo dei
diritti umani" ha dichiarato il
direttore Frank Donaghue. "Sette anni di
segreti sussurati in stanze segrete
devono cessare, e una nuova epoca di
testimonianze registrate e interrogatori
con tutte le tutele legali finalmente
cominciare".
Medici
per i diritti umani.
Sulla questione è intervenuta anche
l'organizzazione umanitaria statunitense
Physicians for Human Rights (Medici per
i diritti umani), che ha lanciato un
appello per un'inchiesta
'transatlantica' da parte del Congresso
Usa e del Parlamento britannico che
faccia luce sull'utilizzo della Diego
Garcia come centro di detenzione
segreto. "Il trattamento dei detenuti e
le pratiche di interrogatori
dell'amministrazione Bush hanno
danneggiato la reputazione della nostra
nazione come leader nel campo dei
diritti umani" ha dichiarato il
direttore Frank Donaghue. "Sette anni di
segreti sussurati in stanze segrete
devono cessare, e una nuova epoca di
testimonianze registrate e interrogatori
con tutte le tutele legali finalmente
cominciare".