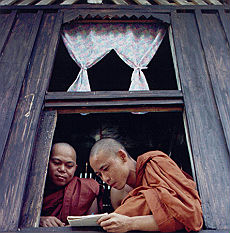|

27 marzo

Regione Campania, mazzette all'americana
Spot con mazzetta? Anche sulle attività per
promuovere l'immagine della Campania nel mondo spunta l'accusa di corruzione. A
partire proprio da quella lussuosa sede di rappresentanza nel cuore di New York
che è sempre apparsa come uno spreco: solo nel 2004 è venuta a costare un
milione e centomila euro. I magistrati napoletani hanno arrestato Elio De Rosa,
titolare della Cosmofilm: la società che ha vinto l'appalto per la promozione
della Regione e ha realizzato i video per le campagne pubblicitarie destinate a
sostenere l'immagine della Campania. Il mandato di cattura riguarda le
iniziative realizzate dalla Cosmofilm a New York: De Rosa sarebbe accusato di
corruzione, associazione per delinquere e frode nelle pubbliche forniture. Con
lui sono sotto inchiesta due dirigenti della Regione: l'ex responsabile della
sede newyorchese, che si è dimesso dall'incarico dopo l'apertura
dell'istruttoria, e l'ex responsabile del settore stampa, entrambi nominati da
Antonio Bassolino. Anche in questo caso, c'è da interrogarsi sul silenzio della
politica e della cosìdetta società civile di fronte a sprechi manifesti da anni:
la Corte dei conti già nel 2005 aveva denunciato le spesi folli dell'ambasciata
campana negli States. Eppure i viaggi di rappresentanza dell'assemblea erano
proseguiti: nel'ultima delle sue trasferte transatlantiche Sandra Lonardo
Mastella riuscì a spendere ben 59 mila euro, vantandosi di averne risparmiati 6
mila rispetto al budget stanziato. Ma il capitolo più impressionante delle
accuse riguarda le iniziative assurde finanziate con i soldi dei contribuenti.
Spicca la mostra sulla "ceramica artistica di San Lorenzello e dell'intarsio
sorrentino" allestita nella Grande Mela nel settembre 2005 con un investimento
di 300 mila euro e nessun visitatore. Scrissero due ispettori, mandati dalla
stessa Regione: «È un fallimento, non è stata visitata da nessun operatore di
settore nè dal pubblico». Perché allora si continuava a consegnare la gestione
di questi eventi alla stessa azienda? Una spiegazione secondo i magistrati può
venire da quelle consegne che venivano ritirate dall'allora numero uno della
comunicazione regionale: «Quanto pattuito, una busta pallinata, tutto sigillato,
anonimo». E dentro 10 mila euro in contanti.
Adesso che i mercati vanno in tilt, tutti chiedono l'aiuto di Stato
Alessandro Volpi
Da
qualche tempo è ricomparso con forza il grande bistrattato. Quasi ovunque
infatti sembra non si possa fare a meno della richiesta di aiuto allo Stato,
indicato come il solo possibile sollievo, rapido e indolore, nei confronti dei
dissesti lasciati dalle crisi dei mercati. La banca inglese Northern Rock,
incapace di restituire il gigantesco prestito ponte fattogli dal governo inglese
per circa 50 miliardi di dollari e di trovare compratori veri, sarà
nazionalizzata per evitare drammatiche ripercussioni sul mercato dei mutui e
sulle sorti di moltissimi contraenti di tali contratti in terra anglosassone.
Intanto 180 mila azionisti, quelli appunto della Northern Rock, hanno già perso
quasi tutto. Ma quello della banca britannica è solo un caso fra i molti della
ricomparsa dell'appello all'aiuto di Stato, che ha fatto breccia anche nel cuore
di George W. Bush spingendolo ad erogare, ancora per fronteggiare la crisi dei
mutui, un contributo pubblico di circa 150 miliardi di dollari. Nella vicina
Francia, dove del resto la pratica dell'aiuto di Stato non ha mai perso
realmente il suo fascino, la crisi della Société Générale sembra avviata a
risoluzione con l'intervento decisivo di un'altra istituzione pubblica, forse
della Banque Postale. Anche in Germania massicci aiuti pubblici hanno salvato la
banca IKB da un sicuro fallimento.
Quando i mercati eccedono nella loro «euforia creativa» e quando gli strumenti
da essi concepiti contribuiscono a spingere il debito delle famiglie fino a
farlo divenire pericolosamente pari a 1,5 volte il loro reddito disponibile,
come avviene negli Stati Uniti e in Inghilterra, allora la necessità del
sostegno del buon vecchio Stato perde i caratteri dell' antiquato e odioso
ritorno al passato. Anche le continue iniezioni di liquidità da parte di Federal
Reserve e Bce paiono sempre più configurarsi per la loro regolarità come
interventi «pubblici» per evitare l'esplosione del debito diffuso; il modello
dell'effetto leva, dell'ingegneria finanziaria che distribuisce il rischio
vendendolo a centinaia di migliaia di soggetti ignari, delle piramidi simili al
fondo Carlyle con 31 dollari di debito per ogni dollaro di attivo sembra
incapace di provvedere alla propria manutenzione. Ha quindi bisogno di soccorso,
reso indispensabile dal fatto che le nuove dimensioni della finanziarizzazione
hanno assunto caratteri sociali.
I titolari di mutui, di pensioni di scorta, di debiti al consumo, di
obbligazioni e di carta commerciale dall'incerta sorte rischiano di diventare i
veri poveri del futuro e allora lo Stato finanziatore torna a presentarsi come
l'unica panacea nonostante sia sempre più chiaro il pericolo inflazionistico
della svalutazione. In questo senso, la vera minaccia per l'inflazione non
proviene dall'indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori «reali», ma dalla
estesa moltitudine dei diseredati finanziari. D'altra parte, se non interviene
l'aiuto pubblico «nazionale», si profila l'eventualità sempre più concreta che a
«salvare» le economie mature dalle loro difficoltà giungano altri Stati. Solo
nel corso dell'ultima estate, i fondi sovrani di proprietà di alcuni governi di
paesi emergenti - Cina, Singapore, Kuwait - hanno investito oltre 60 miliardi di
dollari per «soccorrere» le grandi banche statunitensi in crisi di liquidità,
divenendo spesso detentori di quote decisamente rilevanti.
Nel complesso, stime attendibili valutano in quasi 4 mila miliardi di dollari le
disponibilità in mano dei fondi sovrani dei principali paesi esportatori di
questo pianeta; un vero e proprio arsenale pronto per essere utilizzato in
salvataggi o per sfruttare opportunità spesso dettate dall'emergere di
situazioni di crisi. Si profila quindi uno scontro tra due diverse tipologie di
intervento statale, nazionale ed estero, in vari settori delle economie mature
che saranno messe a dura prova della nuova fase del ciclo internazionale. Certo,
se gli aiuti dei fondi sovrani provengono da paesi dove non esiste un sistema
democratico le preoccupazioni nei riguardi dei loro effetti non sono infondate e
forse l'idea di smantellare del tutto lo «Stato imprenditore» dovrebbe suscitare
almeno qualche dubbio se non lo si vuole trasformare in un mero Stato
finanziatore, peraltro con poche possibilità di successo visto che le manovre
sui tassi hanno esaurito il loro effetto.
*Università di Pisa
La ragione dispersa nel vento
Cinque
anni di guerra in Iraq
Sono passati cinque anni. Cinque anni di
massacri, di bombe calate dall'alto, di bombe portate strette alla
pancia, di proiettili vaganti. Cinque anni di torture. Cinque anni di
violazione di ogni convenzione possibile. Cinque anni di violazione di
ogni logica e di ogni buonsenso.
Forse un milione e mezzo di morti, forse
centomila. Non si sa. Segno che è proprio vero, dei morti civili non
importa proprio a nessuno. Perché quel che è peggio, nessuno lo vuole
sapere. Si conoscono i morti della prima guerra mondiale. Si stimano i
morti delle guerre puniche. Quelli iracheni sono un mistero.
Un paese civile, ricco di storia, con una
cultura tra le più importanti e vive al mondo è stato trasformato, in
cinque anni, in una macelleria che nessuno è più ormai in grado di
controllare.
Per cosa? Perché Saddam Hussein era legato
ad Al-Qaeda. Chiunque avesse anche solo un'infarinatura di cose
mediorientali sapeva benissimo che questa era una scemenza. Saddam era
un macellaio, più o meno come tanti altri che l'occidente ritiene essere
fedeli alleati e paladini della democrazia (lo era anche lui, un fedele
alleato, peraltro), ma era un laico. Di più, era un difensore del
laicismo. Mai e poi mai sarebbe potuto andare d'accordo con chi professa
il potere assoluto della religione e delle scritture (no, non stiamo
parlando di Benedetto XVI).
Per portare la democrazia? Anche questa, è
evidente a tutti, è una bugia colossale. Cosa importa del fatto che ci
sia democrazia o meno nei paesi del mondo? Parliamo di Cina? Parliamo di
Arabia Saudita? Parliamo di Filippine? L'elenco delle tirannidi amiche e
alleate è molto più lungo di quello delle democrazie compiute.
Se è stata una guerra per le risorse, cosa
più probabile, è una guerra persa.
"Il petrolio, dopo l'invasione dell'Iraq,
scenderà sotto i 40 dollari al barile", dicevano le marionette che si
fan passare per esperti economici. Oggi il petrolio costa 105.5 dollari
al barile. E prima che il greggio iracheno possa tornare sotto il
controllo occidentale, passeranno altri anni.
In compenso, nel nome di questa guerra,
nel mondo adesso si può torturare, la violenza fisica e verbale, è
diventata il linguaggio quotidiano con cui è lecito e a volte persino
giusto esprimersi.
A farne una analisi attenta e obiettiva,
questa guerra a qualche cosa è servita: ci ha fatto scoprire che il faro
della democrazia, lo Stato a cui tutti dicevano di ispirarsi, il luogo
delle promesse mantenute e delle speranze realizzate, gli Stati Uniti
d'America, sono in realtà governati da una banda, che mano a mano che
giungono le verità sui loro misfatti, appare sempre più come una
accozzaglia di cinici affaristi che non si fa scrupolo nemmeno di
commissionare torture ed omicidi pur di raggiungere il suo personale e
particolare interesse.
In molti saran saltati sulla sedia,
leggendo quella frase. Perché persino a me che scrivo fa impressione.
Eppure così è. Tutti sapevano delle menzogne. Ma le hanno dette e
ripetute fino a coprirsi di ridicolo. Tutti sapevano che ad Abu Grahib
si torturavao i prigionieri. Tutti sapevano e sanno che ci sono decine,
forse centinaia di carceri segrete in giro per il mondo dove la tortura
è pratica comune.
Eppure, ancora oggi, mentre negli Usa si
riflette sulle proprie colpe e sugli errori di una banda di delinquenti
e di assassini che ha portato il mondo così vicino alla rovina, nella
periferia più scalcinata dell'impero - cioé a casa nostra - c'è ancora
chi dice di vedere nel governo statunitense un prezioso alleato. Di più,
un amico. Di più, un modello da cui trarre ispirazione.
Io di mio, amici così non ne vorrei.
Una crisi nel
vuoto
Galapagos
Il capitalismo globale se la passa
male e, per l'ex presidente della Fed Alan Greenspan, quella attuale
è la peggiore crisi del dopoguerra. Ma in Italia nessuno sembra
accorgesene. Basta guardare i programmi elettorali. Il comunismo non
sarà all'ordine del giorno, ma in questa fase di crisi di sistema
c'è un vuoto di idee e proposte.
Circa 90 anni fa Rosa Luxemburg fece una analisi straordinaria di
quella fase di globalizzazione, dell'apertura ai mercati di
approvvigionamento di materie prime da parte dei paesi
industrializzati e della creazione di mercati di sbocco per la
sovraproduzione degli stessi paesi. Negli ultimi anni la situazione
si è modificata: i paesi emergenti sono diventati, oltre a un enorme
serbatoio di domanda, un fornitore straordinario di prodotti per i
paesi del primo mondo. A questo punto la contraddizione della
sovraproduzione si è riprodotta.
Con una aggravante: mentre ai tempi dell'Urss il proletario
occidentale beneficiava (con il boom dello stato sociale) dei
vantaggi della guerra fredda, da anni con l'Urss sparita, lo stato
sociale si è progressivamente ridotto, fino quasi ad annullarsi in
alcuni paesi nei quali (come gli Usa) regge solo un po' di
flexsecurity sotto forma di sussidi di disoccupazione. La crisi
attuale nasce proprio dal trionfo della globalizzazione e del
liberismo. E non a caso il primo paese nel quale è esplosa sono gli
Stati uniti, mentre per ora - a fatica - la vecchia Europa regge.
Collateralmente è esplosa la crisi della finanza che dovrebbe
garantire tra l'altro - con i fondi pensione - anche il futuro di
centinaia di milioni di persone. Negli ultimi 10 anni la finanza
creativa ha conosciuto - senza controlli - un autentico boom: il
giro d'affari che movimenta è centinaia di volte superiore al Pil
mondiale. Lo è praticamente esentasse con un meccanismo diabolico
che consente con pochi spicci di muovere miliardi. La finanza esalta
il ciclo economico: quando le cose vanno bene le fa andare ancora
meglio, ma quando qualcosa non va, l'economia reale subisce
contraccolpi micidiali. Di organismi di controllo ne esistono decine
(dalla banche centrali, alle varie autorità tipo la Sec e la Consob)
ma la speculazione è andata liscia, negli ultimi anni ha fatto
quello che voleva e i risultati sono ora sotto gli occhi di tutti.
Insomma, parlare di finanza, significa parlare - più o meno
direttamente - di economia reale, della vita delle persone costrette
ad accettare i mutui subprime a tassi altissimi per poter comprarsi
casa. Senza contare che la crisi della finanza porterà un vecchiaia
grama per una moltitudine di futuri pensionati.
Ma torniamo ai programmi e alla politica: si può anche abolire (Berlusconi)
l'Ici sulla prima casa, si può ridurre (Veltroni) la pressione
fiscale ai lavoratori dipendenti. Ma è inutile se dalla crisi
attuale non si matura un'ipotesi «riformista»: questo mondo com'è, è
destinato ad andare sempre peggio se non si mettono al primo posto i
bisogni fondamentali dei più e non si rilancia un'ipotesi di
controllo della produzione e della distribuzione del reddito.

Marco Poggi, infermiere penitenziario,
era in servizio in quei tre giorni
Il racconto al pm e un libro sulla vicenda: "Quegli uomini dovevano essere
sospesi"
"Io, l'infame della caserma
che ha denunciato quelle torture"
di GIUSEPPE D'AVANZO

Marco Poggi
MARCO Poggi, infermiere
penitenziario, entrò in servizio a Bolzaneto alle 20 di venerdì 20 luglio
2001 e ci rimase fino alle 15, 15.30 di domenica 22 luglio. "Ho visto
picchiare con violenza e ripetutamente i detenuti presenti con schiaffi,
pugni, calci, testate contro il muro". "Picchiava la polizia di stato ma
soprattutto il "gruppo operativo mobile" e il "nucleo traduzioni" della
polizia penitenziaria. Ho visto trascinare un detenuto in bagno, da tre o
quattro agenti della "penitenziaria". Gli dicevano: "Devi pisciare, vero?".
Una volta arrivati nell'androne del bagno, ho sentito che lo sottoponevano a
un vero e proprio linciaggio...".
Marco Poggi dice che sa che cos'è la violenza. "Ci sono cresciuto dentro. Ho
"rubato" la terza elementare ai corsi serali delle 150 ore e sono andato
infermiere in carcere per buscarmi il mio pezzo di pane. Per anni ho
lavorato al carcere della Dozza a Bologna. Un posto mica da ridere. Tossici,
ladri di galline, mafiosi, trans, stupratori. La violenza la respiravi come
aria, ma quel che ho visto a Bolzaneto in quei giorni non l'avrei mai
ritenuto possibile, prima. Alcuni detenuti non capivano come fare le
flessioni di routine previste dalla perquisizione di primo ingresso in
carcere. Meno capivano e più venivano picchiati a pugni e calci dagli agenti
della polizia penitenziaria. Gli ufficiali, i sottufficiali guardavano,
ridevano e non intervenivano. Ho visto il medico, vestito con tuta mimetica,
anfibi, maglietta blu con stampato sopra il distintivo degli agenti della
polizia penitenziaria, togliere un piercing dal naso di una ragazza che era
in quel momento sottoposta a visita medica e intanto le diceva: "Sei una
brigatista?"".
Marco Poggi è "l'infame di Bolzaneto". Così lo chiamavano alcuni agenti
della "penitenziaria" e lui, in risposta, per provocazione, per orgoglio,
per sfida, proprio in quel modo - Io, l'infame di Bolzaneto - ha voluto
titolare il libro che raccoglie la sua testimonianza. Poggi è stato il primo
- tra chi era dall'altra parte - a sentire il dovere di rompere il cerchio
del silenzio. "Delle violenze nelle strade di Genova - dice - c'erano le
immagini, le foto, i filmati. Tutto è avvenuto alla luce del sole. A
Bolzaneto, no. Le violenze, le torture si sono consumate dietro le mura di
una caserma, in uno spazio chiuso e protetto, in un ambiente che prometteva
impunità. Solo chi l'ha visto, poteva raccontarlo. Solo chi c'era poteva
confermare che il racconto di quei ragazzi vittime delle violenze era
autentico. Io ero tra quelli. Che dovevo fare, allora? Dopo che sono tornato
a casa da Genova, per giorni me ne sono stato zitto, anche con i miei. Io
sono un pavido, dico sempre. Ma in quei giorni avevo come un dolore al
petto, un sapore di amaro nella bocca quando ascoltavo il bla bla bla dei
ministri, le menzogne, la noncuranza e infine le accuse contro quei ragazzi.
Non ho studiato - l'ho detto - ma la mia famiglia mi ha insegnato il senso
della giustizia. Non ho la fortuna di credere in Dio, ho la fortuna di
credere in questa cosa - nella giustizia - e allora mi sono ripetuto che non
potevo fare anch'io scena muta come stavano facendo tutti gli altri che
erano con me, accanto a me e avevano visto che quel che io avevo visto. Ne
ho parlato con i miei e loro mi hanno detto che dovevo fare ciò che credevo
giusto perché mi sarebbero stati sempre accanto. E l'ho fatta, la cosa
giusta. Interrogato dal magistrato, ho detto quel che avevo visto e non ci
ho messo coraggio, come mi dicono ora esagerando. Non sono matto. Ci ho
messo, credo, soltanto l'ossequio per lo stato, il rispetto per il mio
lavoro e per gli agenti della polizia carceraria - e sono la stragrande
maggioranza - che non menano le mani".
Marco Poggi ha pagato il prezzo della sua testimonianza. "Beh! - dice - un
po' sì, devo dirlo. Dopo la testimonianza, in carcere mi hanno consigliato -
vivamente, per dire così - di lasciare il lavoro. Dicevano che quel posto
per me non era più sicuro. Qualcuno si è divertito con la mia auto,
rovinandomela. Qualche altro mi ha spedito la mia foto con su scritto: "Te
la faremo pagare". Il medico con la mimetica e gli anfibi mi ha denunciato
per calunnia. Ma il giudice ha archiviato la mia posizione e con il lavoro
mi sono arrangiato con contratti part-time in case di riposo per anziani.
Oggi, anche se molti continuano a preoccuparsi della mia integrità più di
quanto faccia solitamente la mia famiglia, sono tornato a lavorare in
carcere, allo psichiatrico di Castelfranco Emilia. Mi faccio 160 chilometri
al giorno, ma va bene così. Sono tutti gentili con me, l'infame di Bolzaneto".
Dice Marco Poggi che "se i reati non ci sono - se la tortura non è ancora un
reato - non è che te li puoi inventare". Dice che lui "lo sapeva fin
dall'inizio che poi le condanne sarebbero state miti e magari cancellate con
la prescrizione". Dice Poggi che però "quel che conta non è la vendetta. La
vendetta è sempre oscena. Il direttore del carcere di Bologna Chirolli - una
gran brava persona che mi ha insegnato molte cose sul mio lavoro - ci
ripeteva sempre che lo Stato ha il dovere di punire e mai il diritto di
vendicarsi. Mi sembra che sia una frase da tenere sempre a mente. Voglio
dire che importanza ha che quelli di Bolzaneto, i picchiatori, non andranno
in carcere? Non è che uno voglia vederli per forza in gabbia. La loro
detenzione potrebbe apparire oggi soltanto una vendetta, mi pare. Quel che
conta è che siano puniti e che la loro punizione sia monito per altri che,
come loro, hanno la tentazione di abusare dell'autorità che hanno in quel
luogo nascosto e chiuso che è il carcere, la questura, la caserma. Per come
la penso io, la debolezza di questa storia non è nel carcere che quelli non
faranno, ma nella sanzione amministrativa che non hanno ancora avuto e che
non avranno mai. Che ci vuole a sospenderli da servizio? Non dico per molto.
Per una settimana. Per segnare con un buco nero la loro carriera
professionale. È questa la mia amarezza: vedere i De Gennaro, i Canterini, i
Toccafondi al loro posto, spesso più prestigioso del passato, come se a
Genova non fosse accaduto nulla. Io credo che bisogna espellere dal corpo
sano i virus della malattia e ricordarsi che qualsiasi corpo si può ammalare
se non è assistito con attenzione. Quella piccola minoranza di poliziotti,
carabinieri, agenti di polizia penitenziaria, medici che è si abbandonata
alle torture di Bolzaneto è il virus che minaccia il corpo sano. Sono i loro
comportamenti che hanno creato e possono creare, se impuniti, sfiducia nelle
istituzioni, diffidenza per lo Stato. Possono trasformare gli uomini in
divisa - tutti, i moltissimi buoni e i pochissimi cattivi - in nemici del
cittadino. Non ci vuole molto a comprendere - lo capisco anch'io e non ho
studiato - che soltanto se si fa giustizia si potrà restituire alle vittime
di Genova, ai giovani che vanno in strada per manifestare le loro idee,
fiducia nella democrazia e non rancore e frustrazione. I giudici fanno il
loro lavoro, ma devono fare i conti con quel che c'è scritto nei codici, con
quel che viene fuori dai processi. Non parlo soltanto dei processi, è
chiaro. Parlo della responsabilità della politica. Che cosa ha fatto la
politica per sanare le ferite di Genova? Gianfranco Fini, che era al governo
in quei giorni, disse che, se fossero emerse delle responsabilità, sarebbero
state severamente punite. Perché non ne parla più, ora che quelle
responsabilità sono alla luce del sole? Perché Luciano Violante si oppose
alla commissione parlamentare d'inchiesta? Dopo sette anni questa pagina
nera rischia di chiudersi con una notizia di cronaca che dà conto di una
sentenza di condanna, peraltro inefficace, senza che la politica abbia fatto
alcuno sforzo per riconciliare lo Stato e le istituzioni con i suoi giovani.
Ecco quel che penso, e temo".
Oggi la caserma non è più quella di allora: cancellati i "luoghi
della vergogna"
Manganellate, minacce, umiliazioni: tutto ricostruito al processo da più di
300 testimoni
Le violenze impunite
del lager Bolzaneto

di GIUSEPPE D'AVANZO
C'ERA anche un carabiniere "buono", quel giorno. Molti "prigionieri" lo
ricordano. "Giovanissimo". Più o meno ventenne, forse "di leva". Altri
l'hanno in mente con qualche anno in più. In tre giorni di "sospensione dei
diritti umani", ci sono stati dunque al più due uomini compassionevoli a
Bolzaneto, tra decine e decine di poliziotti, carabinieri, guardie di
custodia, poliziotti carcerari, generali, ufficiali, vicequestori, medici e
infermieri dell'amministrazione penitenziaria. Appena poteva, il carabiniere
"buono" diceva ai "prigionieri" di abbassare le braccia, di levare la faccia
dal muro, di sedersi. Distribuiva la bottiglia dell'acqua, se ne aveva una a
disposizione. Il ristoro durava qualche minuto. Il primo ufficiale di
passaggio sgridava con durezza il carabiniere tontolone e di buon cuore, e
la tortura dei prigionieri riprendeva.
Tortura. Non è una formula impropria o sovrattono. Due anni di processo a
Genova hanno documentato - contro i 45 imputati - che cosa è accaduto a
Bolzaneto, nella caserma Nino Bixio del reparto mobile della polizia di
Stato nei giorni del G8, tra venerdì 20 e domenica 22 luglio 2001, a 55
"fermati" e 252 arrestati. Uomini e donne. Vecchi e giovani. Ragazzi e
ragazze. Un minorenne. Di ogni nazionalità e occupazione; spagnoli, greci,
francesi, tedeschi, svizzeri, inglesi, neozelandesi, tre statunitensi, un
lituano.
Studenti soprattutto e disoccupati, impiegati, operai, ma anche
professionisti di ogni genere (un avvocato, un giornalista...). I pubblici
ministeri Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati hanno detto,
nella loro requisitoria, che "soltanto un criterio prudenziale" impedisce di
parlare di tortura. Certo, "alla tortura si è andato molto vicini", ma
l'accusa si è dovuta dichiarare impotente a tradurre in reato e pena le
responsabilità che hanno documentato con la testimonianza delle 326 persone
ascoltate in aula.
Il reato di tortura in Italia non c'è, non esiste. Il Parlamento non ha
trovato mai il tempo - né avvertito il dovere in venti anni - di adeguare il
nostro codice al diritto internazionale dei diritti umani, alla Convenzione
dell'Onu contro la tortura, ratificata dal nostro Paese nel 1988. Esistono
soltanto reatucci d'uso corrente da gettare in faccia agli imputati: l'abuso
di ufficio, l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, la violenza
privata. Pene dai sei mesi ai tre anni che ricadono nell'indulto (nessuna
detenzione, quindi) e colpe che, tra dieci mesi (gennaio 2009), saranno
prescritte (i tempi della prescrizione sono determinati con la pena prevista
dal reato).
Come una goccia sul vetro, penosamente, le violenze di Bolzaneto
scivoleranno via con una sostanziale impunità e, quel che è peggio, possono
non lasciare né un segno visibile nel discorso pubblico né, contro i
colpevoli, alcun provvedimento delle amministrazioni coinvolte in quella
vergogna. Il vuoto legislativo consentirà a tutti di dimenticare che la
tortura non è cosa "degli altri", di quelli che pensiamo essere "peggio di
noi". Quel "buco" ci permetterà di trascurare che la tortura ci può
appartenere. Che - per tre giorni - ci è già appartenuta.
Nella prima Magna Carta - 1225 - c'era scritto: "Nessun uomo libero sarà
arrestato, imprigionato, spossessato della sua indipendenza, messo fuori
legge, esiliato, molestato in qualsiasi modo e noi non metteremo mano su di
lui se non in virtù di un giudizio dei suoi pari e secondo la legge del
paese". Nella nostra Costituzione, 1947, all'articolo 13 si legge: "La
libertà personale è inviolabile. È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà"
La caserma di Bolzaneto oggi non è più quella di ieri. Con un'accorta
gestione, si sono voluti cancellare i "luoghi della vergogna", modificarne
anche gli spazi, aprire le porte alla città, alle autorità cittadine,
civili, militari, religiose coltivando l'idea di farne un "Centro della
Memoria" a ricordo delle vittime dei soprusi. C'è un campo da gioco nel
cortile dove, disposti su due file, i "carcerieri" accompagnavano l'arrivo
dei detenuti con sputi, insulti, ceffoni, calci, filastrocche come "Chi è lo
Stato? La polizia! Chi è il capo? Mussolini!", cori di "Benvenuti ad
Auschwitz".
Dov'era il famigerato "ufficio matricole" c'è ora una cappella inaugurata
dal cardinale Tarcisio Bertone e nei corridoi, dove nel 2001 risuonavano
grida come "Morte agli ebrei!", ha trovato posto una biblioteca intitolata a
Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume italiana, ucciso nel campo di
concentramento di Dachau per aver salvato la vita a 5000 ebrei.
Quel giorno, era venerdì 20 luglio, l'ambiente è diverso e il clima di
piombo. Dopo il cancello e l'ampio cortile, i prigionieri sono sospinti
verso il corpo di fabbrica che ospita la palestra. Ci sono tre o quattro
scalini e un corridoio centrale lungo cinquanta metri. È qui il garage
Olimpo. Sul corridoio si aprono tre stanze, una sulla sinistra, due sulla
destra, un solo bagno. Si è identificati e fotografati. Si è costretti a
firmare un prestampato che attesta di non aver voluto chiamare la famiglia,
avvertire un avvocato. O il consolato, se stranieri (agli stranieri non si
offre la traduzione del testo).
A una donna, che protesta e non vuole firmare, è mostrata la foto dei figli.
Le viene detto: "Allora, non li vuoi vedere tanto presto...". A un'altra che
invoca i suoi diritti, le tagliano ciocche di capelli. Anche H. T. chiede
l'avvocato. Minacciano di "tagliarle la gola". M. D. si ritrova di fronte un
agente della sua città. Le parla in dialetto. Le chiede dove abita. Le dice:
"Vengo a trovarti, sai". Poi, si è accompagnati in infermeria dove i medici
devono accertare se i detenuti hanno o meno bisogno di cure ospedaliere. In
un angolo si è, prima, perquisiti - gli oggetti strappati via a forza,
gettati in terra - e denudati dopo. Nudi, si è costretti a fare delle
flessioni "per accertare la presenza di oggetti nelle cavità".
Nessuno sa ancora dire quanti sono stati i "prigionieri" di quei tre giorni
e i numeri che si raccolgono - 55 "fermati", 252 "arrestati" - sono
approssimativi. Meno imprecisi i "tempi di permanenza nella struttura".
Dodici ore in media per chi ha avuto la "fortuna" di entrarvi il venerdì.
Sabato la prigionia "media" - prima del trasferimento nelle carceri di
Alessandria, Pavia, Vercelli, Voghera - è durata venti ore. Diventate
trentatré la domenica quando nella notte tra 1.30 e le 3.00 arrivano quelli
della Diaz, contrassegnati all'ingresso nel cortile con un segno di
pennarello rosso (o verde) sulla guancia.
È saltato fuori durante il processo che la polizia penitenziaria ha un gergo
per definire le "posizioni vessatorie di stazionamento o di attesa". La
"posizione del cigno" - in piedi, gambe divaricate, braccia alzate, faccia
al muro - è inflitta nel cortile per ore, nel caldo di quei giorni,
nell'attesa di poter entrare "alla matricola". Superati gli scalini
dell'atrio, bisogna ancora attendere nelle celle e nella palestra con
varianti della "posizione" peggiori, se possibile. In ginocchio contro il
muro con i polsi ammanettati con laccetti dietro la schiena o nella
"posizione della ballerina", in punta di piedi.
Nelle celle, tutti sono picchiati. Manganellate ai fianchi. Schiaffi alla
testa. La testa spinta contro il muro. Tutti sono insultati: alle donne
gridato "entro stasera vi scoperemo tutte"; agli uomini, "sei un gay o un
comunista?" Altri sono stati costretti a latrare come cani o ragliare come
asini; a urlare: "viva il duce", "viva la polizia penitenziaria". C'è chi
viene picchiato con stracci bagnati; chi sui genitali con un salame, mentre
steso sulla schiena è costretto a tenere le gambe aperte e in alto: G. ne
ricaverà un "trauma testicolare". C'è chi subisce lo spruzzo del gas
urticante-asfissiante. Chi patisce lo spappolamento della milza. A.
D. arriva nello stanzone con una frattura al piede. Non riesce a stare nella
"posizione della ballerina". Lo picchiano con manganello. Gli fratturano le
costole. Sviene. Quando ritorna in sé e si lamenta, lo minacciano "di
rompergli anche l'altro piede". Poi, gli innaffiano il viso con gas
urticante mentre gli gridano. "Comunista di merda". C'è chi ricorda un
ragazzo poliomielitico che implora gli aguzzini di "non picchiarlo sulla
gamba buona". I. M. T. lo arrestano alla Diaz. Gli viene messo in testa un
berrettino con una falce e un pene al posto del martello. Ogni volta che
prova a toglierselo, lo picchiano. B. B. è in piedi.
Gli sbattono la testa contro la grata della finestra. Lo denudano. Gli
ordinano di fare dieci flessioni e intanto, mentre lo picchiano ancora, un
carabiniere gli grida: "Ti piace il manganello, vuoi provarne uno?". S. D.
lo percuotono "con strizzate ai testicoli e colpi ai piedi". A. F. viene
schiacciata contro un muro. Le gridano: "Troia, devi fare pompini a tutti",
"Ora vi portiamo nei furgoni e vi stupriamo tutte". S. P. viene condotto in
un'altra stanza, deserta. Lo costringono a denudarsi. Lo mettono in
posizione fetale e, da questa posizione, lo obbligano a fare una trentina di
salti mentre due agenti della polizia penitenziaria lo schiaffeggiano. J. H.
viene picchiato e insultato con sgambetti e sputi nel corridoio. Alla
perquisizione, è costretto a spogliarsi nudo e "a sollevare il pene
mostrandolo agli agenti seduti alla scrivania". J. S., lo ustionano con un
accendino.
Ogni trasferimento ha la sua "posizione vessatoria di transito", con la
testa schiacciata verso il basso, in alcuni casi con la pressione degli
agenti sulla testa, o camminando curvi con le mani tese dietro la schiena.
Il passaggio nel corridoio è un supplizio, una forca caudina. C'è un doppia
fila di divise grigio-verdi e blu. Si viene percossi, minacciati.
In infermeria non va meglio. È in infermeria che avvengono le doppie
perquisizioni, una della polizia di Stato, l'altra della polizia
penitenziaria. I detenuti sono spogliati. Le donne sono costrette a restare
a lungo nude dinanzi a cinque, sei agenti della polizia penitenziaria.
Dinanzi a loro, sghignazzanti, si svolgono tutte le operazioni. Umilianti.
Ricorda il pubblico ministero: "I piercing venivano rimossi in maniera
brutale. Una ragazza è stata costretta a rimuovere il suo piercing vaginale
con le mestruazioni dinanzi a quattro, cinque persone". Durante la visita si
sprecano le battute offensive, le risate, gli scherni.
P. B., operaio di Brescia, lo minacciano di sodomizzazione. Durante la
perquisizione gli trovano un preservativo. Gli dicono: "E che te ne fai,
tanto i comunisti sono tutti froci". Poi un'agente donna gli si avvicina e
gli dice: "È carino però, me lo farei". Le donne, in infermeria, sono
costrette a restare nude per un tempo superiore al necessario e obbligate a
girare su se stesse per tre o quattro volte. Il peggio avviene nell'unico
bagno con cesso alla turca, trasformato in sala di tortura e terrore. La
porta del cubicolo è aperta e i prigionieri devono sbrigare i bisogni
dinanzi all'accompagnatore. Che sono spesso più d'uno e ne approfittano per
"divertirsi" un po'.
Umiliano i malcapitati, le malcapitate. Alcune donne hanno bisogno di
assorbenti. Per tutta risposta viene lanciata della carta da giornale
appallottolata. M., una donna avanti con gli anni, strappa una maglietta,
"arrangiandosi così". A. K. ha una mascella rotta. L'accompagnano in bagno.
Mentre è accovacciata, la spingono in terra. E. P. viene percossa nel breve
tragitto nel corridoio, dalla cella al bagno, dopo che le hanno chiesto "se
è incinta". Nel bagno, la insultano ("troia", "puttana"), le schiacciano la
testa nel cesso, le dicono: "Che bel culo che hai", "Ti piace il
manganello".
Chi è nello stanzone osserva il ritorno di chi è stato in bagno. Tutti
piangono, alcuni hanno ferite che prima non avevano. Molti rinunciano allora
a chiedere di poter raggiungere il cesso. Se la fanno sotto, lì, nelle
celle, nella palestra. Saranno però picchiati in infermeria perché "puzzano"
dinanzi a medici che non muovono un'obiezione. Anche il medico che dirige le
operazioni il venerdì è stato "strattonato e spinto".
Il giorno dopo, per farsi riconoscere, arriva con il pantalone della
mimetica, la maglietta della polizia penitenziaria, la pistola nella
cintura, gli anfibi ai piedi, guanti di pelle nera con cui farà poi il suo
lavoro liquidando i prigionieri visitati con "questo è pronto per la
gabbia". Nel suo lavoro, come gli altri, non indosserà mai il camice bianco.
È il medico che organizza una personale collezione di "trofei" con gli
oggetti strappati ai "prigionieri": monili, anelli, orecchini, "indumenti
particolari". È il medico che deve curare L. K.
A L. K. hanno spruzzato sul viso del gas urticante. Vomita sangue. Sviene.
Rinviene sul lettino con la maschera ad ossigeno. Stanno preparando
un'iniezione. Chiede: "Che cos'è?". Il medico risponde: "Non ti fidi di me?
E allora vai a morire in cella!". G. A. si stava facendo medicare al San
Martino le ferite riportate in via Tolemaide quando lo trasferiscono a
Bolzaneto. All'arrivo, lo picchiano contro un muretto. Gli agenti sono
adrenalinici. Dicono che c'è un carabiniere morto. Un poliziotto gli prende
allora la mano. Ne divarica le dita con due mani. Tira. Tira dai due lati.
Gli spacca la mano in due "fino all'osso". G. A. sviene. Rinviene in
infermeria. Un medico gli ricuce la mano senza anestesia. G. A. ha molto
dolore. Chiede "qualcosa". Gli danno uno straccio da mordere. Il medico gli
dice di non urlare.
Per i pubblici ministeri, "i medici erano consapevoli di quanto stava
accadendo, erano in grado di valutare la gravità dei fatti e hanno omesso di
intervenire pur potendolo fare, hanno permesso che quel trattamento inumano
e degradante continuasse in infermeria".
Non c'è ancora un esito per questo processo (arriverà alla vigilia
dell'estate). La sentenza definirà le responsabilità personali e le pene per
chi sarà condannato. I fatti ricostruiti dal dibattimento, però, non sono
più controversi. Sono accertati, documentati, provati. E raccontano che, per
tre giorni, la nostra democrazia ha superato quella sempre sottile ma
indistruttibile linea di confine che protegge la dignità della persona e i
suoi diritti. È un'osservazione che già dovrebbe inquietare se non fosse che
- ha ragione Marco Revelli a stupirsene - l'indifferenza dell'opinione
pubblica, l'apatia del ceto politico, la noncuranza delle amministrazioni
pubbliche che si sono macchiate di quei crimini appaiono, se possibile,
ancora più minacciose delle torture di Bolzaneto.
Possono davvero dimenticare - le istituzioni dello Stato,
chi le governa, chi ne è governato - che per settantadue ore, in una caserma
diventata lager, il corpo e la "dimensione dell'umano" di 307 uomini e donne
sono stati sequestrati, umiliati, violentati? Possiamo davvero far finta di
niente e tirare avanti senza un fiato, come se i nostri vizi non fossero
ciclici e non si ripetessero sempre "con lo stesso cinismo, la medesima
indifferenza per l'etica, con l'identica allergia alla coerenza"?
|
La protesta dell'idrante |
|
Antincendio 'non a norma': chiusa l'Università Europea di
San Pietroburgo |
 |
Prosegue l'attacco del
Cremlino alle istituzioni culturali finanziate dall'Occidente.
L'università europea di San Pietroburgo è stata costretta, ormai un
mese fa, a sospendere gli insegnamenti dopo che le autorità
cittadine hanno riscontrato che il sistema antincendio 'non era a
norma'. Un palese pretesto per attaccare un'istituzione accademica
rinomata e autorevole ma, purtroppo, finanziata dall'Occidente.
 Campagna
digitale. Campagna
digitale. La strenua battaglia che accademici e
studenti stanno combattendo contro la decisione ha colto
letteralmente di sorpresa il Cremlino. Oltre alle consuete
proteste per strada, con picchetti e manifestazioni di fronte
all'università, professori e studenti hanno lanciato una
massiccia campagna in internet. Ilya Utekhin, docente di
antropologia, ha postato i suoi video in un blog per documentare
le attività di protesta. Nei video, girati il 29 febbraio e il 7
marzo, sono ripresi gli studenti che - per farsi beffe
dell'assurdo pretesto - hanno portato un idrante dall'edificio
universitario fino alla statua dello scienziato Michail
Lomonosov ( http://www.fontanka.ru/2008/02/29/031/),
considerato il padre dell'istruzione superiore in Russia.
 Nelle
mani occidentali. Nelle
mani occidentali. Lo scorso anno l'università aveva
accettato 673 mila euro dall'Unione Europea per un progetto di
'consulenza' ai partiti politici russi in vista delle elezioni.
La finalità del progetto era informare i partiti su come
garantire che le elezioni si svolgessero correttamente. A
ottobre Putin sferrò un attacco al vetriolo contro l'Università
Europea, accusandola di essere un'agente degli 'intrallazzi
occidentali'. Alla fine di gennaio, il Consiglio accademico fu
costretto a piegarsi alle pressioni del Cremlino e dovette
abbandonare il progetto. Nel corso dei suoi due mandati, l'ex
presidente russo ha lanciato numerosi attacchi contro
organizzazioni non governative, gruppi per la tutela dei diritti
umani, piccoli partiti di opposizione: tutti accusati di essere
strumenti occidentali e traditori del loro Paese.
 Video-burla. Video-burla.
Fino ad oggi, il settore dell'istruzione universitaria era stato
ignorato dalla mano pesante del regime, e gli accademici avevano
un certo grado di autonomia nell'insegnamento, nella selezione
degli studenti e nella ricerca. Adesso, neanche le università
sono più un'eccezione. Ma a San Pietroburgo gli universitari e i
loro professori hanno continuato ad alimentare la protesta per
tutto il mese, soprattutto sul blog. Un altro video mostra il
rettore dell'istituto, Boris Vakhtin, che si burla delle
motivazioni che hanno portato alla chiusura: "La cosa più
eclatante - spiega il rettore - è che l'ateneo avrebbe
acconsentito alla costruzione di una scala a chiocciola che
ostruisce le uscite antincendio. Forse non si sono accorti che
la scala è stata costruita nel 1881".
|
|
|
I vescovi italiani dicono che non
si schierano, ma poi promuovono il test dei valori per l'elettore
cattolico contro vecchi e nuovi diritti di libertà. E' l'ultima ed
inaccettabile ingerenza La Cei precetta il voto cattolico
Contro donne,
gay e unioni civili
Anubi D'Avossa Lussurgiu
Ieri il consiglio permanente della
Conferenza episcopale italiana ha diramato un comunicato. Vi si
legge che, non potendosi certo ammettere una «diaspora culturale dei
cattolici», essi debbono adoprarsi contro il «rischio di scelte
politiche e legislative che contraddicono fondamentali valori e
principi antropologici ed etici radicati nella natura dell'essere
umano, in particolare riguardo alla tutela della vita umana in tutte
le sue fasi e alla promozione della famiglia fondata sul
matrimonio». Precisamente «evitando di introdurre nell'ordinamento
pubblico altre forme di unione che contribuirebbero a
destabilizzarla».
Dunque, i vescovi di Santa Romana Chiesa Cattolica e Apostolica
hanno trovato il modo di rivendicare in piena campagna elettorale il
blocco di ogni riconoscimento delle unioni di fatto. E non sfugge
all'indirizzo lanciato dai vescovi all'elettorato l'insieme di
questioni che vanno sotto l'apodittico titolo di «tutela della vita
umana», così rivendicando altri ostruzionismi ottenuti nel
Parlamento uscente (e nel governo): come quelli che hanno bloccato
ogni iniziativa di superamento della legge 40 sulla "procreazione
assisistita" e ogni accenno di testamento biologico.
Né si frena l'offensiva reazionaria contro la libertà delle donne, a
partire da quella di scelta sulla maternità. Al punto che il
segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Betori ha elargito
questa luminosa sentenza: «Il no netto all'aborto da sempre ha fatto
la differenza, per i cristiani, rispetto alla società». Addirittura
«dal primo secolo». E pensare si credeva una certa differenza
«rispetto alla società» l'avessero stabilitea piuttosto le
Beatitudini di Gesù di Nazareth...
Ma Betori fa sul serio e giunge a citare «le ruote» dei conventi
dove si accoglievano i neonati delle madri povere e/o "reiette": per
lui «hanno espresso e possono esprimere ancora oggi un modo per
venire incontro alle esigenze delle donne». Esigenze che,
evidentemente, sono ben chiare al sacerdozio maschile cattolico.
Tutto questo, però, è servito al monsignore ad uno scopo ben più
prosaico. Poter dire cioè che la Curia dubita che «il problema
dell'aborto possa essere risolto solo in chiave sociale, sia con una
legge, sia attraverso espressioni politiche». E che però «tutto può
essere d'aiuto per pronunciare un no all'aborto, in questo momento».
Pur velata e vescovilmente paludata, è finalmente giunta l'agognata
benedizione attesa da Giuliano Ferrara per la sua lista.
Ora: visto che notoriamente l'ingerenza delle gerarchie d'oltretevere
nelle decisioni della Repubblica è uno «spettro» del «vetero-laicismo»,
ci si dovrà pur stupire della spettralità della politica dominante.
Perché solo silenzi e plausi sono venuti, oltre che dall'Udc, sia
dal Pdl sia dal Pd. Ad allarmarsi, oltre il solito e meritevole
Grillini, è solo la sinistra: con il solo segretario del Prc, Franco
Giordano, a parlare di «precettazione» del «mondo cattolico» e di
«tentativo di condizionare pesantemente le scelte dello Stato
laico». Che per gli altri, forse, non merita più di un Amen.
17 marzo
Chi paga i
partiti
di Primo Di Nicola e Marco Lillo
I milioni di Forza Italia a Dc,
Mussolini e De Gregorio. I fondi ai ministri di Prodi. Le lobby
trasversali e le coop. Tutta la politica euro per euro
Alla faccia della gratitudine. Il
ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani alla vigilia
della storica decisione sulla cessione di Alitalia se ne è uscito
con un sorprendente assist alla compagnia Air France concorrente
dell'abruzzese volante Carlo Toto: "L'italianità non è
indispensabile". Ci deve essere rimasto davvero male il patron di
Air One ripensando a quel bell'assegno da 40 mila euro staccato a
favore del futuro ministro durante la campagna elettorale del 2006.
Sperava di aver trovato in Bersani un paladino dei suoi interessi
imprenditoriali, ne ha ricavato invece una cocente delusione.
Ben diverso il comportamento di Roberto Ulivi, deputato di An,
farmacista di professione, che ha incassato 10 mila euro proprio
dalla Federazione nazionale dei titolari di farmacie (Federfarma) e
altri 8 mila dalle associazioni territoriali di Firenze e Pistoia.
Lui in difesa della categoria che lo aveva finanziato si è battuto
come un leone, con interrogazioni e interventi contro le
liberalizzazioni avviate dallo stesso Bersani per consentire la
vendita di medicinali nei supermercati. "Ma quale liberalizzazione,
questa è una cambiale pagata alla grande distribuzione", ha tuonato
Ulivi, "in modo particolare alle Coop". Sospetti esagerati? Sta di
fatto che proprio dalle cooperative Bersani riceve altri lauti
finanziamenti: 35 mila euro dalla bolognese Manutencoop e 49 mila
dal Consorzio nazionale servizi, sempre di Bologna.
Ecco le sorprese che spuntano sfogliando la documentazione relativa
ai finanziamenti concessi da privati e aziende a uomini politici e
partiti dal primo gennaio del 2006 a oggi, compresi quelli per la
campagna elettorale di due anni fa. Esaminando queste carte è
possibile ricostruire una mappa dei legami tra politici e
imprenditori e comprendere meglio quali lobby si muovono talvolta
dietro le scelte legislative e di governo. Non solo: quell'archivio
di sigle e numeri custodito con tanta riservatezza dagli uffici del
Parlamento (che non ne rilascia copia informatica a nessuno) aiuta a
capire meglio anche i rapporti economici che corrono tra le diverse
forze politiche.
Forza nani
Il tesoro che i partiti italiani si
spartiscono è rappresentato anzitutto dalla pioggia dei rimborsi
elettorali, introdotti nonostante il 90 per cento degli italiani,
con il referendum del 1993, si sia dichiarato contrario al
finanziamento pubblico dei partiti. Partecipa all'abbuffata solo chi
ha superato la soglia dell'1 per cento alle elezioni e riceve un
rimborso proporzionale ai voti ricevuti: 1 euro per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali. Complessivamente fanno 50 milioni
di euro all'anno per la Camera e altrettanti per il Senato. Una
legislatura costa circa 500 milioni di euro.
E chi non ha partecipato con il proprio simbolo alle elezioni,
dissolvendosi magari in liste più ampie per superare le soglie di
sbarramento? Come si finanziano questi piccoli partiti? Ci pensano i
grandi. Emblematico il caso di Forza Italia, che negli ultimi due
anni ha foraggiato Azione sociale, il movimento fondato da
Alessandra Mussolini nel 2004, dopo che Fini aveva definito il nonno
Benito "il male assoluto del XX secolo". In due anni la Mussolini ha
avuto dal Cavaliere ben 673 mila euro.
Non basta: il partito di Berlusconi ha finanziato anche la
Democrazia cristiana di Gianfranco Rotondi (220 mila euro); la
Federazione dei Verdi Verdi (130 mila) apparentata alla Casa delle
libertà per togliere voti agli ambientalisti di Alfonso Pecoraro
Scanio; il Nuovo Psi di Gianni De Michelis (2 milioni di euro); il
Partito repubblicano di Francesco Nucara (90 mila euro); i
Riformatori liberali di Benedetto Della Vedova (450 mila) e gli
Italiani nel mondo (700 mila euro). Il movimento del senatore Sergio
De Gregorio, eletto con l'Italia dei valori di Di Pietro, è passato
al centrodestra con in mano un contratto nel quale Forza Italia si
impegnava a fornire sostegno economico.
I big spender
In questo clima da campagna acquisti è inevitabile che qualcuno
maligni di fronte al contributo versato al partito di Lamberto Dini
da un amico di Paolo Berlusconi. Si chiama Davide Cincotti e la
scorsa estate era ospite nella villa del Berluschino in Costa
Smeralda. Quando in autunno Dini inizia a flirtare con il Cavaliere
in vista dell'approdo nel centrodestra, improvvisamente Cincotti
scopre la sua passione per Rinnovamento Italiano. Al partito di Dini
questo imprenditore di Battipaglia con interessi in Sardegna, dove
sta per costruire un porticciolo alla Maddalena, tra dicembre e
gennaio versa ben 295 mila euro. Niente male se si pensa che nella
classifica dei donatori-imprenditori Cincotti è battuto solo da
Giovanni Arvedi, il re dell'acciaio cremonese che ha donato a Fi 300
mila euro nel novembre scorso. E che ora annuncia a 'L'espresso':
"Ho appena versato altri 300 mila euro al Partito democratico per
essere equidistante".
Lobby inossidabile
Gli imprenditori dell'acciaio sono poco popolari nel Paese per la
dura condizione delle fabbriche e i frequenti incidenti sul lavoro,
ma sono amatissimi nel Palazzo dove cercano una sponda in entrambi
gli schieramenti. La piemontese Tubosider e la ligure Transider
hanno finanziato Fi rispettivamente con 50 mila e 75 mila euro,
Umberto Bossi ha ricevuto un piccolo contributo dalla Oiki di Parma,
mentre il gruppo Riva, mediante le due controllate Riva Fire e Ilva,
ha dato a Forza Italia ben 245 mila euro e altri 98 mila al solito
Bersani. Il ministro dello Sviluppo economico è un asso pigliatutto:
per la campagna elettorale del 2006 da solo ha collezionato oltre
480 mila euro di contributi. Più del doppio di Marco Minniti, altra
star del partito, che ha avuto come primo finanziatore la società
Leat del gruppo Vitrociset con 50 mila euro.
Finanziatori bipartisan
L'associazione di categoria Federacciai è "attentissima", come
recita lo statuto, "a promuovere le politiche economiche volte a
risolvere le criticità del settore" e per questo ha finanziato
ecumenicamente quasi tutti gli ultimi titolari del dicastero delle
Attività produttive (che prima si chiamava Industria e ora Sviluppo
economico). A Bersani ha dato 50 mila euro; stessa cifra all'ex
viceministro di destra Adolfo Urso, mentre al predecessore di
entrambi, Enrico Letta, ora sottosegretario a Palazzo Chigi, sono
andati 30 mila euro.
Altro assertore della tattica dell''equivicinanza' è Carlo Toto: il
patron di Air One sa bene che per volare sicuro c'è bisogno di
oliare sia l'ala sinistra che quella destra. Così, dopo avere
finanziato Bersani, Minniti (30 mila euro) e il dipietrista Egidio
Pedrini (5 mila) ha pensato bene di mettersi al sicuro anche con Fi,
alla quale ha elargito 50 mila euro. Cifre più modeste, ma identica
filosofia, per l'associazione dei produttori delle macchine utensili
Ucimu (5 mila a Bersani, altrettanti a Urso) e per il Comitato
nazionale caccia e natura, che finanzia Bersani con 15 mila euro ma
non dimentica il solito Urso (12 mila) e nemmeno il berlusconiano
Carlo Giovanardi, destinatario di altri 5 mila euro.
Finanziatori faziosi
Chi non teme di lasciare trasparire le proprie simpatie sono invece
i farmacisti di Federfarma: oltre a Ulivi di An finanziano infatti
anche Guido Crosetto di Fi (5 mila) e Maurizio Gasparri di An (10
mila). Al massimo i farmacisti si spingono ad aiutare (con 5 mila
euro) un moderato di centrosinistra come Giuseppe Astorre dell'Idv.
Decisamente orientato a sinistra invece il gruppo immobiliare Romeo.
La società che ha gestito buona parte delle cartolarizzazioni delle
case pubbliche e che ha vinto la maxi gara per tappare le buche
stradali di Roma, predilige gli ex diessini, da Gianni Cuperlo a
Umberto Ranieri, e Silvio Sircana, il portavoce di Romano Prodi. La
cifra non è da capogiro, appena 5 mila euro a testa, e diventa
ancora più piccina se confrontata con quella stanziata da
FrancescoGaetano Caltagirone, costruttore ed editore del 'Messaggero',
che riserva le sue elargizioni esclusivamente all'Udc, il partito di
Pier Ferdinando Casini, marito della figlia Azzurra.
In due anni la famiglia Caltagirone ha regalato alla creatura del
leader centrista 900 mila euro, frazionando i versamenti in nove
tranche da 100 mila. Hanno contribuito nell'ordine Francesco,
Gaetano, Francesco Gaetano e la moglie Luisa Farinon più cinque
società del gruppo. Una potenza di fuoco che l'ex compagno di
partito, Marco Follini, si sogna. Anche se pure lui ha un
immobiliarista nella manica: il gruppo Statuto, mediante la società
Colli Aminei ha donato al transfuga dall'Udc al Pd ben 70 mila euro.
Finanziatori organici
Ci sono poi gli imprenditori e i professionisti prestati alla
politica che foraggiano il proprio partito. Il secondo finanziatore
dell'Udc è per esempio l'europarlamentare Vito Bonsignore.
Democristiano di lungo corso, poi imprenditore con il pallino delle
autostrade, Bonsignore ha versato 220 mila euro all'Udc del Lazio e
del Piemonte, più altri 250 mila nelle casse nazionali mediante la
sua finanziaria Mec, che ha pagato anche i voli del suo padrone
politico: dal primo febbraio al 31 dicembre del 2007 Bonsignore ha
totalizzato voli per 200 mila euro, poco meno di mille euro al
giorno.
Altrettanto munifica è stata la radicale Cecilia Maria Angioletti,
commercialista e amministratrice delle società del partito che ha
versato 121 mila euro alla Rosa nel pugno e altri 236 mila alla
Lista Pannella. L'associazione Iniziativa subalpina dell'avvocato
Michele Vietti ha finanziato l'Udc piemontese con 159 mila euro,
mentre l'avvocato Angelo Piazza ha pagato 142 mila euro al suo
partito, lo Sdi. L'imprenditore Sergio Abramo, ex sindaco di
Catanzaro per Forza Italia e candidato alla presidenza della Regione
senza successo, ha versato a Fi 50 mila euro mediante la società di
famiglia Sqa. Generoso si rivela pure Giuseppe Mussari, presidente
del Monte Paschi di Siena, diessino di lungo corso e finanziatore
dei Ds cittadini con 160 mila euro.
Contributi off shore
La palma del finanziamento più misterioso spetta invece a Maurizio
Gasparri. L'ex ministro delle Comunicazioni nell'ultima campagna
elettorale ha dichiarato un introito dalla Svizzera di 19 mila e 900
euro dalla società Satyricon Services. "È un versamento della
società telefonica israeliana Telit", spiega Gasparri che aggiunge:
"Sono in ottimi rapporti con loro e mi hanno anche nominato nel
board. Non conosco la Satyricon, ma penso l'abbiano usata per
logiche interne al gruppo". Tra i finanziatori di Gasparri si
contano pure gli amici Alessandro Iachia e Maurizio Momi, produttori
di una fiction per la Rai dal titolo politicamente coerente: 'La
fiamma nel ghiaccio'.
Ignazio La Russa
Il suo collega Ignazio La Russa invece ne ha avuti 15 mila da
Tosinvest. Anche l'Udc ha un finanziatore misterioso: la
lussemburghese Energex Engineering. Nel 2006 ha speso 77 mila euro
per mettere a disposizione dell'Udc voli gratis. E nel 2002 ne aveva
pagati altri 251 mila per la stessa causale. L'ufficio stampa del
partito non sa chi sia il padrone di questa società né chi abbia
usato i suoi servigi.
Tutte le Autostrade portano a Roma
Le società più generose sono le concessionarie autostradali. I
manager non dimenticano che il futuro dei loro bilanci dipende dalle
tariffe che saranno fissate tra qualche anno, quando magari al
governo potrebbe esserci chi oggi è all'opposizione. Per questo
l'approccio alla politica è assolutamente bipartisan. Autostrade del
gruppo Benetton ha finanziato con 150 mila euro ciascuno Margherita,
Ds, Fi, An, Udc, Lega e persino il Comitato per Prodi 2006, mentre
Mastella si è dovuto accontentare di 50 mila. Per non essere da meno
il concorrente dei Benetton, Marcellino Gavio, ha finanziato con
diverse società del suo gruppo sia Prodi (100 mila euro), sia Forza
Italia (50 mila euro) senza trascurare l'Udc: 100 mila euro.
Diamoci all'ippica
Un'altra lobby molto potente e ricca è quella dei pronostici e delle
scommesse. Anche se i finanziamenti ai politici dichiarati in
Parlamento sono esigui. Per quanto riguarda l'ippica, la Snai
finanzia con 10 mila euro l'Udc e con 150 mila euro la Margherita.
Una brusca caduta di stile si registra invece esaminando la lista
dei finanziatori per la campagna 2006 compilata dal ministro delle
Politiche agricole Paolo De Castro, destinatario di un versamento di
10 mila euro da parte della Torinese corse cavalli. Dov'è il
problema? Nel fatto che la società ippica ha tra i suoi soci i
familiari di Guido Melzi d'Eril, nell'autunno 2006 nominato dallo
stesso ministro commissario straordinario dell'Unire, l'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine.
Udeur a sorpresa
Tra i finanziatori di Clemente Mastella spicca Diego Della Valle,
che ha dato 150 mila euro al suo amico di Ceppaloni. A dire il vero,
dopo un'iniziale incertezza tra Diego e Andrea, il contributo è
stato registrato a nome del fratello. Della Valle ha finanziato
praticamente tutto il centro, versando 150 mila euro anche a
Margherita e Udc. Mastella ha ricevuto anche due finanziamenti
inattesi. Il primo viene dalla Mec del solito Vito Bonsignore (50
mila euro), europarlamentare Udc. Il secondo dalla Romed spa di
Carlo De Benedetti: l'editore di questo giornale ha donato, a titolo
personale, 25 mila euro al leader Udeur. Due sono invece i
finanziatori che spiccano tra i pochi dichiarati da Antonio Di
Pietro per la sua Idv: la Media Cisco srl (15 mila euro) di Pierino
Tulli e i 40 mila euro dell'ex presidente del Treviso calcio, Ettore
Setten.
Interessi Radicali
Piccolo giallo per un finanziamento del 2006 alla Rosa nel pugno
dall'associazione Luca Coscioni. Che ci fa l'organismo che dovrebbe
battersi per la libertà della ricerca scientifica tra i finanziatori
dei partiti? La spiegazione sta inun prestito di un milione e mezzo
di euro chiesto due anni fa da Emma Bonino e Marco Pannella
all'amico americano George Soros per fondare la Rosa nel pugno. Il
magnate e filantropo divise a metà il prestito tra l'associazione
Coscioni e i Radicali italiani. Entrambi inoltrarono alla Rosa nel
pugno due contributi da 650 mila euro. Soldi tornati indietro nei
mesi successivi con gli interessi quando, incassati i rimborsi
elettorali, la Rosa nel pugno ha rimpinguato i bilanci dell'universo
pannelliano riversando denaro non solo alla Coscioni e ai Radicali
italiani (500 mila euro ciascuno), ma anche al Partito radicale (100
mila) e al Partito radicale transnazionale (572 mila).
ha collaborato Francesca Schianchi
Ha vinto la monnezza
di Gianluca Di Feo e Claudio Pappaianni
Dopo due mesi i rifiuti ricominciano a crescere. E De Gennaro ha
dovuto abbandonare il suo piano. Ecco perché il prefetto senza
superpoteri rischia di fallire
Talquale. Questo eloquente eufemismo indica l'immondizia che nessuno
riesce più a selezionare in Campania: il termine, indicato persino
nei contratti, sembra anche il destino che minaccia la Campania.
Perché tale e quale è la situazione in cui sta precipitando la
regione dopo 60 giorni di Gianni De Gennaro: la montagna dei
sacchi neri ha ripreso a crescere. Un disastro che rischia
di segnare la prima sconfitta per l'ex capo della polizia, alle
prese con un mostro: per la prima volta nella sua storia personale
si comincia a parlare di fallimento.
Dal 3 marzo tutte le soluzioni escogitate finora dal prefetto hanno
cominciato a perdere colpi: la Germania ha bloccato i treni,
i lavoratori dei Cdr si fermano a singhiozzo, la pioggia ha
rallentato i cantieri delle nuove discariche. In più sono
intervenuti i vigili urbani di Acerra, che su ordine del sindaco
controllano tutti i camion dell'immondizia e li multano per ogni
piccola infrazione, ingorgando l'unica rotta per lo smaltimento. Una
farsa incredibile: pochi vigili che mettono in crisi il super
commissario. Ma non è l'unica, perché di super-poteri in realtà De
Gennaro ne ha veramente pochi. Non può precettare, non può
obbligare, non ha nemmeno fondi da spendere: ai suoi ordini
direttamente c'è soltanto il battaglione dell'Esercito. Per tutto il
resto deve chiedere ad altri e bussare alle porte di Palazzo Chigi,
dove Romano Prodi ha già la testa altrove.
UNO E TRINO De Gennaro non ha nemmeno il pieno
controllo della situazione dei rifiuti. Perché i commissari
di governo che operano in questo settore sono ben tre.
L'ex capo della polizia deve gestire l'emergenza,
pulire le strade e trovare dove mettere la spazzatura. Poi c'è il
commissario liquidatore, che deve chiudere le
precedenti strutture: a lui tocca domare i Cdr, le fabbriche
infernali dove si compattano i carichi per trasformarli in ecoballe.
Il problema è che in questi impianti strategici tutto è precario:
dipendenti, forniture, manutenzione, mense, tute, persino la
pulizia. Nel tentativo virtuoso di eliminare gli sprechi del
passato, molti contratti sono stati revocati mentre in altri casi lo
Stato è in ritardo sui pagamenti. I dipendenti, poi, spesso
incrociano le braccia o sono obbligati a fermare le macchine: ogni
ora persa significa lasciare 300 tonnellate a marcire. Infine il
liquidatore deve trovare qualcuno che compri e completi il mostro di
Acerra, ormai degradato per decreto da termovalorizzatore ad
inceneritore. Una missione titanica. Il primo nome scelto dal
governo, un generale della Finanza, si è tirato indietro. A quel
punto l'incarico è finito a Goffredo Sottile, che come prefetto di
Caserta ha imparato a conoscere la materia.
Ma c'è una terza figura fondamentale: il commissario
alle bonifiche, ossia colui che doveva disinnescare
tutte le discariche create nei precedenti 14 anni di emergenza,
trasformando le bombe chimiche in pascoli. Una struttura che agisce
in modo autonomo, parallelo e in almeno un caso conflittuale con le
altre due. Alla fine di gennaio l'incarico era ancora in mano ad
Antonio Bassolino, che ha gestito dal 2001 stanziamenti per 300
milioni, Bagnoli inclusa. Ma dopo le prime indagini di De Gennaro,
Prodi ha subito rimpiazzato il governatore con Massimo Mengozzo, un
esperto della Regione. Perché l'ex capo della polizia ha capito a
sue spese che senza bonifiche non ci possono essere nuovi spazi per
versare i rifiuti. Ci ha messo 40 giorni, poi è stato costretto a
rottamare il piano presentato in pompa magna: i siti che risultavano
ripuliti a suon di milioni invece erano ancora colmi di veleni.
"Guai ad avvicinarsi alle vecchie discariche", ha sentenziato con
amarezza in un'intervista a 'Repubblica'.
CARTE FALSE Che le cose andassero peggio del
previsto De Gennaro lo ha scoperto in un lampo. L'illusione
sul piano è svanita poche ore dopo la conferenza stampa del 21
gennaio. All'alba i tecnici del Commissariato si sono
presentati in un capannone industriale di Pianura, destinato ad
accogliere una catasta di ecoballe. Una mossa politica: dopo gli
scontri con la polizia per la discarica, si voleva dimostrare che lo
Stato non faceva dietrofront e portava comunque dei rifiuti in quel
comune. Nei dossier del Commissariato quel capannone risultava vuoto
e sotto sequestro, insomma pronto all'uso: in realtà la pattuglia
del prefetto è stata accolta dal metronotte di turno, che vigilava
sulle sette aziende con 80 operai legalmente attive nell'impianto.
Il bello è che già un anno prima gli emissari del Commissariato lo
avevano ispezionato. Con un brivido, il prefetto ha compreso: il suo
piano era stato costruito su carte inattendibili. Aveva mosso armate
che non esistevano ed era finito in laghi di veleni, muovendosi
verso lo scontro popolazioni senza più fiducia nelle istituzioni. La
sua manovra prevedeva di riaprire in 7-10 giorni quattro vecchie
discariche 'bonificate' (Villaricca, Difesa Grande, Montesarchio e
Parapoti come riserva) dove infilare di corsa gran parte degli
arretrati. Il resto, circa 200 mila tonnellate, doveva finire in 11
siti provvisori in attesa di una soluzione definitiva. Ossia i
quattro nuovi maxidepositi (Serre, Savignano, Terzigno, Sant'Arcangelo)
che in realtà sarebbero dovuti nascere già nel luglio 2007 ma dove i
cantieri non erano mai partiti. Un piano da 900 mila tonnellate,
ingoiando 10 mila tonnellate al giorno: 7.200 di produzione
quotidiana, più una fetta del giacente. L'immondizia sarebbe sparita
da metà marzo: il miracolo di De Gennaro. Che nemmeno il Gennaro
santo avrebbe potuto realizzare: nel primo mese quota 10 mila è
stata toccata solo 5 volte.
INDIETRO TUTTA L'ex capo della polizia ha lottato
per andare avanti: "Dico no al gioco dell'oca, il piano è
perfettibile ma non si può sempre tornare alla casella di partenza",
ha insistito il 30 gennaio. Il bollettino di guerra ora dopo ora è
diventato drammatico: nelle vecchie discariche spuntavano giacimenti
mefitici. È stata dissepolta dal terreno persino un'intera
autocisterna piena di liquami tossici. Risvegliare quei mostri
significava perdere tempo prezioso. A San Valentino la resa:
bisogna trovare un'altra rotta. Quale? L'estero. Portare tutto
l'arretrato in Germania, ben 200 mila tonnellate via mare
fino ai porti del Baltico: un'alternativa costosa. E finora
impraticabile. Perché i tedeschi da dieci giorni rifiutano anche
quelle 700 tonnellate quotidiane che facevano respirare Napoli. E il
loro nein rischia di riaprire il baratro: fino ad allora erano state
spostate 329 mila tonnellate, dimezzando la montagna di 250 mila che
sommergeva tutto a metà gennaio. Adesso tecnici del prefetto e
militari corrono da un sito all'altro, cercando di impedire la
paralisi. Sfruttano al massimo i centri di stoccaggio creati dai
mezzi dell'Esercito. Ogni giorno 1.700 tonnellate vengono portate ad
Acerra, pesate e messe nel magazzino di Italambiente. Da lì la Fibe
li trasloca a Santa Maria la Fossa, dove sono pesate di nuovo e
gettate a Ferrandelle: tutto doppio, processione di camion e costi.
SOTTO IL TAPPETO Ma senza nuove discariche è come
nascondere la polvere sotto il tappeto. L'unico vero
impianto, quello di Serre, corre verso l'esaurimento.
Taverna del Re, riaperta dopo l'intervento personale di De Gennaro
ha chiuso mentre Marigliano che doveva rimpiazzarla non è ancora
pronta. Nel gioco delle quattro discariche, risuscita anche il
'vulcano cattivo' di Somma Vesuviana: nel 2005 era quasi pieno di
rifiuti quando un incendio lo svuotò tra nuvole tossiche. I nuovi
maxi siti di Savignano e Sant'Arcangelo non apriranno prima di un
mese, ammesso che arrivino i soldi. Sperando che non scoppi il
caldo: per adesso non si temono epidemie, quanto l'invasione dei
ratti e insetti. Spetterebbe ai comuni e alle Asl intervenire anche
solo spargendo disinfettante e topicida. Ma nessuno fa nulla.
De Gennaro non vuole gettare la spugna: "Di rifiuti
ce ne sono fin troppi...". Dicono lo faccia per senso dello Stato e
per una questione personale. Ma prima di lui, anche un duro come
Guido Bertolaso dovette arrendersi. E se falliscono gli unici
funzionari credibili di cui lo Stato dispone, chi mai potrà ripulire
la Campania?
ha collaborato Piero Messina
|
All'ombra di una
stessa bandiera |
|
Reportage dal Kurdistan turco, dove si finisce ancora in
carcere se si scrive in curdo. |
 |
|
scritto da
Nicola Sessa
Gli orologi nei corridoi del tribunale di Diyarbakir sono quasi
tutti fermi. Nessuno di questi segna l’ora esatta. Il giudice
Nhuan Ayaci aspetta nella sua aula al terzo piano; indossa un
collare ortopedico e la sua figura assume forme rigide. Il
volto, al pari della Sfinge, non rilascia emozioni. Accanto,
siede la pubblica accusa che, se non fosse per un impercettibile
movimento degli occhi, sembrerebbe di pietra. Alle loro spalle
campeggia il motto “La giustizia è fondamento dello Stato”. Gli
imputati sono in numero superiore a quanti ne possa contenere il
banco e la stessa aula. Ventuno persone accusate di aver
attentato alla “turchità” della Repubblica. L’articolo 222 del
codice penale lo prevede; il sindaco della municipalità di Sur,
Abdullah Demirbas, con tutto il consiglio, lo ha violato nel
momento in cui, il sei ottobre del 2006, ha deliberato di
produrre una brochure esplicativa dei servizi del comune in
quattro lingue. Le quattro lingue che da uno studio risultavano
essere le più parlate: il curdo, il siriano, il turco, l’arabo.
Scrivere in curdo è reato: l’intera amministrazione di Sur, più
il sindaco di Diyarbakir, che ha espresso solidarietà al suo
omologo, rischia una condanna a quattro anni di reclusione. Nel
frattempo il prefetto ha provveduto a sollevarli dalle loro
mansioni.
 All’interno
dei cinque chilometri di mura che abbracciano la città di
Diyarbakir vivono ufficialmente 350.000 persone, a grandissima
maggioranza curda, ma se si esce fuori dai bastioni la
popolazione si quintuplica: un milione di profughi arrivati da
tutto il Kurdistan a Diyarbakir, antica Amed, capitale di un
paese che non esiste (più) sulle carte ufficiali. Il 74 percento
della popolazione parla il curdo, moltissimi non conoscono la
lingua turca, solo la lingua madre. Sono più di quattromila i
villaggi evacuati o dati alle fiamme dalle forze turche perché
ritenuti collegati alla guerriglia combattuta dal Pkk.
La questione curda è da anni la grande preoccupazione della
Turchia. Risolverla vorrebbe dire risolvere non soltanto
intrecci di politica interna, ma anche problemi di affari
esteri, soprattutto con l’Unione Europea. Il modo di affrontare
la questione non piace a molti intellettuali turchi, non piace
ai curdi che pure vorrebbero vederla risolta. I tentativi di
soluzione inciampano in una continua violazione dei diritti
umani.
Il governo turco intende procedere a una assimilazione della
popolazione curda, nonostante le parole pronunciate da Erdogan
in Germania per incitare i turchi a integrarsi con i tedeschi ma
non ad assimilarsi; i curdi vogliono vedere riconosciuta loro
una identità culturale e linguistica.
 Secondo
Ali Akiaci, presidente di Ihd - associazione che si occupa della
tutela di diritti umani -, in Turchia c’è una vera e propria
emergenza democratica. In seguito all’invasione turca nel Nord
Iraq la popolazione del Kurdistan si è messa in moto: in ogni
città ci sono state pacifiche marce di protesta; le associazioni
civili, le assemblee degli avvocati hanno convocato conferenze
stampa per denunciare la violazione del diritto internazionale.
A seguito della manifestazione del 25 febbraio, solo a
Diyarbakir sono state arrestate 40 persone. Parte di queste
hanno denunciato all’Ihd di aver subito torture: gli ultimi due
arrivati erano una donna con il volto livido e un ragazzo di
appena sedici anni a cui era stato spezzato un braccio.
|
|
Sulle ali della menzogna |
|
Heathrow,
il contestato progetto per l'ampliamento |
 |
| Con la
costruzione di una terza pista all'aeroporto londinese di Heathrow
la Gran Bretagna potrebbe rinunciare definitivamente alla sua lotta
contro i cambiamenti climatici.
 Il
rapporto 'aggiustato' Il
rapporto 'aggiustato'. Nei primi mesi del 2007, il
destino del progetto sembrava segnato: una ricerca - non resa
pubblica - commissionata dal governo aveva infatti evidenziato
che l'espansione dell'aeroporto avrebbe provocato un impatto
tale da superare di gran lunga le soglie di inquinamento
acustico e ambientale fissate dal ministero per l'Ambiente.
Risultati poco incoraggianti soprattutto per il dirigente del
Dipartimento dei Trasporti (DfT), David Gray. Questi aveva
infatti il compito di mostrare all'opinione pubblica come la
terza pista non avrebbe avuto conseguenze troppo onerose in
termini di squilibrio ecologico, o almeno non troppo gravi da
vanificare l'ambizioso piano di lotta all'inquinamento che il
Primo ministro Gordon Brown va sbandierando ad ogni incontro sul
clima al quale partecipi.
 Come
aggirare il problema? Come
aggirare il problema? Trasmettere (in via del tutto
confidenziale) al Baa, l'ente di gestione dell'aeroporto, i
risultati del rapporto. Il Baa avrebbe scritto al Dipartimento
dei Trasporti esortandolo a riconsiderare la valutazione di
impatto ambientale sulla base di 'nuove acquisizioni'. Un
aggiustamento qua e uno là, finalmente governo e Baa approdano
al risultato finale. "Gli sforzi congiunti di entrambi -
scriveva il Times nella sua edizione domenicale - hanno avuto
come risultato il tentativo di far passare l'idea che un nuovo
aeroporto delle dimensioni di Gatwick può essere tranquillamente
aggiunto a Heathrow senza alcun impatto ambientale".
 Anti-pista. Anti-pista.
In un momento in cui milioni di persone a livello globale stanno
esprimendo la necessità di cambiamenti climatici urgenti, ma
soprattutto in un momento in cui Gordon Brown si fa paladino di
queste richieste, propagandando ovunque il suo piano per la
lotta globale all'inquinamento, le betoniere stanno già
preparando a sputare chilometri di asfalto per la nuova pista di
Heathrow e gli scarichi degli aerei tonnellate di ossido di
carbonio che - a detta del governo - avranno un impatto solo
'minimo' sul sistema ecologico britannico. Per bloccare il
progetto, gli ambientalisti stanno preparando picchetti
nell'area interessata, e più di 10 mila persone sono attese alla
manifestazione che si terrà a Heathrow il 31 maggio prossimo.
Luca Galassi
|
Tiro al canguro
|
|
L'Australia vuole sopprimere 400 canguri che vivono in
un'ex base militare. Proteste degli animalisti |
 |
|
Per riconquistare una ex base militare ora in mano a
un nemico che continua a moltiplicare le sue forze,
il governo australiano è pronto a lanciare
un'offensiva a colpi di armi chimiche. Ma molti
australiani non sono d'accordo e sono pronti a fare
da scudi umani, chiedendo una soluzione diplomatica
alla crisi. Dall'altra parte non giungono però
proposte alternative. E come potrebbero, dato che il
nemico da sterminare è una colonia di canguri,
destinata a essere decimata con un'iniezione letale
di massa, che sta provocando la reazione compatta
dei gruppi animalisti.
 Il
piano. Il
piano. Le autorità di Canberra vogliono
sopprimere 400 canguri sui circa 500 che vivono
nell'area attorno alla dismessa stazione di
trasmissione navale di Belconnen, proprio nella
capitale. Secondo il governo, l'eccessivo numero di
canguri a pascolo nella zona mette a rischio altre
specie animali, tra cui un tipo di lucertola e di
falena. Un piano per spostare i marsupiali in
un'altra regione, come proposto dagli animalisti, è
stato bocciato dal governo in quanto “inumano”.
Così, questo fine settimana gli animali dovrebbero
venire soppressi, dopo essere stati addormentati con
dei sonniferi sparati a distanza. L'idea di un tiro
a segno con proiettili veri è stata scartata per i
rischi di colpire i residenti delle case
circostanti, o i dimostranti che si dovessero
opporre al piano.
Le reazioni. “Programmi come questi, se
amministrati in modo umano, sono a volte necessari”,
ha detto il ministro per l'ambiente Peter Garrett.
Ma gli attivisti per i diritti degli animali hanno
intenzione di bloccare il massacro, incatenandosi ai
cancelli della Belconnen Station. “Da sabato saremo
lì 24 ore su 24”, ha annunciato Pat O'Brien,
presidente della Wildlife Protection Association
of Australia. Secondo gli attivisti, i canguri
da sopprimere sono inoltre già fatti soffrire
inutilmente perché tenuti lontani dalle fonti
d'acqua dove si abbeverano, per colpa di una rete
provvisoria installata dalle autorità. Un gruppo
animalista britannico, Viva!, si è unito alla
battaglia grazie anche al sostegno di Paul McCartney,
che in un messaggio video ha parlato del “bisogno
urgente di proteggere i canguri da una barbara
industria che li massacra per la loro carne e la
loro pelle”.
 Un
commercio mondiale. Un
commercio mondiale. Il piano era stato ideato un
anno fa dall'allora governo conservatore di John
Howard, ma le proteste degli animalisti avevano
fatto rinviare la sua esecuzione. In un precedente
simile, nel 2004, l'Australia provocò uno scandalo
internazionale decidendo di sparare a 900 canguri
vicino a una diga che rifornisce d'acqua la
capitale. Anche in quella occasione, il motivo era
l'erosione del terreno causata dal pascolo selvaggio
degli animali. Ma lontano dai riflettori, ogni anno
in Australia sono milioni i canguri uccisi per
motivi commerciali. “La carne è venduta come cibo
per cani ed esportata, specialmente in Francia,
Germania e Russia”, ha spiegato O'Brien.
|
|
|
|
|
Pakistan, bombe sui
civili |
|
I villaggi pashtun
sotto i colpi delle artiglierie statunitense e
pachistana |
 |
|
La popolazione civile delle aree tribali pachistane
continua a morire sotto le bombe della guerra al
terrorismo. Solo ieri, almeno sedici civili, tra cui
donne e bambini, sono rimasti uccisi in due distinti
bombardamenti di artiglieria condotti dall’esercito
statunitense e da quello pachistano
 Kangrai,
Nord Waziristan. Kangrai,
Nord Waziristan. Secondo il capo di Stato
Maggiore pachistano, generale Athar Abbas, cinque
proiettili d’artiglieria sparati dalle forze Usa dal
territorio afgano hanno colpito un’area residenziale
distruggendo una casa e uccidendo due donne e due
bambini. “Abbiamo inoltrato una dura protesta alle
forze della Coalizione al di là del confine”, ha
detto il generale.
Da Kabul gli ha risposto un portavoce delle forze
Usa, il maggiore Chris Belcher, confermando un
attacco “di precisione” condotto un chilometro e
mezzo all’interno del territorio pachistano contro
“un edificio legato alla rete di Sirajuddin Haqqani”,
comandante dei talebani waziri. “Non ho alcuna
informazione sulle vittime dall’operazione”, ha però
aggiunto il maggiore.
 Nawagai,
Bajahur. Nawagai,
Bajahur. Nelle stesse ore, in una zona più
settentrionale delle aree tribali pashtun, un
massiccio bombardamento dell’artiglieria pachistana
ha ucciso almeno dodici civili, tra cui due donne e
un bambino. L’attacco governativo è stato sferrato
in rappresaglia a due imboscate talebane costate la
vita ad alcuni soldati. Questa mattina, gli abitanti
dei villaggi bombardati sono andati nella più vicina
cittadina, Khar, per manifestare contro queste
stragi di civili. In migliaia hanno protestato
scandendo rabbiosi slogan contro il governo
pachistano e contro gli Stati Uniti: “Morte al
traditore Musharraf!”, “Morte all’America!”.
Da quando nel 2004 Musharraf – su pressione di
Washington – ha lanciato la campagna militare
anti-terrorismo nelle aree tribali, sono morte più
di seimila persone, per metà civili.
|
|
|
|
13 marzo
Candidati
Le
figurine della politica
Marco d'Eramo
Nei presepi napoletani di Via San Gregorio Armeno ogni condizione
umana è sempre raffigurata da una sola statuina: la giovane con
l'anfora sulle spalle che torna dalla fonte, il pastore con il
piffero, il fabbro davanti all'incudine, la massaia alacre al
lavatoio. Nelle liste di candidature, la cui presentazione si è
conclusa ieri, il parlamento che uscirà dal voto del 13 aprile si
configura già come presepio postmoderno, di cui ogni deputato è
statuina.
Ecco lì a sinistra «la Giovane»; più in alto «il Manager»; in fondo
«l'Operaio» accanto al «Generale»; nel Transatlantico «il Tassista»,
mentre «il Trentenne» uscito da una pubblicità antiforfora discute
alla buvette con «lo Scienziato» telegenico prestato alla cosa
pubblica (esempi non immaginari). C'è sempre da dubitare quando le
categorie umane si trasformano in singolare maiuscolo. Fa paura
quando gli ebrei diventano l'Ebreo, le donne la Donna. È una visione
da Commedia dell'Arte: il giovin signore, la servetta, la locandiera
e il figaro. Un'idea cristallizzata, stereotipata della società,
come se ogni dirigente politico vedesse ciò che lo circonda solo
attraverso i luoghi comuni di cui è vittima. A lungo andare, una
concezione deleteria del mondo, perché lo riduce alla statica di un
tableau vivant, e si preclude di percepirne la dinamica, i
mutamenti. Ancora più deleteria è l'idea soggiacente di politica.
Queste candidature di «esponenti della società civile» si presentano
come una risposta all'antipolitica, alle accuse di casta. Deputati
non saranno più politici, ma italiani qualunque, il cui anonimato è
garanzia di genuinità: «cittadini veraci».
In realtà questo metodo di candidatura è l'operazione più eversiva
messa in atto negli ultimi anni perché scippa ogni residua sovranità
al popolo sovrano. Cosa faranno in parlamento queste figure se non
appunto le belle statuine? Come oseranno ribellarsi a decisioni
prese altrove? La Giovane si opporrà al leader che l'ha proiettata
alla ribalta? E l'onorevole Operaio dirà no a chi lo ha sottratto
all'indigenza di fabbrica? Non è neanche una riedizione del
corporativismo: lì erano le Corporazioni a scegliere esponenti che
dovevano promuoverne gli interessi. Ma quali interessi esprime la
giovane cooptata come capolista solo per la sua età e per non aver
mai fatto politica? È il più subdolo, buonista attacco alla
democrazia rappresentativa mai visto, un'operazione letteralmente
extraparlamentare, perché il parlamento vi si riduce a raccolta di
figurine da incollare in un album Panini di nuovo tipo: non più
calciatori ma deputati. Pare già di vederli i leader dei partiti
scambiarsele scartando i doppioni: «Ce l'ho; ce l'ho; mi manca».
Per dirla tutta, è perversa l'idea che per fare una politica
favorevole a un certo segmento sociale, bisogna inviare al
parlamento un prototipo di quel segmento. Come la mettiamo coi
bambini? Come si fa a fare una politica a favore dell'infanzia senza
pueri a Montecitorio? Solo un anacronistico limite di età della
nostra anacronistica costituzione vieta di candidare pupetti. Quanto
sarebbero più efficaci manifesti e spot! Non più il candidato che
abbraccia un bimbo, ma un candidato in braccio al leader. E poi, a
elezioni avvenute, immaginate che bello: parlamentari con treccine e
boccoli, da far sbavare un pedofilo. Infine deputate col biberon,
senatori col ciuccio.
Il volo senza slot
di Franco Bernabè
L'aereo di
Vincino (CorrierEconomia di ieri) che gira su Malpensa in attesa
di sapere chi vincerà le elezioni è sintesi perfetta non solo
del caso Alitalia ma delle vicende del nostro intero sistema
paese. La campagna elettorale condotta a colpi di imprenditori
sottrae più che aggiungere, mentre la borsa continua a bastonare
indistintamente, in chiaro segno di confusione. In ballo, o in
volo, c'è un po' di credibilità residua, con la finanza sempre
più slacciata dalla realtà.
La Telecom Italia tornata nelle mani di Franco Bernabè sembra un
altro aereo di Vincino. Ieri il Wall Street Journal ha definito
«saggio» l'amministratore delegato di TI perché ha staccato la
linea alla vecchia gestione basata su allegre finanze e ha
deciso di restituire alla società un ruolo proprio, che è poi
quello di fare il suo mestiere, a partire da un piano
industriale vero. Basta con l'era Tronchetti fatta da dividendi
«a piene mani» agli azionisti, il «saggio» Bernabè non è profeta
in patria: oggi comincia il suo road show in giro per il mondo a
cercare investitori lasciandosi alle spalle una frana di borsa.
Il suo aereo assomiglia un po' a quello di un altro manager cui
da tre anni e mezzo la fortuna arride, Sergio Marchionne.
L'amministratore delegato del gruppo Fiat ha cominciato come
Bernabè, mettendo il silenziatore agli squilli di tromba dei
suoi predecessori (che promettevano sfracelli sul mercato e poi
sfracellavano i bilanci) e cominciando a ricostruire l'azienda.
Gestione, squadra, prodotto, ricerca all'estero di investitori
con cui condividere oneri di sviluppo. Ritorno all'utile,
gloria, eccetera. Ma ora il 2008 si presenta difficile per il
comparto, certo meno difficile del 2004 guidato sull'orlo della
bancarotta, e la borsa che fa? Punisce secco il titolo Fiat.
Tornando a Vincino, di sicuro su quell'aereo non c'è ai comandi
Maurizio Prato, l'amministratore delegato di Alitalia voluto da
Romano Prodi che continua a tenere la cloche dritta verso Air
France, a fronte di una privatizzazione difficile, giunta
all'ultimo slot, che avrà dei costi per quanto riguarda il
lavoro. Il titolo perde, Prato va, benché il cielo sopra sia in
tempesta, con la compagnia arrivata agli ultimi sgoccioli di
carburante finanziario e la politica a spingerlo nei vuoti
d'aria di moratorie per Malpensa e simili.
Atterrare è in italiano un verbo transitivo, che sia questo il
motivo?
Ambiente
Falla nell'oleodotto Nato,
disastro ecologico a Vicenza
Ettolitri di cherosene
si sono riversati nel fiume Bacchiglione (nel vicentino) e in un
torrente vicino. Nell'oleodotto Nato che da Livorno arriva fino a Aviano
è stata scoperta una falla di dimensioni ancora non chiare. Centinaia di
cittadini ieri sera hanno telefonato ai vigili del fuoco per lamentare
forti dolori alla gola, problemi di respirazione e agli occhi. La ditta
che controlla l'oleodotto aveva già registrato ieri mattina un calo di
pressione.
 Sotto-passo
e sovra-prezzo. Così i metodi finanziari più moderni, nati per
realizzare opere pubbliche trasparenti e senza ritardi, sembrano
essere diventati lo strumento per riproporre vecchi vizi. Come
quello dei costi per i cantieri che lievitano di anno in anno,
fino a sfiorare il raddoppio. La lezione arriva da Firenze, che
ha scelto il project financing per una serie di interventi
destinati a cambiare il volto della città. Tra queste il
sottopasso di viale Strozzi pare destinato a diventare un
monumento allo spreco. I costi sono passati da 5 milioni
previsti ad oltre 8, tutti a carico del Comune. Sotto-passo
e sovra-prezzo. Così i metodi finanziari più moderni, nati per
realizzare opere pubbliche trasparenti e senza ritardi, sembrano
essere diventati lo strumento per riproporre vecchi vizi. Come
quello dei costi per i cantieri che lievitano di anno in anno,
fino a sfiorare il raddoppio. La lezione arriva da Firenze, che
ha scelto il project financing per una serie di interventi
destinati a cambiare il volto della città. Tra queste il
sottopasso di viale Strozzi pare destinato a diventare un
monumento allo spreco. I costi sono passati da 5 milioni
previsti ad oltre 8, tutti a carico del Comune.
Secondo gli inquirenti, le spese in molti casi sono state
gonfiate ad arte. La Guardia di Finanza, per esempio, ha
calcolato che per il sottopasso sono state utilizzati 2.416
metri quadrati di pietra pregiata ma ne sono state fatturate al
Comune 2.792. Stessa moltiplicazione virtuale per i cubetti di
porfido. Così si arriva a un sovra-prezzo di 3 milioni 187 mila:
oltre il 60% in più rispetto al contratto.
Le Fiamme Gialle hanno segnalato questa e altre opere urbane
alla Corte dei conti, sostenendo che quei soldi in più non
andassero pagati: una responsabilità che ricadrebbe soprattutto
sull'architetto Gaetano De Benedetto, numero uno della direzione
urbanistica del Comune, ma che in seconda istanza coinvolgerebbe
tutta la giunta di Palazzo Vecchio, sindaco incluso, accusata di
avere pagato i milioni extra senza vigilare. Adesso scende in
campo anche la Procura, che indaga sul sottopasso per il reato
di truffa: quattro persone sono sotto inchiesta, tra loro
l'ingegnere che presiede Firenze Mobilità, designato dal colosso
delle costruzioni Baldassini-Tognozzi-Pontello e che ha un ruolo
in tutte le nuove iniziative urbanistiche cittadine.
|
Bolzaneto, chiesti 76
anni per poliziotti e medici |
|
I pm di Genova: nella caserma
violazioni della Convenzione europea sulla tortura
|
 |
 La
richiesta più pesante è stata quella per Antonio Biagio
Gugliotta, ispettore della polizia penitenziaria: 5 anni, 8 mesi
e 5 giorni di reclusione. Poi quella per Massimo Pigozzi, il
poliziotto accusato di lesioni personali: 3 anni e 11 mesi.
Infine, quella per Giorgio Toccafondi, il medico, accusato di
abuso di atti d'ufficio e diversi episodi di percosse, ingiurie
e violenza privata: 3 anni, 6 mesi e 25 giorni di reclusione.
Sono 76 in totale gli anni di prigione chiesti oggi dai pm
genovesi Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati per 44
dei 45 imputati nel processo per i fatti avvenuti nella caserma
di Bolzaneto durante il G8. Per uno solo degli imputati, il
funzionario di polizia Giuseppe Fornasiere, è stata chiesta
l'assoluzione. La
richiesta più pesante è stata quella per Antonio Biagio
Gugliotta, ispettore della polizia penitenziaria: 5 anni, 8 mesi
e 5 giorni di reclusione. Poi quella per Massimo Pigozzi, il
poliziotto accusato di lesioni personali: 3 anni e 11 mesi.
Infine, quella per Giorgio Toccafondi, il medico, accusato di
abuso di atti d'ufficio e diversi episodi di percosse, ingiurie
e violenza privata: 3 anni, 6 mesi e 25 giorni di reclusione.
Sono 76 in totale gli anni di prigione chiesti oggi dai pm
genovesi Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati per 44
dei 45 imputati nel processo per i fatti avvenuti nella caserma
di Bolzaneto durante il G8. Per uno solo degli imputati, il
funzionario di polizia Giuseppe Fornasiere, è stata chiesta
l'assoluzione.
Inadempienza italiana.
In quella caserma, descritta dai pm nella requisitoria come un
'girone infernale', furono inflitte alle persone fermate "almeno
quattro" delle cinque tecniche di interrogatorio che, secondo la
Corte Europea sui diritti dell'uomo, vengono configurate come
"trattamenti inumani e degradanti". Purtroppo, però, il nostro
Paese, a differenza di altri come Gran Bretagna e Francia, non
ha mai accolto nel proprio ordinamento la Convenzione europea
contro la tortura. Non esistendo, quindi, una norma penale (per
la quale l'Italia è inadempiente rispetto all'obbligo di
adeguare il proprio ordinamento alla convenzione
internazionale), l' accusa è stata costretta a contestare agli
imputati l'articolo 323 (abuso d'ufficio), che comunque sarà
prescritto nel 2009. L'unico reato per cui sono richieste 10
anni per la prescrizione è il falso ideologico. Altri reati
contestati a vario titolo sono: violazione della convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, abuso di autorità nei confronti di persone
arrestate o detenute, minacce, ingiurie, lesioni.
|
|
|
Sale la tensione |
|
Bolivia, è scontro sulla decisione di non far svolgere i
referendum il prossimo 4 maggio |
|
Dopo le
infinite polemiche che hanno accompagnato la
decisione di indire in Bolivia referendum
costituzionali, la corte nazionale elettorale ha
deciso che non “esistono le condizioni tecniche,
operative, legali e politiche per portare avanti il
processo referendario per il prossimo 4 maggio”.
 I
fatti. Dunque, i due
referendum indetti non si svolgeranno. Nel primo
quesito sarebbe stata chiesta al popolo boliviano
l'approvazione della nuova Costituzione. Nel secondo
referendum, altrettanto importante, sarebbe stata
presa in considerazione la proprietà terriera. Il
quesito, infatti, avrebbe dovuto stabilire se le
proprietà terriere dovevano essere inferiori ai 5
mila ettari oppure potevano arrivare fino a 10 mila. I
fatti. Dunque, i due
referendum indetti non si svolgeranno. Nel primo
quesito sarebbe stata chiesta al popolo boliviano
l'approvazione della nuova Costituzione. Nel secondo
referendum, altrettanto importante, sarebbe stata
presa in considerazione la proprietà terriera. Il
quesito, infatti, avrebbe dovuto stabilire se le
proprietà terriere dovevano essere inferiori ai 5
mila ettari oppure potevano arrivare fino a 10 mila.
Secondo
Morales, la nuova carta costituzionale cerca di
“garantire la rifondazione della Bolivia, una
rifondazione democratica che garantisca l'unità, la
dignità e l'uguaglianza di tutti i boliviani”
Ma, dal 9
dicembre scorso, giorno in cui è stata approvata
dall'Assemblea Costituente la nuova Carta Magna, è
iniziato anche un duro braccio di ferro fra Evo
Morales e i governatori di Santa Cruz, Tarija, Pando
e Beni. Fino a giungere alla decisione del Cne di
sospendere i referendum.
 Le
province ricche.
Ricche e industrializzate, le quattro province in
polemica con Morales hanno auto-indetto per il mese
di giugno un referendum per l'approvazione degli
statuti d'autonomia dal governo centrale. Ma anche
in questo caso il Cne ha bloccato il loro
svolgimento. Secondo i giudici, infatti, la
convocazione referendaria da parte dei governatori
delle quattro province non è conforme alla legalità.
La convocazione di elezioni che stabiliscano
l'autonomia o meno di alcune regioni del Paese è di
assoluta competenza del Parlamento e non dei
governatori regionali. Le
province ricche.
Ricche e industrializzate, le quattro province in
polemica con Morales hanno auto-indetto per il mese
di giugno un referendum per l'approvazione degli
statuti d'autonomia dal governo centrale. Ma anche
in questo caso il Cne ha bloccato il loro
svolgimento. Secondo i giudici, infatti, la
convocazione referendaria da parte dei governatori
delle quattro province non è conforme alla legalità.
La convocazione di elezioni che stabiliscano
l'autonomia o meno di alcune regioni del Paese è di
assoluta competenza del Parlamento e non dei
governatori regionali.
Inoltre dal
Cne fanno sapere che la decisione è stata presa in
piena autonomia, senza nessun “calcolo politico” o
“pressione” ma solo "applicando della legge e
principi di imparzialità, autonomia e indipendenza”.
Ma non è difficile intuire che per la Bolivia si
apre una nuova fase politica. Morales invita tutte
le forze al dialogo ma, forse, oggi più che mai le
sue parole non verranno ascoltate.
 Novità.
Intanto, nella notte fra sabato e domenica scorsa,
violenti incidenti fra i sostenitori di Evo Morales
e quelli dei partiti di opposizione si sono
verificati a La Paz. Le strade della città si sono
inizialmente riempite di persone che manifestavano
in favore dei governatori, quando i fedeli di
Morales si sono presentati armati di bastoni e hanno
iniziato ad accusare i prefetti di essere gli stessi
che negli anni passati hanno svenduto le risorse del
Paese alle multinazionali straniere. Novità.
Intanto, nella notte fra sabato e domenica scorsa,
violenti incidenti fra i sostenitori di Evo Morales
e quelli dei partiti di opposizione si sono
verificati a La Paz. Le strade della città si sono
inizialmente riempite di persone che manifestavano
in favore dei governatori, quando i fedeli di
Morales si sono presentati armati di bastoni e hanno
iniziato ad accusare i prefetti di essere gli stessi
che negli anni passati hanno svenduto le risorse del
Paese alle multinazionali straniere.
Immediate
le reazioni da parte dei servizi di sicurezza
boliviani che hanno caricato i manifestanti fedeli a
Morales, lanciando anche diversi lacrimogeni. E' di
alcune decine di feriti lievi il bilancio della
giornata di scontri.
|
|
|
|
10 marzo
Per le autorità ci sono state solo dieci
vittime. Ma c'è chi parla di quattromila morti
La repressione più dura è scattata quando alle proteste si sono
uniti gli studenti
Birmania, nel
monastero della rivolta
'Noi, monaci che sfidammo il regime'
dal nostro inviato DANIELE MASTROGIACOMO
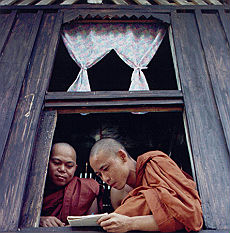
PAKOKKU
- Cinque mesi dopo, restano
ancora le tracce della battaglia. Fuori, lungo i muri di cinta
sbrecciati dalla pallottole; dentro, sui pavimenti in legno
anneriti, nei giardini invasi dalle erbacce, nei bagni
collettivi allagati, nell'infermeria saccheggiata, nelle stanze
dei novizi vuote e sporche. Persino i corridoi, luogo di
meditazione e di lettura, sono occupati dai resti di armadi,
sedie e tavoli ammassati alla rinfusa. Per terra, allineati con
cura in una stanza chiusa a chiave, si sono salvati solo loro: i
libri sacri dello Sangha, la chiesa buddista, e le antiche
pergamena di palma scritte a mano.
Il grande bonzo, il capo spirituale del monastero, è assorto
nella sua lettura. E' solo, al centro del salone al primo piano
dove si tengono le lezioni, disteso su un letto in tek coperto
da un telo rosso scuro. Restiamo in attesa, avvolti da un cupo
senso di desolazione. Il maestro piega il libro. Si mette
seduto, incrocia le gambe, si gira verso di noi, porta le mani
giunte sulla fronte. "Siate i benvenuti", ci dice dopo minuti
che sembrano eterni.
Ma-Gway Taungdwingyi, 84 anni, il viso liscio, lo sguardo
sereno, non aggiunge altro. Osserva il silenzio che il regime
gli ha imposto. Non può dire, come chiunque racconta in
Birmania, che tutto è iniziato qui dentro, in un monastero alla
periferia di Pakokku: un villaggio lontano dalle rotte
turistiche, famoso per il suo tabacco forte e profumato con cui
si confezionano i sigari cheerok, sulle sponde del fiume
Ayeyarwady, cuore della Birmania centrale, oggi chiamata Myanmar.
E' il 16 agosto scorso. Quattro funzionari del governo si
presentano nel collegio di Pakhanngeh Kyaung, il più grande di
tutto il paese, 100 anni di storia, un'immensa struttura che si
regge su 322 pilastri in legno intarsiati. Chiedono di Ma-Gway:
non sono venuti, come fanno molti, per chiedere un consiglio e
lasciare un'offerta. Hanno altro in testa, il maestro è finito
nel mirino della giunta militare. Parla troppo e parla male: del
governo dei militari, di quanto sia profondo il distacco che li
divide dal paese reale. Lo ammoniscono senza molte remore:
"Questo deve essere un luogo di studio e di preghiera, non di
politica".
Lo minacciano in modo brusco: "Smettila di sobillare i tuoi
studenti o ti facciamo sparire". Il grande monaco è paziente.
Usa tutto il suo carisma e la sua influenza. Ricorda che
l'aumento di cinque volte il prezzo della benzina e di tanti
altri beni di prima necessità sta affamando il popolo.
I bonzi lo sanno bene: vivono a stretto contatto con la gente.
La colletta che compiono ogni mattina all'alba, secondo un
rituale di secoli, scalzi, avvolti nelle loro tuniche colorate,
passando di casa in casa, si è interrotta. A Pakokku, davanti
alla ciotola mostrata per raccogliere le offerte, le famiglie
portano la mano alla bocca: non c'è cibo, non ci sono soldi. Il
maestro invita i funzionari a lasciare il monastero. Ma i
quattro emissari insistono; l'ordine è arrestarlo, portarlo via.
Volano parole grosse: la discussione è animata, violenta,
sostiene chi era presente.
Sfidare un monaco, un maestro spirituale, in Birmania è una
grave offesa, una vera provocazione. Decine di novizi, ragazzi
che vivono nel monastero il tempo per studiare i testi sacri del
buddismo e imparare l'inglese, hanno seguito il diverbio. Sono
indignati. Intervengono, come sono sempre intervenuti. Anche
nelle proteste del 1988 sono stati i bonzi più giovani, assieme
agli studenti, ad accendere la miccia della rivolta. Scoppia una
rissa generale. I quattro funzionari lasciano a fatica il
monastero. Ma all'esterno trovano le loro auto in fiamme.
Ma-Gway Taungdwingyi non scenderà nei dettagli e noi eviteremo
domande che non vanno fatte.
Sarà George, la nostra guida di Nyaung U che ci ha accompagnato
sul posto, a dirci cosa è accaduto. Al ritorno, mentre
attraversiamo l'Ayeyarwady a bordo di una lancia, coperti dal
rumore assordante del motore ad elica allungata, ci spiega:
"Adesso posso parlare. Prima non mi fidavo di nessuno. Pakokku è
piena di spie. Le autorità le hanno infiltrate anche tra i
monaci.
La rivolta dell'agosto e settembre scorsi è nata qui dentro.
Dopo l'incendio delle auto dei quattro funzionari del governo,
sono arrivati la polizia e l'esercito. Ma è accorsa anche la
gente del villaggio.
La voce si è sparsa in tutta la regione. Migliaia di persone
sono giunte dai paesi vicini: ne arrivavano ad ondate, con ogni
mezzo, dall'interno e poi con le barche, dall'altra sponda del
fiume. Ci sono stati gli scontri, molti feriti, tantissimi
morti. La gente è rimasta, ha resistito. La protesta si è
allargata a Bagan, a Mandalay, a Yangon. Ventotto giorni di
cortei e manifestazioni.
Fino a quando sono intervenuti i reparti speciali, con i fucili,
le mitragliatrici, lo stato d'assedio, il coprifuoco". Il
monastero resterà isolato e circondato dal filo spinato fino a
Natale.
Oggi il collegio di Pakhanngeh Kyaung è stato riaperto ma sembra
abbandonato: pochi lo frequentano e non ci sono soldi per
restaurare le ferite inferte durante la sommossa. Su 836 monaci
ne sono rimasti solo 174. I pochi che si affacciano, timidi e
preoccupati, evitano ogni contatto. C'è ancora molta diffidenza:
i bonzi sono visti dal regime come un pericolo. In tutta la
Birmania, ce n'erano 400 mila. In dieci anni la giunta, con la
sua "campagna di purificazione", li ha ridotti del 20 per cento.
Il monastero si è svuotato.
Molti sono fuggiti. Forse tornati a casa, forse scomparsi,
morti, inghiottiti nelle carceri. Nessuno sa nulla di loro. Solo
il principio buddista per cui la vita è un continuo ripetersi
può spiegare le contraddizioni di questo paese allegro e insieme
triste, ribelle e rassegnato. Il suo fascino è tutto lì. La
Birmania sembra galleggiare su un tempo indefinito: ancorata al
suo passato glorioso, costretta a vivere un presente drammatico,
proiettata su un futuro che non le appartiene ancora.
La giunta dei militari è rimasta sorpresa dalla rivolta di
Pakokku. Non si aspettava che proprio in questo monastero,
immerso nel cuore dell'etnia bamar, scattasse l'ennesima sfida.
I pericoli, storicamente, arrivano dalle zone che confinano con
Cina, Thailandia, Laos e India, dove sono arroccate le minoranze
più ostili al sogno di una grande Birmania. Occupato dal suo
business, il regime non si era reso conto che l'intero paese
bolliva come un vulcano pronto ad esplodere. Eppure basta
camminare nel centro di Mandalay, 80 chilometri più a nord, per
capire che la "primavera" birmana non è mai finita.
Il sangue versato a settembre sui grandi viali che costeggiano
la maestosa fortezza costruita del re Mindom Min, penultimo
sovrano della dinastia Konbaung, ha scosso dal torpore questa
città adagiata sul privilegio di essere la culla religiosa e
l'ultima capitale del regno prima della dominazione britannica.
Avvolta dal buio dopo il tramonto, punteggiata dai fari dei
motorini e delle biciclette che invadono le strade come sciami,
abbagliata da decine di pagode dalle cupole bianche e i
pennacchi dorati, Mandalay fa i conti con l'ennesimo incendio.
La corrente arriva a singhiozzo.
Il governo la concentra sulle strutture militari. Quando torna,
l'energia è una scarica che brucia gli impianti ridotti ad un
ammasso di fili. Il cortocircuito è inevitabile. La benzina
comprata al mercato nero e tenuta in casa fa il resto. L'anno
scorso, in questo modo, nella sola Mandalay, un milione di
abitanti, sono andate a fuoco 40 mila abitazioni.
Tsa-Tsa, il ragazzo del nostro risciò, si dirige verso la zona
dove adesso si alzano fiamme rosse e gialle. Ha bisogno di
lavorare e si fa coraggio. Sostiene di non mangiare da tre
giorni. C'è da credergli. Nel 2007, secondo una fonte
diplomatica occidentale, ci sono stati solamente duecentomila
turisti, rispetto agli 800 mila dell'anno precedente. Si fanno
sentire gli inviti (timidi) al boicottaggio rivolti alle Nazioni
unite e all'Unione europea contro la giunta militare da 46 anni
al potere. Prevalgono gli scrupoli morali. L'appello a disertare
la Birmania di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel
1991, leader dell'Nld (National leage for democracy), vincitrice
assoluta delle passate elezioni, da 6 anni di nuovo agli arresti
domiciliari, sembra avere effetto. Per due settimane abbiamo
girato il paese in lungo e in largo incontrando pochissimi
turisti.
Chiediamo alla nostra guida cosa sta accadendo; vediamo, in
lontananza, le luci della polizia. "Problem, problem", si
affanna allarmato. "Police, army, protest". Ma poi, subito dopo,
giù a ridere, come fanno sempre i birmani per stemperare anche
la più piccola tensione.
"Questo viale", racconta, "ad agosto era pieno di gente.
Migliaia e migliaia di persone. Prima sono scesi in piazza i
monaci, poi la gente si è fatta coraggio e li ha seguiti".
Chiediamo quanti feriti e quanti morti ci sono stati. Lo
domandiamo spesso in giro. Le risposte sono sempre diverse e
vaghe. Dopo tante pressioni, il governo dello Spdc (State peace
and development council), ex Slorc, il partito unico, artefice
di questa "via birmana al socialismo", ha ammesso dieci vittime,
2700 arresti, tra cui 573 monaci, 1600 dei quali già stati
rilasciati.
Il "Tate naing" della "Assistance association of political
prisoniers" parla invece di 4000 morti e 700 arresti. La verità,
inaccessibile, resta isolata al centro della Birmania, a
Nyapyidaw, dove il regime, con una scelta paranoica e ossessiva
appoggiata dall'indovino di corte, ha deciso di trasferire la
nuova capitale. Una città-caserma artificiale, nata dal nulla,
senza negozi, ristoranti, case, sale da tè, ospedali e scuole.
Ci vivono il vertice della giunta militare, i generali, gli
ufficiali, la truppa, i dirigenti del Spdc. Una comunità priva
di vita, rumori, colori, emozioni. I birmani ci ridono sopra e
la spiegano con una barzelletta: "Hanno paura di tutto, persino
del loro popolo".
Tsa-Tsa ricorda molto bene i cadaveri abbandonati sull'asfalto o
lungo i marciapiedi quando l'esercito ebbe l'ordine di sparare.
E' convinto: "Li hanno cremati o buttati in una fossa comune".
Racconta che i cortei sono durati quattro settimane. "C'erano
due appuntamenti quotidiani: la mattina alle 9 e poi alle 4 del
pomeriggio. Non si mangiava e si dormiva poco. Bevevamo
coca-cola, lo zucchero ci dava forza e ci teneva svegli. Le
autorità non hanno reagito subito. Sono rimaste a guardare per
una settimana. Sparare sui religiosi li metteva in crisi".
Oltre ad essere buddista, la giunta militare è nota per essere
superstiziosa: nelle scelte più importanti interpella esperti
astrali e interpreti del fuoco in grado di scacciare gli spiriti
maligni. Ma qualcosa si è rotto al vertice. Si parla di uno
scontro tra il capo, il tenente generale Than Shwe, 74 anni e il
suo vice, il generale Maung Aye, 69. Il primo era favorevole ad
un intervento, il secondo invitava alla prudenza. La realtà
della piazza ha fatto prevalere la linea dura.
"Quando si sono uniti anche gli studenti", aggiunge il ragazzo
del risciò, "i professori, i commercianti, gli ingeneri, i
farmacisti, quando tutti i negozi sono rimasti chiusi, quando i
genitori si sono rifiutati di mandare i propri figli a scuola,
allora è scattata la repressione". Indica le feritoie della
muraglia che scorre sul lato: "Sparavano da lì. La folla
marciava e loro sparavano". Ciò che è accaduto, lo ha saputo e
visto tutto il mondo. Grazie alle foto scattate con i cellulari
e spedite all'estero via mail dai più coraggiosi. Sono gli
stessi che vediamo accorrere verso l'incendio. Le ragazze in
minigonna ma con il viso protetto dalla "tannaka", la crema di
legno di sandalo, per mantenere la pelle bianca. I ragazzi con i
jeans larghi e calati, i capelli colorati, i tatuaggi, gli
orecchini, mischiati a quelli che indossano i "longyi", il pareo
tradizionale, e ciabattine. Passato e futuro.
Tutti insieme. Alzano le due dita in segno di vittoria,
strombazzano clacson e trillano i campanelli delle loro
biciclette.
La scuola è finita. Due potenti casse sparano
musica heavy metal da un camion. Stasera si balla. Anche il
nuovo incendio sarà spento. La Birmania, quella vera, non vuole
più attendere.

Mesi precedenti
>
Febbraio 2008
>
Gennaio 2008
Anni precedenti
>
Anno 2007
>
Anno 2006
>
Anno 2005
|
 Sotto-passo
e sovra-prezzo. Così i metodi finanziari più moderni, nati per
realizzare opere pubbliche trasparenti e senza ritardi, sembrano
essere diventati lo strumento per riproporre vecchi vizi. Come
quello dei costi per i cantieri che lievitano di anno in anno,
fino a sfiorare il raddoppio. La lezione arriva da Firenze, che
ha scelto il project financing per una serie di interventi
destinati a cambiare il volto della città. Tra queste il
sottopasso di viale Strozzi pare destinato a diventare un
monumento allo spreco. I costi sono passati da 5 milioni
previsti ad oltre 8, tutti a carico del Comune.
Sotto-passo
e sovra-prezzo. Così i metodi finanziari più moderni, nati per
realizzare opere pubbliche trasparenti e senza ritardi, sembrano
essere diventati lo strumento per riproporre vecchi vizi. Come
quello dei costi per i cantieri che lievitano di anno in anno,
fino a sfiorare il raddoppio. La lezione arriva da Firenze, che
ha scelto il project financing per una serie di interventi
destinati a cambiare il volto della città. Tra queste il
sottopasso di viale Strozzi pare destinato a diventare un
monumento allo spreco. I costi sono passati da 5 milioni
previsti ad oltre 8, tutti a carico del Comune. 




 Campagna
digitale. La strenua battaglia che accademici e
studenti stanno combattendo contro la decisione ha colto
letteralmente di sorpresa il Cremlino. Oltre alle consuete
proteste per strada, con picchetti e manifestazioni di fronte
all'università, professori e studenti hanno lanciato una
massiccia campagna in internet. Ilya Utekhin, docente di
antropologia, ha postato i suoi video in un blog per documentare
le attività di protesta. Nei video, girati il 29 febbraio e il 7
marzo, sono ripresi gli studenti che - per farsi beffe
dell'assurdo pretesto - hanno portato un idrante dall'edificio
universitario fino alla statua dello scienziato Michail
Lomonosov (
Campagna
digitale. La strenua battaglia che accademici e
studenti stanno combattendo contro la decisione ha colto
letteralmente di sorpresa il Cremlino. Oltre alle consuete
proteste per strada, con picchetti e manifestazioni di fronte
all'università, professori e studenti hanno lanciato una
massiccia campagna in internet. Ilya Utekhin, docente di
antropologia, ha postato i suoi video in un blog per documentare
le attività di protesta. Nei video, girati il 29 febbraio e il 7
marzo, sono ripresi gli studenti che - per farsi beffe
dell'assurdo pretesto - hanno portato un idrante dall'edificio
universitario fino alla statua dello scienziato Michail
Lomonosov ( Nelle
mani occidentali. Lo scorso anno l'università aveva
accettato 673 mila euro dall'Unione Europea per un progetto di
'consulenza' ai partiti politici russi in vista delle elezioni.
La finalità del progetto era informare i partiti su come
garantire che le elezioni si svolgessero correttamente. A
ottobre Putin sferrò un attacco al vetriolo contro l'Università
Europea, accusandola di essere un'agente degli 'intrallazzi
occidentali'. Alla fine di gennaio, il Consiglio accademico fu
costretto a piegarsi alle pressioni del Cremlino e dovette
abbandonare il progetto. Nel corso dei suoi due mandati, l'ex
presidente russo ha lanciato numerosi attacchi contro
organizzazioni non governative, gruppi per la tutela dei diritti
umani, piccoli partiti di opposizione: tutti accusati di essere
strumenti occidentali e traditori del loro Paese.
Nelle
mani occidentali. Lo scorso anno l'università aveva
accettato 673 mila euro dall'Unione Europea per un progetto di
'consulenza' ai partiti politici russi in vista delle elezioni.
La finalità del progetto era informare i partiti su come
garantire che le elezioni si svolgessero correttamente. A
ottobre Putin sferrò un attacco al vetriolo contro l'Università
Europea, accusandola di essere un'agente degli 'intrallazzi
occidentali'. Alla fine di gennaio, il Consiglio accademico fu
costretto a piegarsi alle pressioni del Cremlino e dovette
abbandonare il progetto. Nel corso dei suoi due mandati, l'ex
presidente russo ha lanciato numerosi attacchi contro
organizzazioni non governative, gruppi per la tutela dei diritti
umani, piccoli partiti di opposizione: tutti accusati di essere
strumenti occidentali e traditori del loro Paese. Video-burla.
Fino ad oggi, il settore dell'istruzione universitaria era stato
ignorato dalla mano pesante del regime, e gli accademici avevano
un certo grado di autonomia nell'insegnamento, nella selezione
degli studenti e nella ricerca. Adesso, neanche le università
sono più un'eccezione. Ma a San Pietroburgo gli universitari e i
loro professori hanno continuato ad alimentare la protesta per
tutto il mese, soprattutto sul blog. Un altro video mostra il
rettore dell'istituto, Boris Vakhtin, che si burla delle
motivazioni che hanno portato alla chiusura: "La cosa più
eclatante - spiega il rettore - è che l'ateneo avrebbe
acconsentito alla costruzione di una scala a chiocciola che
ostruisce le uscite antincendio. Forse non si sono accorti che
la scala è stata costruita nel 1881".
Video-burla.
Fino ad oggi, il settore dell'istruzione universitaria era stato
ignorato dalla mano pesante del regime, e gli accademici avevano
un certo grado di autonomia nell'insegnamento, nella selezione
degli studenti e nella ricerca. Adesso, neanche le università
sono più un'eccezione. Ma a San Pietroburgo gli universitari e i
loro professori hanno continuato ad alimentare la protesta per
tutto il mese, soprattutto sul blog. Un altro video mostra il
rettore dell'istituto, Boris Vakhtin, che si burla delle
motivazioni che hanno portato alla chiusura: "La cosa più
eclatante - spiega il rettore - è che l'ateneo avrebbe
acconsentito alla costruzione di una scala a chiocciola che
ostruisce le uscite antincendio. Forse non si sono accorti che
la scala è stata costruita nel 1881". All’interno
dei cinque chilometri di mura che abbracciano la città di
Diyarbakir vivono ufficialmente 350.000 persone, a grandissima
maggioranza curda, ma se si esce fuori dai bastioni la
popolazione si quintuplica: un milione di profughi arrivati da
tutto il Kurdistan a Diyarbakir, antica Amed, capitale di un
paese che non esiste (più) sulle carte ufficiali. Il 74 percento
della popolazione parla il curdo, moltissimi non conoscono la
lingua turca, solo la lingua madre. Sono più di quattromila i
villaggi evacuati o dati alle fiamme dalle forze turche perché
ritenuti collegati alla guerriglia combattuta dal Pkk.
All’interno
dei cinque chilometri di mura che abbracciano la città di
Diyarbakir vivono ufficialmente 350.000 persone, a grandissima
maggioranza curda, ma se si esce fuori dai bastioni la
popolazione si quintuplica: un milione di profughi arrivati da
tutto il Kurdistan a Diyarbakir, antica Amed, capitale di un
paese che non esiste (più) sulle carte ufficiali. Il 74 percento
della popolazione parla il curdo, moltissimi non conoscono la
lingua turca, solo la lingua madre. Sono più di quattromila i
villaggi evacuati o dati alle fiamme dalle forze turche perché
ritenuti collegati alla guerriglia combattuta dal Pkk. Secondo
Ali Akiaci, presidente di Ihd - associazione che si occupa della
tutela di diritti umani -, in Turchia c’è una vera e propria
emergenza democratica. In seguito all’invasione turca nel Nord
Iraq la popolazione del Kurdistan si è messa in moto: in ogni
città ci sono state pacifiche marce di protesta; le associazioni
civili, le assemblee degli avvocati hanno convocato conferenze
stampa per denunciare la violazione del diritto internazionale.
Secondo
Ali Akiaci, presidente di Ihd - associazione che si occupa della
tutela di diritti umani -, in Turchia c’è una vera e propria
emergenza democratica. In seguito all’invasione turca nel Nord
Iraq la popolazione del Kurdistan si è messa in moto: in ogni
città ci sono state pacifiche marce di protesta; le associazioni
civili, le assemblee degli avvocati hanno convocato conferenze
stampa per denunciare la violazione del diritto internazionale. Il
rapporto 'aggiustato'. Nei primi mesi del 2007, il
destino del progetto sembrava segnato: una ricerca - non resa
pubblica - commissionata dal governo aveva infatti evidenziato
che l'espansione dell'aeroporto avrebbe provocato un impatto
tale da superare di gran lunga le soglie di inquinamento
acustico e ambientale fissate dal ministero per l'Ambiente.
Risultati poco incoraggianti soprattutto per il dirigente del
Dipartimento dei Trasporti (DfT), David Gray. Questi aveva
infatti il compito di mostrare all'opinione pubblica come la
terza pista non avrebbe avuto conseguenze troppo onerose in
termini di squilibrio ecologico, o almeno non troppo gravi da
vanificare l'ambizioso piano di lotta all'inquinamento che il
Primo ministro Gordon Brown va sbandierando ad ogni incontro sul
clima al quale partecipi.
Il
rapporto 'aggiustato'. Nei primi mesi del 2007, il
destino del progetto sembrava segnato: una ricerca - non resa
pubblica - commissionata dal governo aveva infatti evidenziato
che l'espansione dell'aeroporto avrebbe provocato un impatto
tale da superare di gran lunga le soglie di inquinamento
acustico e ambientale fissate dal ministero per l'Ambiente.
Risultati poco incoraggianti soprattutto per il dirigente del
Dipartimento dei Trasporti (DfT), David Gray. Questi aveva
infatti il compito di mostrare all'opinione pubblica come la
terza pista non avrebbe avuto conseguenze troppo onerose in
termini di squilibrio ecologico, o almeno non troppo gravi da
vanificare l'ambizioso piano di lotta all'inquinamento che il
Primo ministro Gordon Brown va sbandierando ad ogni incontro sul
clima al quale partecipi. Come
aggirare il problema? Trasmettere (in via del tutto
confidenziale) al Baa, l'ente di gestione dell'aeroporto, i
risultati del rapporto. Il Baa avrebbe scritto al Dipartimento
dei Trasporti esortandolo a riconsiderare la valutazione di
impatto ambientale sulla base di 'nuove acquisizioni'. Un
aggiustamento qua e uno là, finalmente governo e Baa approdano
al risultato finale. "Gli sforzi congiunti di entrambi -
scriveva il Times nella sua edizione domenicale - hanno avuto
come risultato il tentativo di far passare l'idea che un nuovo
aeroporto delle dimensioni di Gatwick può essere tranquillamente
aggiunto a Heathrow senza alcun impatto ambientale".
Come
aggirare il problema? Trasmettere (in via del tutto
confidenziale) al Baa, l'ente di gestione dell'aeroporto, i
risultati del rapporto. Il Baa avrebbe scritto al Dipartimento
dei Trasporti esortandolo a riconsiderare la valutazione di
impatto ambientale sulla base di 'nuove acquisizioni'. Un
aggiustamento qua e uno là, finalmente governo e Baa approdano
al risultato finale. "Gli sforzi congiunti di entrambi -
scriveva il Times nella sua edizione domenicale - hanno avuto
come risultato il tentativo di far passare l'idea che un nuovo
aeroporto delle dimensioni di Gatwick può essere tranquillamente
aggiunto a Heathrow senza alcun impatto ambientale". Anti-pista.
In un momento in cui milioni di persone a livello globale stanno
esprimendo la necessità di cambiamenti climatici urgenti, ma
soprattutto in un momento in cui Gordon Brown si fa paladino di
queste richieste, propagandando ovunque il suo piano per la
lotta globale all'inquinamento, le betoniere stanno già
preparando a sputare chilometri di asfalto per la nuova pista di
Heathrow e gli scarichi degli aerei tonnellate di ossido di
carbonio che - a detta del governo - avranno un impatto solo
'minimo' sul sistema ecologico britannico. Per bloccare il
progetto, gli ambientalisti stanno preparando picchetti
nell'area interessata, e più di 10 mila persone sono attese alla
manifestazione che si terrà a Heathrow il 31 maggio prossimo.
Anti-pista.
In un momento in cui milioni di persone a livello globale stanno
esprimendo la necessità di cambiamenti climatici urgenti, ma
soprattutto in un momento in cui Gordon Brown si fa paladino di
queste richieste, propagandando ovunque il suo piano per la
lotta globale all'inquinamento, le betoniere stanno già
preparando a sputare chilometri di asfalto per la nuova pista di
Heathrow e gli scarichi degli aerei tonnellate di ossido di
carbonio che - a detta del governo - avranno un impatto solo
'minimo' sul sistema ecologico britannico. Per bloccare il
progetto, gli ambientalisti stanno preparando picchetti
nell'area interessata, e più di 10 mila persone sono attese alla
manifestazione che si terrà a Heathrow il 31 maggio prossimo. Il
piano. Le autorità di Canberra vogliono
sopprimere 400 canguri sui circa 500 che vivono
nell'area attorno alla dismessa stazione di
trasmissione navale di Belconnen, proprio nella
capitale. Secondo il governo, l'eccessivo numero di
canguri a pascolo nella zona mette a rischio altre
specie animali, tra cui un tipo di lucertola e di
falena. Un piano per spostare i marsupiali in
un'altra regione, come proposto dagli animalisti, è
stato bocciato dal governo in quanto “inumano”.
Così, questo fine settimana gli animali dovrebbero
venire soppressi, dopo essere stati addormentati con
dei sonniferi sparati a distanza. L'idea di un tiro
a segno con proiettili veri è stata scartata per i
rischi di colpire i residenti delle case
circostanti, o i dimostranti che si dovessero
opporre al piano.
Il
piano. Le autorità di Canberra vogliono
sopprimere 400 canguri sui circa 500 che vivono
nell'area attorno alla dismessa stazione di
trasmissione navale di Belconnen, proprio nella
capitale. Secondo il governo, l'eccessivo numero di
canguri a pascolo nella zona mette a rischio altre
specie animali, tra cui un tipo di lucertola e di
falena. Un piano per spostare i marsupiali in
un'altra regione, come proposto dagli animalisti, è
stato bocciato dal governo in quanto “inumano”.
Così, questo fine settimana gli animali dovrebbero
venire soppressi, dopo essere stati addormentati con
dei sonniferi sparati a distanza. L'idea di un tiro
a segno con proiettili veri è stata scartata per i
rischi di colpire i residenti delle case
circostanti, o i dimostranti che si dovessero
opporre al piano. Un
commercio mondiale. Il piano era stato ideato un
anno fa dall'allora governo conservatore di John
Howard, ma le proteste degli animalisti avevano
fatto rinviare la sua esecuzione. In un precedente
simile, nel 2004, l'Australia provocò uno scandalo
internazionale decidendo di sparare a 900 canguri
vicino a una diga che rifornisce d'acqua la
capitale. Anche in quella occasione, il motivo era
l'erosione del terreno causata dal pascolo selvaggio
degli animali. Ma lontano dai riflettori, ogni anno
in Australia sono milioni i canguri uccisi per
motivi commerciali. “La carne è venduta come cibo
per cani ed esportata, specialmente in Francia,
Germania e Russia”, ha spiegato O'Brien.
Un
commercio mondiale. Il piano era stato ideato un
anno fa dall'allora governo conservatore di John
Howard, ma le proteste degli animalisti avevano
fatto rinviare la sua esecuzione. In un precedente
simile, nel 2004, l'Australia provocò uno scandalo
internazionale decidendo di sparare a 900 canguri
vicino a una diga che rifornisce d'acqua la
capitale. Anche in quella occasione, il motivo era
l'erosione del terreno causata dal pascolo selvaggio
degli animali. Ma lontano dai riflettori, ogni anno
in Australia sono milioni i canguri uccisi per
motivi commerciali. “La carne è venduta come cibo
per cani ed esportata, specialmente in Francia,
Germania e Russia”, ha spiegato O'Brien. Kangrai,
Nord Waziristan. Secondo il capo di Stato
Maggiore pachistano, generale Athar Abbas, cinque
proiettili d’artiglieria sparati dalle forze Usa dal
territorio afgano hanno colpito un’area residenziale
distruggendo una casa e uccidendo due donne e due
bambini. “Abbiamo inoltrato una dura protesta alle
forze della Coalizione al di là del confine”, ha
detto il generale.
Kangrai,
Nord Waziristan. Secondo il capo di Stato
Maggiore pachistano, generale Athar Abbas, cinque
proiettili d’artiglieria sparati dalle forze Usa dal
territorio afgano hanno colpito un’area residenziale
distruggendo una casa e uccidendo due donne e due
bambini. “Abbiamo inoltrato una dura protesta alle
forze della Coalizione al di là del confine”, ha
detto il generale.  Nawagai,
Bajahur. Nelle stesse ore, in una zona più
settentrionale delle aree tribali pashtun, un
massiccio bombardamento dell’artiglieria pachistana
ha ucciso almeno dodici civili, tra cui due donne e
un bambino. L’attacco governativo è stato sferrato
in rappresaglia a due imboscate talebane costate la
vita ad alcuni soldati. Questa mattina, gli abitanti
dei villaggi bombardati sono andati nella più vicina
cittadina, Khar, per manifestare contro queste
stragi di civili. In migliaia hanno protestato
scandendo rabbiosi slogan contro il governo
pachistano e contro gli Stati Uniti: “Morte al
traditore Musharraf!”, “Morte all’America!”.
Nawagai,
Bajahur. Nelle stesse ore, in una zona più
settentrionale delle aree tribali pashtun, un
massiccio bombardamento dell’artiglieria pachistana
ha ucciso almeno dodici civili, tra cui due donne e
un bambino. L’attacco governativo è stato sferrato
in rappresaglia a due imboscate talebane costate la
vita ad alcuni soldati. Questa mattina, gli abitanti
dei villaggi bombardati sono andati nella più vicina
cittadina, Khar, per manifestare contro queste
stragi di civili. In migliaia hanno protestato
scandendo rabbiosi slogan contro il governo
pachistano e contro gli Stati Uniti: “Morte al
traditore Musharraf!”, “Morte all’America!”.  La
richiesta più pesante è stata quella per Antonio Biagio
Gugliotta, ispettore della polizia penitenziaria: 5 anni, 8 mesi
e 5 giorni di reclusione. Poi quella per Massimo Pigozzi, il
poliziotto accusato di lesioni personali: 3 anni e 11 mesi.
Infine, quella per Giorgio Toccafondi, il medico, accusato di
abuso di atti d'ufficio e diversi episodi di percosse, ingiurie
e violenza privata: 3 anni, 6 mesi e 25 giorni di reclusione.
Sono 76 in totale gli anni di prigione chiesti oggi dai pm
genovesi Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati per 44
dei 45 imputati nel processo per i fatti avvenuti nella caserma
di Bolzaneto durante il G8. Per uno solo degli imputati, il
funzionario di polizia Giuseppe Fornasiere, è stata chiesta
l'assoluzione.
La
richiesta più pesante è stata quella per Antonio Biagio
Gugliotta, ispettore della polizia penitenziaria: 5 anni, 8 mesi
e 5 giorni di reclusione. Poi quella per Massimo Pigozzi, il
poliziotto accusato di lesioni personali: 3 anni e 11 mesi.
Infine, quella per Giorgio Toccafondi, il medico, accusato di
abuso di atti d'ufficio e diversi episodi di percosse, ingiurie
e violenza privata: 3 anni, 6 mesi e 25 giorni di reclusione.
Sono 76 in totale gli anni di prigione chiesti oggi dai pm
genovesi Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati per 44
dei 45 imputati nel processo per i fatti avvenuti nella caserma
di Bolzaneto durante il G8. Per uno solo degli imputati, il
funzionario di polizia Giuseppe Fornasiere, è stata chiesta
l'assoluzione.  I
fatti. Dunque, i due
referendum indetti non si svolgeranno. Nel primo
quesito sarebbe stata chiesta al popolo boliviano
l'approvazione della nuova Costituzione. Nel secondo
referendum, altrettanto importante, sarebbe stata
presa in considerazione la proprietà terriera. Il
quesito, infatti, avrebbe dovuto stabilire se le
proprietà terriere dovevano essere inferiori ai 5
mila ettari oppure potevano arrivare fino a 10 mila.
I
fatti. Dunque, i due
referendum indetti non si svolgeranno. Nel primo
quesito sarebbe stata chiesta al popolo boliviano
l'approvazione della nuova Costituzione. Nel secondo
referendum, altrettanto importante, sarebbe stata
presa in considerazione la proprietà terriera. Il
quesito, infatti, avrebbe dovuto stabilire se le
proprietà terriere dovevano essere inferiori ai 5
mila ettari oppure potevano arrivare fino a 10 mila.
 Le
province ricche.
Ricche e industrializzate, le quattro province in
polemica con Morales hanno auto-indetto per il mese
di giugno un referendum per l'approvazione degli
statuti d'autonomia dal governo centrale. Ma anche
in questo caso il Cne ha bloccato il loro
svolgimento. Secondo i giudici, infatti, la
convocazione referendaria da parte dei governatori
delle quattro province non è conforme alla legalità.
La convocazione di elezioni che stabiliscano
l'autonomia o meno di alcune regioni del Paese è di
assoluta competenza del Parlamento e non dei
governatori regionali.
Le
province ricche.
Ricche e industrializzate, le quattro province in
polemica con Morales hanno auto-indetto per il mese
di giugno un referendum per l'approvazione degli
statuti d'autonomia dal governo centrale. Ma anche
in questo caso il Cne ha bloccato il loro
svolgimento. Secondo i giudici, infatti, la
convocazione referendaria da parte dei governatori
delle quattro province non è conforme alla legalità.
La convocazione di elezioni che stabiliscano
l'autonomia o meno di alcune regioni del Paese è di
assoluta competenza del Parlamento e non dei
governatori regionali.  Novità.
Intanto, nella notte fra sabato e domenica scorsa,
violenti incidenti fra i sostenitori di Evo Morales
e quelli dei partiti di opposizione si sono
verificati a La Paz. Le strade della città si sono
inizialmente riempite di persone che manifestavano
in favore dei governatori, quando i fedeli di
Morales si sono presentati armati di bastoni e hanno
iniziato ad accusare i prefetti di essere gli stessi
che negli anni passati hanno svenduto le risorse del
Paese alle multinazionali straniere.
Novità.
Intanto, nella notte fra sabato e domenica scorsa,
violenti incidenti fra i sostenitori di Evo Morales
e quelli dei partiti di opposizione si sono
verificati a La Paz. Le strade della città si sono
inizialmente riempite di persone che manifestavano
in favore dei governatori, quando i fedeli di
Morales si sono presentati armati di bastoni e hanno
iniziato ad accusare i prefetti di essere gli stessi
che negli anni passati hanno svenduto le risorse del
Paese alle multinazionali straniere.