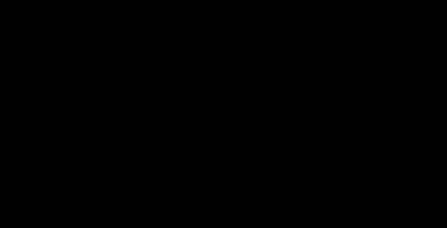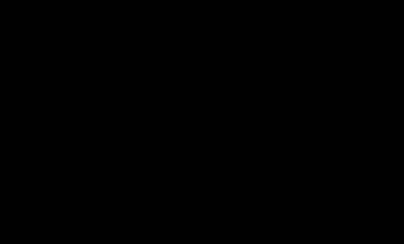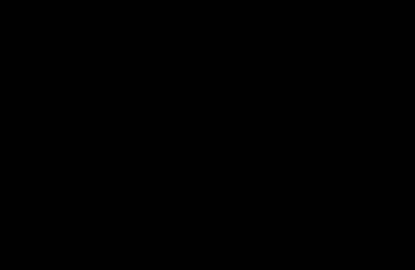|
Lo sapevate che...
31 ottobre
Le forze dell'ordine
hanno attaccato i manifestanti a Oaxaca
I docenti chiedono aumenti salariali. E la lotta si è allargata
ad altre categorie
Messico, la Polizia spara sugli
insegnanti
due vittime dopo cinque mesi di proteste
Il subcomandante Marcos ha inviato un messaggio
di solidarietà ai manifestanti: "Non siete soli

CITTA'
DEL MESSICO - E' finita con due morti, decine di feriti, 50
arresti e 36 persone sequestrate dai manifestanti, la carica
della Polizia Federale preventiva (Pfp) messicana che ieri ha
occupato la piazza centrale (Zocalo) di Oaxaca, capitale
dell'omonimo stato per interrompere la protesta, durata più di
160 giorni, degli insegnanti messicani.
Il 22 maggio 70.000 maestri sono scesi in sciopero per chiedere
aumenti salariali ma, di fronte all'intransigenza del
governatore Ulises Ruiz, il movimento si è generalizzato
coinvolgendo l'Assemblea del popolo di Oaxaca (Appo) che ha
tenuto a lungo testa alle forze dell'ordine.
Permanendo una impasse che rischiava di paralizzare
economicamente Oaxaca, il presidente uscente, Vicente Fox ha
deciso di inviare reparti della polizia federale che sono
entrati in azione ieri.
Per risolvere la crisi sono così intervenuti 3.800 agenti,
appoggiati logisticamente da 5.000 uomini dell'esercito, che
hanno rimosso, fin dal mattino, con l'appoggio di mezzi blindati
ed elicotteri le barricate, scontrandosi più volte con i
manifestanti. Gli insegnanti hanno risposto al blitz della
polizia con azioni nonviolente, ma a tratti anche con pietre e
bastoni, agli idranti e ai lacrimogeni.
L'operazione ha permesso di recuperare gli edifici pubblici
occupati ed ha sospeso le trasmissioni di Radio Universidad, che
per tutta la giornata era servita da coordinamento per la
resistenza civile.
Dall'inizio dei disordini sono almeno 13 le persone, per lo più
maestri elementari, morte per mano di cecchini paramilitari.
Venerdì è caduto sotto i colpi d'arma da fuoco anche un
cameraman statunitense. Secondo la Appo le ultime due vittime
sono Roberto Lopez, un impiegato della previdenza sociale, e
Jorge Alberto Beltran, un infermiere.
Nel momento di maggiore intensità degli scontri di ieri, il
subcomandante zapatista Marcos ha inviato un messaggio di
solidarietà ai manifestanti di Oaxaca: "Le strade sono bloccate
dalla polizia - ha detto il leader dell'Esercito zapatista di
liberazione nazionale (Ezln) parlando a Chihuahua, nel Messico
settentrionale - nell'aria non volano uccelli ma aerei
dell'esercito. Il popolo è circondato e sente di essere solo, ma
noi diciamo che non è solo, che lo appoggiamo".
Anche il leader del Partito della rivoluzione democratica (Prd)
ed ex candidato sconfitto di misura alle recenti elezioni
presidenziali, Andres Manuel Lopez Obrador, si è schierato con i
manifestanti della Appo sostenendo "inaccettabile e indegno" che
il governo del presidente Fox continui a sostenere il
governatore Ruiz, bollato di "antipopolare, sinistro e
repressore".
A 10 anni dalla
dichiarazione di Roma, che impegnava i governi
a dimezzare i sottoalimentati nel mondo le cifre sono allarmanti
La Fao ammette il fallimento
"La fame nel mondo aumenta"
L'obiettivo fissato nel 1996 è
praticamente irraggiungibile
Nell'Africa sub-sahariana 40 milioni di malnutriti in più
di CRISTINA NADOTTI

ROMA -
L'obiettivo di dimezzare il numero di persone che soffrono la
fame entro il 2015 è lontano, sempre più lontano, praticamente
irraggiungibile. Il Rapporto annuale sullo Stato di insicurezza
alimentare nel mondo (Sofi), diffuso oggi dalla Fao, ammette:
"In dieci anni, in pratica, non è stato fatto alcun progresso
verso l'obiettivo di dimezzare il numero di sottoalimentati nel
mondo". Già in occasione della "Giornata
mondiale dell'alimentazione", lo scorso 16 ottobre, il
direttore generale dell'organizzazione, Jacques Diouf, aveva
reso note alcune cifre allarmanti, ma i risultati del Sofi
mostrano come in alcune zone - tra queste l'Africa - la
situazione non solo non è migliorata, ma è in peggioramento.
I dati. Al mondo ci sono 854 milioni di persone che soffrono la
fame e il numero non è mai calato dal 1990-92. Fare riferimento
a questa data è importante perché nel 1996 oltre 180 capi di
Stato e di governo si erano riuniti a Roma per il Vertice
mondiale sull'alimentazione e avevano firmato una Dichiarazione
con la quale si impegnavano a dimezzare il numero degli affamati
entro il 2015 e portarlo a 412 milioni. Per onorare l'impegno
preso al vertice si dovrebbe ridurre il numero dei sottonutriti
di 31 milioni l'anno da oggi sino al 2015, mentre il trend
attuale è al contrario di un aumento al ritmo di quattro milioni
l'anno.
Le ultime rilevazioni della Fao si riferiscono al periodo
2001-2003: le persone sottoalimentate sono ancora 854 milioni,
tra queste 820 milioni vivono nei paesi in via di sviluppo, 25
milioni nei Paesi in transizione e nove milioni nei Paesi
industrializzati. Il rapporto sottolinea che ci sono alcuni dati
confortanti e riguardano i Paesi in via di sviluppo, nei quali
il numero di sottoalimentati si è ridotto del 3% rispetto al
1990, e potrebbe dimezzarsi entro il 2015. Ma a fronte di queste
buone notizie si evidenzia un divario sempre più ampio con i
Paesi più poveri, nei quali le cifre parlano di un aumento netto
della povertà. E' esemplare il caso dell'Africa sub-sahariana:
la Fao stima che entro il 2015 il 30% di sottoalimentati sarà
concentrato in quella regione.
Il caso africano. Nell'Africa sub-sahariana il numero di persone
sottoalimentate è passato da 169 milioni nel 1990-92 a 206,2
milioni nel 2001-03. Tra le cause di questo incremento l'Aids,
le guerre e le catastrofi naturali, in particolare nel Burundi,
in Eritrea, in Liberia, in Sierra Leone e nella Repubblica
democratica del Congo. E' proprio questo il Paese per cui si
registrano le maggiori preoccupazioni della Fao poiché, a causa
anche della guerra del 1998-2002, il numero di affamati è
triplicato passando da 12 a 37 milioni di persone, cioè il 72%
della popolazione. La Repubblica Democratica del Congo è un caso
emblematico se si considera che si tratta di una delle regioni
della terra con le maggiori risorse naturali. Per dirla con le
parole del Sofi "ciò che manca è la volontà politica per
mobilitare quelle risorse a beneficio degli affamati".
Le politiche contraddittorie. Il rapporto della Fao indica
chiaramente che per ridurre il numero di sottoalimentati è
fondamentale lo sviluppo rurale, almeno nei Paesi nei quali la
situazione è peggiore. "Nonostante ciò i Paesi donatori hanno
ridotto in modo consistente gli aiuti al settore agricolo -
sottolinea Francisco Sarmento di Action Aid International, una
delle organizzazioni invitate dalla Fao a discutere della
revisione del piano d'azione - Nell'84 i Paesi donatori hanno
versato quasi otto miliardi di dollari per il sostegno dei
programmi agricoli, ma nel 2002 la cifra si è ridotta a circa
tre miliardi. Inoltre i Paesi del Nord del mondo adottano tutta
una serie di azioni economiche che frenano la produzione
agricola dei Paesi sottosviluppati e l'esportazione dei loro
prodotti. E' un po' come dire che si individua l'agricoltura
come il motore principale per la ripresa dei Paesi
sottosviluppati, ma poi questo motore lo si frena in tutti i
modi".
Gli impegni. Il rapporto della Fao fa notare che l'obiettivo è
ancora raggiungibile, ma solo se si interverrà concretamente e
in modo concertato, con un'azione diretta contro la fame
contemporaneamente a interventi mirati allo sviluppo agricolo e
rurale. Tra le altre misure elencate dal Sofi ci sono:
indirizzare i programmi e gli investimenti verso le "zone più
critiche" di povertà e sottonutrizione; rafforzare la
produttività a livello di piccoli produttori; creare condizioni
idonee per gli investimenti privati, e questo implica tra
l'altro trasparenza e buon governo; far sì che il commercio
mondiale funzioni anche per i poveri, con l'istituzione di
meccanismi di protezione per i gruppi più vulnerabili; un
immediato incremento del livello degli Aiuti Pubblici allo
Sviluppo (APS) per arrivare a raggiungere lo 0,7% del Pil, come
promesso.
Che state a Fao? Da oggi fino al 4 novembre nel palazzo della
Fao, a Roma, si tengono gli incontri per la revisione del piano
d'azione del Vertice mondiale dell'alimentazione. All'evento
partecipano i ministri di alcuni tra i Paesi più ricchi e più
poveri del mondo e la Fao ha invitato organizzazioni non
governative ed esponenti della società civile per discutere
quali misure adottare per non fallire l'obiettivo del 2015.
Action Aid International ha lanciato in contemporanea la
campagna "Che state a Fao?" per denunciare l'insufficiente
impegno politico e finanziario degli ultimi dieci anni da parte
dei governi e della comunità internazionale. Per informarsi
sulle iniziative portate avanti dalla ong si può visitare
il sito.
30 ottobre
La storia
Così si licenziano i dipendenti
municipali
Lauro,
comune pilota nelle «ristrutturazioni» del settore pubblico. Fuori i
lavoratori iscritti alla Fp Cgil, dentro nuovi assunti senza concorso. E
intanto mancano le strutture: gli ospiti devono sedere sui banchi dell'asilo
Francesca Pilla
Lauro (Avellino)
Sedici dipendenti pubblici da
licenziare per far posto a 32 nuovi assunti senza concorso. A Lauro - comune
di 3 mila abitanti alle porte di Nola ma in provincia di Avellino - si può.
Protagonista la giunta comunale guidata dal sindaco Vito Bossone (Udeur),
succeduto al cugino Antonio da tre anni, che ha prima deciso di portare
l'organico a 80 dipendenti - un numero altissimo per un piccolo comune -
quindi di mettere in mobilità quelli sgraditi, cinque di questi iscritti
alla Fp-Cgil. La motivazione del provvedimento? Un eccessivo costo per la
pubblica amministrazione. Anche se quelle spese sono state «autoprodotte»,
fuori i vecchi - tra cui il comandante dei vigili urbani, alcuni assistenti
tecnici e operatori ecologici - dentro i nuovi.
Il provvedimento è stato impugnato dal sindacato che la scorsa settimana è
riuscito a ottenere il reintegro dei lavoratori dal prossimo primo novembre.
Ma l'amministrazione non si è data per vinta e alcuni giorni fa ha deciso
unilateralmente il part time per questi impiegati. «Un'operazione illegale
dato che secondo il contratto nazionale per poter applicare il part time si
deve prima concordarlo con i dipendenti - spiega Luigi Mauro, della
segreteria Fp-Cgil di Avellino - Si tratta di un ennesimo abuso che si
aggiunge a cinque anni di violazioni di norme e regole nell'organizzazione
del lavoro».
Attualmente l'ente è sull'orlo del tracollo per i troppi sprechi, da
settembre i lavoratori non percepiscono lo stipendio e ieri la situazione,
ormai non più sopportabile, è stata anche denunciata in un'assemblea dei
lavoratori dal segretario nazionale della Fp-Cgil Mauro Breschi. Il sindaco
non vuole nessun tipo di confronto a riprova anche «l'accoglienza» riservata
all'assemblea: «Una sala malsana e senza sedie, con lavoratori e giornalisti
costretti a sedere sui banchi dell'asilo infantile», ha raccontato Marco D'Acunto,
segretario provinciale. «La pianta organica è stata gonfiata a dismisura
mediante assunzioni di dubbia legittimità che hanno portato al raddoppio dei
dipendenti nel giro di un anno e mezzo - continua D'Acunto - dal mese di
settembre i lavoratori non solo sono senza stipendio, ma non hanno ancora
avuto gli arretrati contrattuali approvati col contratto nazionale dello
scorso maggio. Su queste basi si arriverà a uno scontro». E la vicenda di un
piccolo paesino, a causa delle continue violazioni, potrebbe anche diventare
di interesse nazionale.
I parlamentari Raffaele Aurisicchio e Tommaso Sodano nelle scorse settimane
hanno già prodotto tre interrogazioni parlamentari sul «caso Lauro». Così
Beschi ha rincarato la dose: «L'azione dei lavoratori del comune di Lauro -
ha detto chiudendo l'assemblea - ci aiuta anche a livello nazionale per
portare avanti la battaglia che conduciamo sull'importanza del ruolo del
pubblico impiego e sulla necessità che esso sia organizzato e gestito sulle
esigenze dei cittadini e non sul volere degli amministratori, che seppure
eletti dal popolo sono tenuti al rispetto delle leggi e dei contratti».
Legge
sulle armi, uno solo dice no
L'assemblea generale dell'Onu ha approvato la proposta di redigere un
trattato per limitare la vendita di armamenti. Con un solo voto contrario,
quello di Washington, il principale esportatore di armi del mondo: 18,5
miliardi di dollari l'anno
Gabriele Carchella*
Questa volta gli Stati uniti sono
proprio soli. Soli di fronte al resto del mondo, che ha deciso di mettere
nero su bianco le nuove regole sul commercio delle armi. Non ci sono neanche
i cugini britannici a dar man forte all'alleato d'oltreoceano: giovedì sera,
quando il comitato dell'Onu ha messo ai voti la proposta di redigere un
trattato sulla compravendita di armi, Londra ha risposto sì. Lo stesso i
francesi, che in tema di armamenti hanno sempre fatto la voce grossa.
Persino la grande Russia e il gigante cinese hanno preferito non opporsi,
scegliendo la via più prudente dell'astensione. Due produttori emergenti
dell'ex blocco sovietico, Ucraina e Bulgaria, hanno invece espresso parere
positivo. Riassumendo: 139 sì, 26 astensioni (tra cui India e Pakistan) e un
solo no. Quello degli Stati uniti. L'unilateralismo della super potenza,
insomma, assomiglia sempre di più a una malattia irreversibile. Di fronte
all'isolamento internazionale, Washington risponde che i trattati già in
vigore sono più che sufficienti. Diverso il parere dei britannici, che
salutano il voto all'Onu come un grande traguardo: «Tutti i paesi dovrebbero
sostenere un trattato come questo, perché offre la speranza di un mondo più
sicuro in cui i bambini non debbano aver paura di andare a scuola», ha
dichiarato il ministro per lo Sviluppo internazionale di sua maestà Gareth
Thomas. Le organizzazioni per i diritti umani applaudono. Per Amnesty
International, si tratta di «un'opportunità storica» per redigere un
trattato credibile, che metta fuorilegge i trasferimenti di armi, causa di
«sistematici omicidi, stupri, torture».
Il voto del primo comitato dell'Assemblea generale dell'Onu è frutto di un
lungo lavoro. Negli ultimi tre anni, la campagna «Control Arms» - promossa
da Amnesty, Oxfam International e dalla Rete internazionale d'azione sulle
armi leggere (Iansa) - ha raccolto un milione di adesioni in 170 paesi.
Nella lista dei sostenitori spiccano i nomi di 15 premi Nobel per la pace,
tra cui l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu e il Dalai Lama. «Questa
decisione deve tradursi in un trattato forte, basato sugli impegni di
diritto internazionale assunti dagli stati», ha detto Rebecca Peters,
direttrice di Iansa.
Ma perché i trattati in vigore non sono efficaci? La globalizzazione ha reso
i controlli attuali inadeguati, spiegano i promotori di «Control Arms». Per
le grandi industrie di armamenti, infatti, è semplice sfuggire ai controlli.
Se in un paese le regole sono rigide, basta trasferire i centri di
produzione dove le leggi sono più permissive. Il voto all'Onu, comunque, è
solo un primo passo. Il segretario generale dell'Onu (dal primo gennaio Ban
Ki-Moon) ha un anno di tempo per ascoltare i pareri di tutti gli stati
membri delle Nazioni unite. Terminate le consultazioni, riferirà alla fine
del 2007 all'Assemblea generale. La parola passerà poi a un gruppo di
esperti governativi, che a sua volta sarà ascoltato dall'Assemblea nel 2008.
Insomma, prima di vedere la bozza del trattato ci vorranno anni. Proprio per
questo colpisce il voto contrario degli Usa, che hanno detto no prima ancora
di conoscere i principi guida del possibile trattato. In America latina e
Africa, al contrario, l'idea ha suscitato molto interesse. Soprattutto tra i
paesi che hanno sofferto gli effetti del traffico incontrollato di armi,
come Colombia, Haiti, Liberia e Rwanda.
L'idea piace meno all'industria bellica, per la quale ogni anno si spendono
nel mondo più di mille miliardi di dollari. Al primo posto tra i paesi
esportatori ci sono gli Stati uniti. Secondo le stime del londinese
Institute for Strategic Studies, nel 2004 gli Usa hanno esportato armi per
un valore di 18,5 miliardi di dollari Seguono molto distanziate Russia (4,6
miliardi), Francia (4,4), Regno unito (1,9) e Germania (0,9). Nella
classifica degli acquirenti, considerando solo i paesi in via di sviluppo,
il primo posto spetta agli Emirati arabi uniti (3,6 miliardi di dollari
spesi nel 2004), seguiti da Arabia saudita (3,2 miliardi), Cina (2,7) e
India (1,7). Di sicuro non sarà facile mettere tutti d'accordo su un
trattato internazionale. Oltre al no degli Usa, pesano le astensioni di
Russia e Cina, che faranno di tutto per evitare danni alle loro industrie
belliche.
Interrogatori «robusti»? Sì, se
permettono di ottenere informazioni. Parola di vicepresidente
Usa, torturare un po' va bene
In
un'intervista messa sul sito della Casa Bianca il vice di Bush, Dick Cheney,
assolve il «water-boarding», che consiste nel legare un detenuto a una
tavola e portarlo quasi all'annegamento: «Se serve a salvare vite umane è
sciocco perfino parlarne»
Franco Pantarelli
New York
Dick Cheney, il vice di George Bush, parla poco ma quando apre bocca
colpisce duro. Nell'ultima sua uscita, in un'intervista radiofonica
dell'altro ieri, ha detto che il «waterboarding» - cioè il trattamento che
fa sentire quelli che vi vengono sottoposti sull'orlo di annegare - va
benissimo e non costituisce tortura. Anzi, se deve servire a salvare vite
umane è un «no-brainer», cioè una cosa ovvia che non costituisce neanche un
grattacapo. Si fa e basta.
Immediata reazione delle associazioni per la difesa dei diritti umani e
domande a ripetizione, durante il briefing quotidiano della Casa bianca, al
portavoce ufficiale Tony Snow, che naturalmente ha negato tutto. Il vice
presidnte, ha detto Snow, «non parla del waterboarding. Non lo farebbe mai,
non lo fa mai e mai lo farà». Ma il testo dell'intervista, che è stato posto
perfino nel sito ufficiale della Casa bianca, dice esattamente il contrario.
L'intervistatore Scott Hennen, «stella» di una radio del Minnesota (una
delle tante di di cui la destra dispone, le sole con cui parla Dick Cheney)
gli chiede se non sia d'accordo nel considerare il gran discutere sul
waterboarding, diventato una sorta di simbolo, non sia per l'appunto una
schiocchezza e lui risposnde tranquillamente: «Sono d'accordo», anche se poi
- come al solito infischiadosene della logica - ribadisce che «noi non
torturiamo, noi rispettiamo gli impegni che ci vengono dai trattati
internazionali e dalle nostre stesse leggi».
Il riferimento è ovviamente alla Convenzione di Ginevra e alla nuova legge
sulle «commissioni militari», cioè quella che conferisce al presidente il
potere di decidere a suo insindacabile giudizio di stabilire cosa è permesso
dalla Convenzione di Ginevra e cosa no. Fra le varie nefandezze di quella
legge c'è anche quella di consentire che - quando i detenuti di Guantanamo e
quelli finora tenuti nelle prigioni segrete della Cia compariranno di fronte
alle commissioni militari per il processo - a loro carico potranno anche
essere presentate testimonianze ottenute con «trattamenti coercitivi». Dove
passa il confine fra tortura e trattamenti coercitivi?. I giornalisti hanno
preso a chiederlo a qualunque membro dell'amministrazione che capitasse loro
a tiro, ma nessuno rispondeva. Hanno cambiato tattica, chiedendo
esplicitamente se fra i trattamenti coercitivi consentiti ci fosse anche il
waterboarding, ma ugualmente nessuno rispondeva.
Ora la risposta l'ha data Cheney, spiegando tranquillamente che, sì, quella
tecnica si può usare. Il waterboarding consiste nello stendere il detenuto
su una tavola inclinata in modo che la sua testa sia più in basso dei piedi,
nel coprirgli il viso con un foglio di plastica e nel gettarvi acqua sopra.
Il risultato è che il poveraccio sente che sta per annegare e si dichiara
pronto a dire tutto ciò che da lui si vuole sapere. Cheney ha fatto il nome
di almeno un detenuto che è stato sottoposto a quel trattamento - il famoso
Khaled Sheikh Mohammed, considerato il cervello dell'attacco contro le Torri
Gemelle - per dire che lui ha fornito «informazioni di enorme valore sul
numero dei militanti di Al Qaeda, su come loro preparano i loro piani, su
come funzionano i loro addestramenti e così via». A quel punto
l'intervistatore, mostrandosi molto impressionato da quella spiegazione che
«ci fa sentire più sicuri», chiede a Cheney se non sia d'accordo che il
dibattito sul waterboarding non sia «un po' sciocco» e il vicepresidente si
dice «del tutto d'accordo».
Del resto lo scopo dell'intervista era di far rientrare la «paura del
terrorismo» nel dibattito elettorale, ormai completamente monopolizzata dal
disastro iracheno e quindi molto pericoloso per le fortune del partito
repubblicano. Se davvero Cheney e la sua «spalla» Scott Hennen siano
riusciti nell'impresa è dubbio. Di sicuro il vice presidente è riuscito a
riaffermare la sua figura come la più sinistra - ma in qualche modo la più
schietta - di questa amministrazione. Ma c'è una cosa che va ricordata, e
cioè che il dibattito e le decisioni prese sulla pratica della tortura non
era centrato sull'elemento «salvare vite umane», che sembra fatto apposta
per evocare una situazione in cui si sa che sta per scattare un'azione
terroristica ma non si sa esattamente cosa verrà colpito, dove e quando e
l'unico modo per saperlo e quindi salvare vite umane è torturare chi «si è
sicuri che lo sa», tipo uno di quelli impegnati nell'azione. No, la legge
che consente la tortura Bush l'ha voluta per «sanare» la situazione che si è
venuta a creare con i detenuti di Guantanamo e altrove, che - stante che le
vecchie leggi che non consentivano la tortura - non si potevano processare
perché sarebbero stati tutti assolti. Non potendo confessare di aver portato
nella prigione di Cuba gente che in gran parte col terrorismo non c'entra
nulla (il 90 per cento di quei detenuti non sono stati catturati dai soldati
americani ma consegnati da gente che cercava solo le loro laute ricompense),
Bush ha voluto una legge ad hoc che consentisse di processarli e condannarli
usando le confessioni estorte con la tortura, in modo che tutto alla fine il
processo appaia legittimo. I parlamentari repubblicani gli hanno fato questo
regalo e dovrebbe bastare questo a indurre gli elettori del prossimno 7
novemnbre a ripudiarli. Ma è più probabile che siano sconfitti per la guerra
in Iraq. Per ora, la bruttura di Bush che il pubblico americano ha
individuato è solo questa.
Duemila
euro di tasse in più Tanto ci costano gli evasori
La
ricerca di Fiscooggi quantifica in 250 miliardi di euro il Pil che sfugge
alle rilevazioni tributarie
Michele Simeone
Dopo tante chiacchiere, volete sapere quanti soldi gli evasori sottraggono
ogni anno dal vostro portafoglio? Ben 2 mila euro, che ogni abitante di
questa nazione versa in più per non «dare disturbo» a quelle persone che di
pagare le tasse proprio non ne vogliono sapere. Nel complesso la
stratosferica cifra sottratta alla contabilità nazionale ammonta a 250
miliardi di euro annui, il 7% del Pil nazionale. Il dato è stato fornito da
un'inchiesta della rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, FISCOoggi.
La cifra è il reddito totale ignoto al fisco. Nelle casse dello stato
dovrebbe andare il 40% di quei 250 miliardi di euro, per un importo che si
aggira intorno a 100 miliardi, 2 finanziarie attuali e mezzo. «La cifra
stimata», si sottolinea, « è una via di mezzo» tra le varie stime che sono
state registrare negli ultimi anni. Nel 2004 il Censis, valutò in 200
miliardi di euro «l'imponibile del sommerso che riguardava il lavoro nero».
Un dato che comprendeva solo una parte dell'evasione fiscale. La Banca
mondiale, di recente, «ha stimato che l'imponibile sconosciuto al fisco» nel
nostro bel paese «si avvicina ai 300 miliardi di euro». FISCOoggi ricorda
che a questi numeri «occorre aggiungere le pratiche evasive ed elusive di
chi conduce una regolare attività». La rivista dell'Agenzia delle Entrate
riporta anche i dati della «nazione modello» per antonomasia del
capitalismo, gli Stati uniti d'America, dove l'«Internal Revenue Service»
(l'agenzia delle entrate americana) stima in 345 miliardi di dollari la
differenza media annua tra le entrate tributarie attese e il gettito
effettivo delle imposte federali». Una cifra che, trasformata in euro, si
aggira verso i 270 miliardi, simile all'imponibile evaso in Italia. Ma i
conti non tornano, perché in America la popolazione è di 300 milioni e in
Italia di quasi 60 milioni; senza contare il fatto che la differenza tra le
due economie va ben al di là della semplice differenza di popolazione.
Inoltre, mentre in Italia vantarsi di «non voler pagare le tasse» è quasi
diventato uno sport nazionale, «88 cittadini americani su 100 considerano
inaccettabile la pratica di non pagarle». E giustamente FISCOoggi registra
anche questo. In paesi come la Gran Bretagna è entrato in funzione il
sistema del «Tax Robot» uno strumento avanzato che « individua, filtra e
seleziona» i siti web che alimentano il business dell'e-commerce e che
vengono utilizzati per evadere l'Iva. In questo modo il sistema fiscale
inglese è riuscito a recuperare - nel 2005 - ben 1,5 miliardi di euro. Se
proprio piace tanto far riferimento all'America e alla Gran Bretagna per il
«libero mercato», sarebbe coerente che i nostri neoliberisti li prendessero
ad esempio anche per la loro capacità di scoprire gli evasori e stangarli.
Reesom, le
torture non bastano
per ottenere l'asilo politico
I pigri
cliché della comunicazione sono più forti dei principi della
Costituzione. Così, testardi come muli e ciechi come
pipistrelli, innumerevoli giornali e televisioni continuano a
definire in blocco "clandestini" gli immigrati che arrivano in
Italia via mare. L'ultimo comma dell'articolo 10 della nostra
carta fondamentale ("lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge")
sembra essere stato abrogato dalle antenne e dalle rotative.
Eppure sono ormai anni che associazioni umanitarie, singoli
volenterosi, docenti di diritto e anche qualche maestro
elementare (perché il concetto è alla portata di un bambino)
spiegano che circa la metà del carico umano delle "carrette del
mare" è costituito da persone che si trovano proprio nelle
condizioni descritte dall'articolo 10. Definirli a priori
"clandestini" è come chiamare "hooligans" tutti quelli che vanno
allo stadio.
Ma va detto che i mezzi di comunicazione di massa non sono gli
unici responsabili di questa quotidiana manifestazione di
analfabetismo civile. A consolidare l'errore contribuiscono in
modo determinante le modalità di attuazione del principio del
diritto d'asilo. Il caso dell'eritreo Reesom ne è un esempio da
manuale.
Bisogna sapere che esiste una via di mezzo tra la decisione di
accordare l'asilo politico e quella di negarlo. Questa via di
mezzo ha un nome soave: "protezione umanitaria". In pratica, se
si ritiene che il richiedente non abbia subito una vera e
propria "persecuzione individuale" ma che, comunque, sia
impossibilitato a rientrare nel suo paese di origine, gli si dà
questa protezione che si traduce in un permesso di soggiorno
valido per un anno. Mentre chi ha avuto l'asilo può, per
esempio, fare il ricongiungimento familiare, il titolare della
protezione umanitaria vive in una specie di limbo, con l'incubo
che, scaduto l'anno, lo stato ospitante decida di espellerlo.
Reesom vive questo incubo da fine settembre. Per convincere la
commissione territoriale che era rimasto vittima di una
"persecuzione individuale" non sono stati sufficienti i segni
delle torture subite nel carcere eritreo da dove è entrato e
uscito per anni, accusato di essere un oppositore politico,
prima come studente universitario che organizzava manifestazioni
contro il regime, poi come militare obbligato a un servizio di
leva di cui non si conosce la fine. Non è bastato che
dimostrasse d'essere un membro del partito di opposizione al
regime, né il fatto che il suo fratello minore (altra pratica
diffusa in Eritrea) sia stato arrestato per ritorsione alla sua
fuga. Reesom, per agevolare i suoi esaminatori, aveva preparato
un appunto dove illustrava nei dettagli le persecuzioni subite.
Ma nel verbale della commissione per la concessione dell'asilo,
compare solo metà del racconto. L'altra metà è rimasta nel notes
di Reesom. Gli esaminatori non hanno ritenuto necessario
ascoltarla. Ma hanno stabilito che le persecuzioni non potevano
essere considerate "individuali" (evidentemente i segni di
tortura erano stati provocati dall'aria di Asmara) e gli hanno
accordato la "protezione umanitaria".
Se l'ovvio ricorso non sarà accolto, se ne riparlerà tra un
anno. Non è escluso che qualche funzionario di polizia decida
che Reesom può tornare a casa, gli neghi il rinnovo del permesso
di soggiorno e lo trasformi in un vero e proprio "clandestino".
O, in alternativa, se sarà espulso e riconsegnato ai suoi
carnefici, in un cadavere
Non toccate le bambine
di Fabrizio Gatti
Sono minorenni. Arrivano dall'Europa
dell'Est o dall'Africa. Ridotte in schiavitù e costrette a vendersi. Non
possono essere espulse. E l'Italia diventa il loro inferno
Quanto vale una ragazza di 18 anni o
forse meno? L'offerta è stata buttata lì qualche sera fa, nel
dopocena sul tavolo di una pizzeria alle porte di Torino. "Se hai 15
mila euro, diventa tua. Pagamento in tre mesi". Pochi minuti per
decidere, tra il caffè e un bicchiere di grappa: "Guardala, è un
affare. Te la porti a vivere con te...". Alla fine il ricatto: "Se
non trova 15 mila euro in tre mesi, dovrà pagarne 50 mila
all'organizzazione che l'ha fatta arrivare in Italia. E sai cosa
vuol dire? Che se non l'aiuti, la manderanno a battere sulla
strada". Paolo G., 41 anni, single, non si aspettava di concludere
la serata con un profondo senso di colpa. Una risposta la doveva pur
dare a quell'amico di mezza età che l'aveva invitato a cena. L'amico
è un imprenditore piemontese con l'azienda che va così così e la
testa piena di Viagra: dopo aver lanciato la proposta, ha aspettato
seduto tra la nuova moglie nigeriana di vent'anni più giovane e la
teenager in vendita, sorella di lei. "Gli ho risposto che avrei
immediatamente portato la ragazza alla comunità del Gruppo Abele",
racconta Paolo G., "ma lui, che bazzica le chiese pentecostali, mi
ha fatto un discorso sul valore del debito e della promessa data.
Insomma, dopo il mio rifiuto avrà provato a vendere sua cognata a
qualcun altro in cerca di moglie. Oppure l'avrà mandata sulla
strada. Se no, come trova quei soldi?".
Nell'Italia marchettara dove tutto si può comprare, anche la
prostituzione si è inventata nuove strade. Compreso il fai-da-te di
famiglia. Non importa se il contratto è per la vita o per dieci
minuti sul sedile ribaltabile di una macchina. Cambia solo il costo.
Eravamo il Paese dei latin lover. Siamo un popolo di clienti. Così
le bande di trafficanti si adeguano. La domanda di sesso a pagamento
aumenta? Loro procurano l'offerta. Con ragazze sempre più giovani.
Fino alle baby-squillo, insulto un po' cinematografico per indicare
ragazzine strappate dai banchi di scuola e mandate in tanga e
canottiera a vendersi sui viali. Alla periferia di Roma le fanno
dormire nelle grotte. La via Salaria è un postribolo di minorenni al
chiaro dei lampioni e spesso anche alla luce del pomeriggio. Lo
stesso, dopo le 11 di sera, diventa via Cristoforo Colombo,
l'arteria che porta al mare e all'aeroporto di Fiumicino. A Milano
non occorre uscire dalla città: ragazze europee e africane sono
tornate a occupare piazzale Loreto, viale Abruzzi, la
Circonvallazione fin dentro i quartieri semicentrali come i Navigli
e il parco Ravizza. Dalle parti di Perugia hanno scoperto una gang
di moldavi che legava le adolescenti alle pareti di una stalla
abbandonata. Ma la distribuzione di ragazze è capillare su tutta la
Penisola. Raggiunge le campagne sperdute, perché lì la domanda dei
clienti su camion e trattori è altrettanto forte. Come lungo la
statale 16, tra Foggia e San Severo, dove non esistono altro che
campi di pomodoro e vigne. La notte le nigeriane bruciano i
copertoni per farsi vedere, di giorno vanno a dormire nell'ex
zuccherificio a Rignano Garganico. Oppure la statale Adriatica da
Rimini a San Benedetto del Tronto. E ancora Bari, Catania, Cremona,
Prato, Aosta, Treviso. Al di fuori dei confini dell'Unione europea
il mondo è pieno di famiglie ridotte alla fame. I trafficanti non
fanno altro che portare le figlie di quelle famiglie là dove clienti
ricchi possono mantenere loro e i loro sfruttatori.
Nessuno conosce quante siano le
prostitute in Italia. C'è soltanto una stima: tra 50 mila e 70 mila
persone e non tutte sottoposte a un controllo violento. Il giro
d'affari è mostruoso: ipotizzando un guadagno a testa di 2 mila euro
a settimana, fa un incasso settimanale di 140 milioni di euro. Ma
secondo Transcrime, l'osservatorio dell'Università di Trento, in
quel totale il numero delle donne prigioniere del traffico di esseri
umani e dello sfruttamento sessuale è in continua crescita. Le
statistiche danno un minimo annuale di vittime (che a volte può
coincidere con l'inverno) e un massimo (l'estate): dalla stima di
17.550-35.500 ragazze nel 2001 si passa a 19.710-39.420 nel 2004. Un
altro istituto di ricerca e assistenza, il Parsec di Roma, fornisce
cifre più caute. Ma comunque spaventose: quasi 23 mila donne
sfruttate. E non c'è solo la prostituzione di strada. Perché la
forma più temuta dalle ragazze resta quella invisibile tra le mura
di night-club e appartamenti. In confronto all'Europa, l'Italia ha
il record: le donne 'vittime della tratta a scopo di sfruttamento
sessuale' sono 115 ogni 100 mila abitanti maschi con più di 15 anni.
Al secondo posto l'Austria con 84 vittime. L'Olanda è ferma a 76. La
Spagna a 54. La Germania a 45. La Francia a 27.
Al ministero dell'Interno, un ufficio sta analizzando i dati per
indirizzare le strategie. "L'arrivo di minorenni prima di tutto:
purtroppo è un effetto indotto involontariamente da noi", ammette un
ricercatore della polizia: "Gli organismi investigativi negli ultimi
anni hanno snobbato le indagini sullo sfruttamento. Per contrastare
il fenomeno le questure hanno scelto la via più veloce dei rimpatri.
Come azione preventiva sono state espulse le donne. Questo ha fatto
crescere l'arrivo di minorenni: perché i minori non possono essere
espulsi. Le organizzazioni hanno poi cambiato politica. Ora alle
ragazze lasciano anche il 30 o il 50 per cento dell'incasso. Ed
evitano di sottoporle a violenze, rapimenti e stupri. Così le
ragazze non scappano, non denunciano e hanno più incentivi a
rimanere nel giro. L'altro aspetto nuovo è la mobilità delle
prostitute. Le fanno spostare in continuazione: una settimana sulla
Salaria, poi sulla Domiziana, poi le ritrovi sulla Romea. Lo
spostamento impedisce eventuali legami affettivi con i clienti. Ma
questo nasconde un dato preoccupante che dobbiamo approfondire:
l'esistenza di una rete comune di contatti tra le squadre di
sfruttatori. Che sulla strada sono quasi sempre romeni o albanesi".
Treviso è una città molto severa con gli stranieri. Grazie a
Giancarlo Gentilini, vicesindaco della Lega, sono state perfino
tolte le panchine nei parchi. Così gli immigrati non si possono
sedere. Ma dopo le 22, lungo le vie intorno alla città, con le
immigrate gli abitanti della provincia possono fare di tutto. Dalla
strada del Terraglio alla Pontebbana. Due ragazze ogni 50-100 metri.
Trenta euro per dieci minuti le europee, 20 le africane. Gentilini,
quando era sindaco rottweiler e difensore della razza Piave, le
aveva protette: "Sono contro gli immigrati", aveva detto, "ma non
contro le prostitute straniere. Che volete? Le prostitute sono le
navi scuola dei giovani". Anche le forze dell'ordine locali hanno i
loro benefici. Quando non sanno come aumentare la statistica di
espulsioni e arresti, pure loro prendono di mira le prostitute: c'è
sempre qualche ragazza clandestina da rimpatriare o da sbattere in
carcere per non aver rispettato la Bossi-Fini.
Giulia, moldava, ex atleta della Nazionale giovanile di pallamano,
si offre a ragazzi, single e mariti della provincia di Treviso e
Venezia. Da quasi due anni si prostituisce sulla strada del
Terraglio. Di solito davanti al comando della polizia municipale di
Mogliano Veneto. Quando la sera chiudono gli uffici, arriva lei.
L'insegna blu e bianca le dà sicurezza. Giulia ha quell'età
indefinita acqua e sapone, tra i 16 e i 18 anni. Se vigili,
poliziotti o carabinieri le chiedono quanti anni ha, lei è pronta a
rispondere 17: per evitare il rimpatrio. Se invece a domandarle
l'età sono clienti preoccupati di finire in galera, dice 19. Così le
hanno insegnato i protettori. Quando ha lasciato la Moldavia, sapeva
cosa avrebbe fatto in Italia? "Sì, l'ho scelto io", risponde. Ha mai
avuto ripensamenti? "Sicuro che non mi piace. Ogni cliente potrebbe
essere quello che mi violenta o mi ammazza. Ma io sono moldava: o
fai questo o fai la fame". Che immagine ha degli italiani? "Un corpo
addosso con le braghe abbassate e il portafoglio in mano". Il
portafoglio in mano? "Sì, la gente di qui è molto legata ai soldi.
Tengono il portafoglio in mano anche quando fanno sesso. Hanno paura
che glielo freghi".
Se passeranno le proposte proibizioniste presentate in Parlamento,
le ragazze come Giulia finiranno in carcere. La logica è piuttosto
singolare: è come se nella lotta al contrabbando, lo Stato invece di
prendere i contrabbandieri avesse arrestato le stecche di sigarette.
È la tipica morale italica: si sfrutti pure, ma non si deve vedere.
L'esempio più famoso è quel consigliere comunale del centrodestra a
Milano. Ha conquistato i voti dei comitati di quartiere scatenando
violente campagne, retate ed espulsioni contro le prostitute
straniere: una notte la polizia l'ha pizzicato in macchina con un
travestito.
Ma come si potrebbe identificare il reato di prostituzione?
Nell'atto sessuale? Nel pagamento? Nella lunghezza della minigonna?
La questione preoccupa sociologi e consulenti dei Comuni più
sensibili. "Un provvedimento del genere", osserva Lorenza Maluccelli,
ricercatrice dell'Università di Ferrara e autrice di saggi,
"spingerebbe le ragazze in circuiti ancor meno visibili e più
pericolosi. Quante sono le donne violentate nel silenzio? Quelle
uccise? Eppure non c'è indignazione perché, per la cultura morale,
se sono prostitute se la sono cercata. Gli uomini invece dovrebbero
cominciare a interrogarsi sulla loro sessualità. Si dice che in
Italia ci siano 9 milioni di clienti. C'è una segregazione mondiale
del lavoro delle donne. Dai Paesi più poveri l'Italia prende
prostitute e badanti. Due forme di servizi alla persona. E non è un
caso che in tutti e due i settori lo sfruttamento di immigrate e
clandestine sia largamente diffuso". A volte le prostitute hanno un
lavoro regolare proprio come badanti. "Ma quando la questura lo
scopre", denuncia Alessandra Ballerini, avvocato della Cgil a
Genova, "il permesso di soggiorno può essere negato. Anche se la
prostituzione non è vietata dalla legge".
Un progetto riuscito di mediazione tra le proteste degli abitanti e
l'andirivieni di clienti l'ha inventato il Comune di Mestre. Qui le
prostitute sono state invitate a trasferirsi in 'zone informali'
meno abitate. Il potenziamento dell'illuminazione stradale,
l'assistenza di unità di strada e la sorveglianza discreta dei
vigili urbani ha convinto ragazze e travestiti a spostarsi nelle
aree indicate. "L'approccio è pragmatico, puntiamo alla riduzione
del danno", spiega il coordinatore, Claudio Donadel: "E ha
sicuramente portato a una migliore convivenza e a un forte contrasto
delle reti criminali. Dal '99, 172 ragazze sono uscite dallo
sfruttamento e più di 680 persone sono state arrestate e condannate.
Ora il progetto sarà esteso al Veneto. Partecipano tutti. Tranne,
ovviamente, Treviso. E Belluno, dove la prostituzione è meno
visibile".
Dal Veneto al Piemonte si muovono i trafficanti della mafia
nigeriana. Uno di loro è famoso a Torino come pastore pentecostale.
E a Verona, in un bar di Veronetta dove lavora, come basista del
racket. Fa parte della rete che costringe migliaia di ragazze
africane a saldare il prezzo della loro schiavitù, vendendosi sulle
strade. Alcuni pastori nigeriani hanno un ruolo fondamentale. Spesso
hanno di fronte giovani spaventate e analfabete. E durante le
prediche le minacciano con le peggiori pene dell'inferno se non
onorano il debito con l'organizzazione. A volte gli avvertimenti si
trasformano in aggressioni ai familiari in Nigeria. Così l'unica via
d'uscita dallo sfruttamento è l'aiuto dei clienti. "Il 90 per cento
delle ragazze nigeriane", spiega Claudio Magnabosco, fondatore del
progetto La ragazza di Benin City, "esce dalla tratta accompagnato
da un uomo, cliente o ex cliente che è diventato amico, fidanzato o
marito". Il progetto punta alla sensibilizzazione dei 'consumatori':
"I clienti, se informati, possono diventare una risorsa. Vogliono
multarli? Facciano pure, ma chi aiuterà le ragazze segregate?". Una
delle vittime della tratta, Isoke Aikpitanyi, è oggi moglie di
Claudio Magnabosco: "Per uscire", racconta Isoke, "basterebbe darci
una opportunità, un permesso di soggiorno anche breve, sei mesi, per
cercare un lavoro vero. In cambio dei documenti, invece, le autorità
pretendono che denunci qualcuno. Dobbiamo far sapere quello che
succede. Le 200 nigeriane assassinate in Italia. Le stuprate. Le
madri alle quali le maman prendono i figli per ricattarle. I black
boy che spacciano droga. Le famiglie che spingono le figlie
minorenni a venire in Europa. La corruzione che favorisce i
trafficanti. Le mutilazioni sessuali, il debito da pagare che non
finisce mai, i pastori cristiani che collaborano con il racket, le
ragazze che muoiono attraversando il deserto. Questa è la tratta.
Davvero pensate che il problema sia la prostituzione?".
Dopo l'accordo tra governo e parti sociali, 6
mesi per scegliere
dall'inizio del 2007. Un vademecum per capire cosa conviene fare
Fondi pensione o
vecchie liquidazioni
che fine farà il Tfr degli italiani
Obiettivo: recuperare almeno una parte del pesante gap futuro
tra attuale stipendio e pensione. I diversi rendimenti a confronto
di ROSARIA AMATO

La firma dell'intesa
governo-parti sociali sul Tfr
ROMA - Tfr o fondi pensione? L'idea di "trasformare" in una rendita
vitalizia la liquidazione (trattamento di fine rapporto), che per decenni è
stata il coronamento di una vita di lavoro, il modo per offrirsi un lusso e
comunque per "stare tranquilli", per acquistare una casa o comprarla ai
propri figli, ha spiazzato molti lavoratori, che adesso devono fare i conti
nel giro di pochi mesi, e scegliere.
Con l'accordo tra governo e parti sociali siglato, dopo molte polemiche il
23 ottobre, si è anticipata di un anno la riforma Maroni che prevede
l'opzione tra il mantenimento del regime attuale del Tfr (non senza alcune
importanti modifiche) e il conferimento della liquidazione ai fondi
pensione. Nelle ultime settimane si è parlato molto della destinazione delle
liquidazioni (aziende, Inps, fondi) ma, forse, non abbastanza di quanto e
come tutto questo inciderà nelle tasche dei lavoratori. Vediamo.
Sei mesi per decidere. Dall'1 gennaio 2007 decorre il termine dei sei
mesi entro i quali tutti i lavoratori dipendenti dovranno scegliere (col
meccanismo del silenzio-assenso) se destinare la parte futura di Tfr ai
fondi pensione. Nel caso in cui il dipendente di un'azienda superiore ai 50
dipendenti non scelga i fondi, il Tfr "inoptato" andrà al fondo della
Tesoreria istituito presso l'Inps. Rimarrà, invece al datore di lavoro nelle
aziende sotto i 50 dipendenti. Ciò significa che, date le prevalenti
dimensioni modeste delle imprese italiane, il 99,5% delle aziende non dovrà
trasferire nulla all'Inps. La scelta è reversibile: in che misura e con
quali modalità dovrà però stabilirlo un successivo decreto.
Necessario integrare la pensione.
La scelta, diretta o indiretta, ha naturalmente delle conseguenze serie
sui lavoratori. L'anticipo della riforma Maroni, la cui entrata in
vigore era stata fissata al 1° gennaio 2008, è stato determinato
soprattutto dall'intento di dare ai lavoratori la possibilità di
costruirsi un'entrata da affiancare alla pensione. Per effetto delle
ultime riforme, infatti, e il graduale passaggio dal sistema retributivo
a quello contributivo, la previdenza degli italiani sarà sempre meno
consistente.
Un "buco" pensionistico dai 45 anni in giù. "Secondo i nostri
calcoli - spiega la professoressa Agar Brugiavini, ordinario di Economia
all'Università Ca' Foscari di Venezia e redattore del sito Lavoce.info -
se nei prossimi dieci anni ci saranno ancora tassi di rimpiazzo (il
tasso di rimpiazzo è il rapporto tra la prima pensione e l'ultimo
stipendio, ndr) tra il 60 e il 70 per cento, già per la generazione
successiva, quella che adesso ha tra i 40 e i 45 anni, si troverà con
tassi di rimpiazzo al 30-40 per cento. L'unica via per coprire questo
buco pensionistico è garantire, specialmente ai giovani, rendimenti più
elevati all'accantonamento ora versato al trattamento di fine rapporto".
Rendimenti: confronto tra Tfr e fondi pensione. Attualmente il
tasso di rivalutazione del Tfr è fissato dall'articolo 2120 del codice
civile, e si ottiene sommando il 75% dell'aumento del costo della vita
per gli operai e gli impiegati (Istat) nel mese in esame rispetto al
mese di dicembre dell'anno precedente, a un tasso fisso pari all'1,5% su
base annua.

Cesare Damiano, ministro del lavoro
L'anno scorso il rendimento del Tfr (calcolato nel modo appena detto) è
stato solo del 2,6%. I fondi pensione di nuova istituzione sono andati molto
meglio con un rendimento dell'8,5%. Quest'anno le cose però stanno andando
diversamente: "Nei primi nove mesi del 2006 - ha detto il presidente della
Covip (l'organismo di vigilanza sui fondi pensione, ndr) Luigi Scimia
a un recente convegno bancario - il rendimento generale netto stimato dei
fondi pensione di nuova istitutizione, pari al 2,4%, è stato leggermente
superiore alla rivalutazione netta del Tfr che, nello stesso periodo, si è
attestata a poco più del 2%. I fondi pensione negoziali (aziendali, ndr)
hanno conseguito un rendimento medio del 2,5% mentre il rendimento medio dei
fondi pensione aperti (quelli privati offerti dalle compagnie
assicurative, ndr) è stato del 2,1%".
Rendimenti, una simulazione 'retrospettiva'. Tuttavia il rendimento
medio dei fondi pensione, spiegano gli economisti, non va valutato e
raffrontato al Tfr anno per anno, ma su periodi lunghi. In Italia
l'istituzione e il decollo dei fondi pensione sono piuttosto recenti,
tuttavia la Covip ha effettuato una simulazione 'retrospettiva', calcolando
"il rendimento teorico che i fondi pensione avrebbero conseguito in periodi
passati sulla base di una composizione media di portafoglio tipicamente
prudenziale, con una percentuale di investimento azionario dell'ordine del
25-30%". E' risultato che tra il maggio 1982 e la fine del 2005 "il
rendimento reale annuo composto dei fondi pensione, pari a circa il 5%,
avrebbe abbondantemente superato il tasso annuo di rivalutazione reale del
Tfr, pari allo 0,2%".
I pro e i contro/1. A questo punto la scelta sembrerebbe praticamente
obbligata. Perchè lasciare il Tfr all'Inps o al datore di lavoro quando si
può ottenere un rendimento ben più cospicuo dai fondi pensione? Per
scegliere però bisogna tenere conto anche di altri fattori. "Resta
confermato che i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e
accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione
del Tfr", si legge nell'accordo sottoscritto il 23 tra governo e parti
sociali. Il che significa che i lavoratori avranno comunque diritto a
ottenere un anticipo del Tfr alle stesse condizioni attuali (per esempio per
l'acquisto della prima casa nella misura del 75% purchè si sia dipendenti da
almeno otto anni, per esempio). Però le cose non stanno esattamente così.
I pro e i contro/2. "Chi sceglie un fondo pensione è vincolato per un
certo numero di anni, di solito cinque o sei", ricorda Agar Brugiavini. E
questo incide sulla possibilità di chiedere anticipi. C'è anche poi una
differenza rispetto alla possibilità di avere parte del Tfr nel corso della
propria vita lavorativa in seguito a interruzione del rapporto di lavoro.
Infatti alla fine di un contratto a termine, o quando un rapporto di lavoro
si interrompe, il lavoratore ha sempre ricevuto finora la parte di Tfr
corrispondente al periodo di lavoro effettuato. Sarà così anche in futuro
per i lavoratori che lasceranno il Tfr in azienda o lo destineranno all'Inps.
"Per chi ha optato per i fondi pensione invece le possibilità sono due -
spiega Giovanni Pollastrini, consigliere del ministro del Lavoro - nel caso
in cui una persona cambi lavoro, potrà chiedere il trasferimento del Tfr nel
fondo negoziale che fa capo alla nuova azienda. Nel caso in cui perda il
lavoro, e rimanga disoccupato o in cassa integrazione, il lavoratore deve
aspettare 12 mesi per riscattare il 50% del Tfr dal fondo presso il quale lo
aveva collocato. Per ottenere il rimanente 50% bisogna aspettare che passino
48 mesi durante i quali permanga la situazione di disoccupazione".
I pro e i contro/3. Naturalmente le conseguenze della scelta tra Inps
e fondo pensione pesano anche arrivati alla fine della carriera lavorativa.
Infatti chi ha effettuato la prima scelta si vedrà consegnare un certo
ammontare di liquidità, rivalutato secondo la paramentrazione stabilita
dalla legge. Gli altri potranno optare tra una rendita che venga calcolata
sull'intera cifra, oppure sulla metà del Tfr rivalutato secondo i rendimenti
del fondo, e chiedere la liquidazione del rimanente 50% in contanti. La
rendita dei fondi pensione è tendenzialmente vitalizia, ma in qualche caso
può essere reversibile. "La reversibilità ha però un prezzo, e incide sul
calcolo della rata corrisposta", ricorda il consulente della Uil Giuseppe De
Nardo.
Fondi chiusi e fondi aperti. Quanto alla scelta tra fondi chiusi e
fondi aperti, che al momento non è possibile (possono optare per i fondi
solo coloro rispetto ai quali è stato attivato un fondo negoziale di
categoria), anche questa presenta pro e contro. I sindacati caldeggiano i
fondi negoziali, ritenendo che offrano più garanzie: "Sono controllati da
un'assemblea dei delegati - ricorda De Nardo - c'è un collegio sindacale,
mentre i fondi aperti hanno semplicemente un responsabile". Inoltre al
momento è previsto un contributo del datore di lavoro solo per i fondi
aziendali, non per quelli aperti (anche se in futuro dovrebbe esserci
un'equiparazione anche sotto questo profilo). Al momento inoltre i fondi
aperti sono più costosi, anche per quanto riguarda la gestione. Ma in
futuro, a parità di condizioni, potrebbero risultare più appetibili per
quelle categorie di lavoratori che sono più propensi a investimenti più
rischiosi ma a più alta remunerazione.
Le garanzie dei fondi pensione. In ogni caso i
fondi pensione costituiscono una forma di collocazione "sicura": "A breve
dovrebbe essere costituito un fondo di garanzia, che si affiancherà a quello
già previsto per le imprese", dice la professoressa Brugiavini. "In ogni
caso un fondo non può fallire, è escluso dalle procedure concorsuali",
ricorda De Nardo. Senza contare tutti i limiti stabiliti per legge rispetto
al tipo di investimento: non si possono comunque scegliere prodotti ad alto
rischio e bisogna rispettare rigidi criteri di bilanciamento.
Non fa una bella
figura l'Italia in tribunale
Daniela Marchesi
Si è celebrata ieri la Giornata
europea della giustizia civile e l’Italia ancora una volta si è presentata a
testa bassa. All’inizio di ottobre il Consiglio d’Europa ha denunciato
deficienze strutturali del sistema giudiziario italiano tali da minacciare lo
Stato di diritto. Non è una novità, ormai da diversi anni l’Italia si posiziona
nella visione di tutte le istituzioni internazionali nelle ultime posizioni per
performance del settore giustizia. Non è solo la preservazione dello Stato di
diritto a preoccupare: una giustizia civile troppo lenta ha un impatto negativo
e rilevante sul grado di
competitività del sistema economico.
L’inefficienza della giustizia civile italiana risiede in alcune carenze dal
lato dell’offerta, ma anche in molte storture che interessano il lato della
domanda. Cosa si sta facendo per correggere le distorsioni?
Dal lato dell’offerta
L’ultimo
rapporto Cepej, pubblicato all’inizio di ottobre, mostra nuovamente che le
risorse pubbliche impegnate nel settore giustizia in Italia non sono scarse, ma
sono in linea con la media di altri paesi dell’Europa a 15, che hanno però tempi
dei processi di molto inferiori. Non è quindi in una carenza di spesa la radice
dell’inefficienza della nostra macchina giudiziaria. Questa affermazione appare
in contrasto con l’esperienza comune: si porta spesso all’attenzione pubblica il
fatto che i tribunali non hanno risorse, al punto da rendere critico anche lo
svolgimento delle attività quotidiane. Le denunce di disagio non sono, tuttavia,
in contrasto con l’evidenza di una destinazione di risorse non esigua al
settore. Emerge dai dati che è la composizione della spesa a risultare
differente da quella degli altri paesi: la componente incomprimibile per
l’Italia è molto alta. Il 77 per cento del budget dei tribunali è assorbito
dalle retribuzioni dei magistrati e del resto del personale. Per l’Austria
questo rapporto è del 55 per cento, per la Francia del 54 per cento, per
Germania e Svezia del 60 per cento.
Differenze importanti si riscontrano anche nel livello degli stipendi dei
magistrati. Mentre all’inizio della carriera la retribuzione dei nostri giudici
è del tutto in linea con quella degli altri paesi, non è così per i livelli più
alti. Fatta eccezione per la Svezia, rappresentiamo il caso in cui la
progressione di stipendio con l’avanzare della carriera (dal livello iniziale a
quelli del grado più alto) è maggiore: 3,2 volte, contro, ad esempio, il 2,4
dell’Austria, il 2,2 della Germania e l’1,7 dei Pesi Bassi. Inoltre, il fatto
che tale progressione avvenga in Italia per anzianità e non per incarichi
svolti, fa sì che la platea di soggetti che ne fruisce sia ampia. Le soluzioni
per incrementare l’efficienza dal lato dell’offerta vanno, perciò, cercate più
in una razionalizzazione della spesa e dell’organizzazione generale del settore,
che in un aumento della quantità di risorse da impegnare.
Cosa si sta facendo
Le disposizioni contenute nella Finanziaria che tagliano
gli incrementi stipendiali legati all’anzianità, ovviamente, non sono di per sé
una soluzione: gli scatti di carriera oggi sono legati soltanto all’anzianità e
quindi un taglio generalizzato riduce la spesa, ma non seleziona in alcun modo
in favore dell’efficienza del servizio. Tuttavia, ha il pregio di porre il focus
su una questione che va risolta. La
riforma dell’ordinamento giudiziario, sia per le tormentate vicende
parlamentari che la interessano, sia per il contenuto dei progetti che si
profilano, non sembra ancora trovare la strada dei rimedi efficaci a questo
problema.
Alcuni segnali positivi vengono invece dal lato della riorganizzazione generale
dei tribunali. Il ministero della Giustizia intende operare tagli e accorpamenti
in modo che tutte le strutture giudiziarie contino su un organico minimo di 14
magistrati. Si tratta di un intervento necessario, ma contenuto nella misura, a
dispetto della vivacità delle proteste che si sono sollevate. Da analisi
econometriche della Commissione tecnica della spesa pubblica e dell’Isae, ad
esempio, emerge che, per il sistema italiano, sarebbe ottimale un minimo di 20
magistrati per tribunale, che il 72 per cento dei tribunali è attualmente
sottodimensionato e che le performance della giustizia sono in passato
migliorate in occasione di riforme che hanno aumentato la dimensione media dei
tribunali. La produttività dei magistrati risulta aumentare al crescere delle
dimensioni del tribunale in cui operano, per effetto di economie di
specializzazione.
La situazione dal lato della domanda
La situazione dal lato della domanda appare anche più
problematica di quella relativa al lato dell’offerta.
La combinazione delle regole del processo civile, di quelle che interessano la
formula di determinazione dell’onorario degli avvocati, la lentezza stessa della
giustizia, generano una serie di
incentivi di comportamento distorti il cui risultato finale è di indebolire
ampiamente la forza contrattuale della parte che ha ragione. L’effetto è quello
di gonfiare la componente patologica della domanda di giustizia civile e di
intasare i tribunali producendo ulteriori allungamenti dei processi. Lo stato di
debolezza contrattuale della parte che ha ragione pregiudica l’utilità di
ricorrere a sistemi di incentivazione all’uso di forme di giustizia alternativa
– le
cosiddette Adr – che hanno avuto successo in altri paesi, ad esempio in
Inghilterra. La riforma più efficace consisterebbe nel sostituire l’attuale
formula di parcella degli avvocati, basata su un sistema a prestazione, in una
forma di compenso a forfait, e di consentire al legale di percepire una quota
rilevante del compenso nel caso in cui una transazione tra le parti si raggiunga
nelle primissime fasi del processo, come avviene in Germania.
Siamo molto lontani da questa ipotesi. Anche le novità introdotte dal decreto
Bersani, che seppure non risolutive avviavano la strada a una riforma dei
compensi, rischiano di essere presto vanificate. Una
proposta di riforma della professione forense, trasversale, presentata
qualche giorno fa al Parlamento prevede che il sistema tariffario resti com’è, a
prestazione, e che i minimi siano per molti casi ristabiliti.
27 ottobre
La verità velata
di Carlo
Bertani
Viene quasi da
piangere ad osservare i dibattiti televisivi: difatti, si cambia presto canale
per non farsi inondare dalla noia più che dall’angoscia. Viene invece da
sorridere nell’osservare l’esibizione di Bruno Vespa a mezzo busto e di Daniela
Santanché a mezza coscia, con a fianco una giovane musulmana velata fino al
midollo.
Cosa dobbiamo ancora sopportare?
Niente, del dibattito, merita d’essere ricordato: un tritatutto di facezie, di
probabili citazioni coraniche, di profusioni d’illuminismo; come contorno
qualche strillo e quelle che vorrebbero essere battute al vetriolo. Dotte
citazioni, professori rampanti, giornalisti esimi, parlamentari “consapevoli”.
Del nulla incombente.
Se potessimo
riavvolgere il nastro del tempo, tutto questo non esisterebbe. Sarebbe bastato
non desiderare fino in fondo al cuore che gli italiani diventassero degli
azzimati britannici, grigi come la nebbia delle Midland, freddi come il vento
delle Highlands.
Per
decenni tutti ci hanno provato, ce lo hanno ripetuto: “L’Italia non potrà essere
mai la Germania , perché ci sono gli italiani”.
Il primo fu Mussolini. O forse no? Forse già Cavour – nella
sua misantropia – disdegnava gli italici umori, al punto che plasmò un
fazzoletto di terra sotto le Alpi come se fosse stato il Devonshire, poi lo
proiettò alla conquista dello Stivale. Appena annessa Genova creò un Consiglio
d’Ammiragliato: a Torino, ovviamente. Sailor’s only.
Nel dopoguerra
tornarono a tuonare – da destra e da sinistra – che eravamo un popolo
indisciplinato, credulone, trasformista. La metamorfosi dell’Italia in una
potenza industriale doveva corrispondere in pieno alla rinascita degli italiani:
non più visionari, fantasiosi, prolifici amanti bensì ordinati cittadini in
cerca d’equilibrio, assennatezza, contenimento.
Ci sono riusciti, con il tempo e tanta ostinazione oggi siamo diventati un
placido gregge che pascola ordinato fra uno steccato e l’altro del Bedfordshire,
troppo “corretti” per alzare lo sguardo oltre la siepe ed osservare altri
greggi.
Sta calando
l’inverno ed il grigio – gli ostinati anti-orgoni di Reich – offuscano la vista
alla mia finestra. Vorrei poter celebrare un rito di purificazione, sciamanico e
selvaggio, per allontanare le nubi incombenti: una cerimonia, una Danza del Sole
in cima ad un colle slabbrato dal vento e deriso dalla pioggia per disintegrare
– io solo – il buio incombente. Follia.
Fra poche settimane le foglie oramai rosse e gialle si rassegneranno a staccarsi
dai rami ed il paesaggio diventerà un’anonima scia di scheletri neri, impalati
sui colli a testimoniare la nostra resistenza al gelo, la nostra ostinazione a
non cedere un metro.
Nella Lucania del
secolo scorso, uomini come noi, italiani, contadini, celebravano il rito del
capro espiatorio, per allontanare – all’inizio dell’inverno – il timore del
“vuoto vegetale”, ossia di quel deserto che rimaneva dopo i raccolti, dopo il
fuoco del Sole sulla terra riarsa dell’estate. Folli.
Oggi siamo così sicuri del ritorno della primavera che non sentiamo il bisogno
di corteggiarla con un rito, non avvertiamo la necessità d’evocarla per tacitare
la nostra paura del vuoto e del buio invernale, del tetro avanzare del freddo
che ci ricaccerà nei nostri cubicoli superbamente arredati – CD, DVD, CCD, DVX,
DDT, ADSL, USB, DS, AIDS – con tutto quel che serve per fare spallucce al gelo
dell’inverno.
Ma, siamo così
certi che il nostro corpo lo sappia?
Nonostante la
nostra modernità, s’ostina a prepararci il rito della purificazione per il
prossimo Febbraio – Februarius, mese delle febbri – quella che oggi
preferiamo chiamare “influenza”. E da chi?
Chi ci
“influenza”? Chi soffia – in flato, afflato – sui nostri corpi per costringerci
a letto? Perché – ancora dopo secoli – serbiamo memoria della purificazione dopo
il sabba di cacce dell’inverno, dopo il sangue delle prede sulla neve ed i
fegati mangiati crudi per sopperire al bisogno (inconscio) di vitamine?
Aggrappati al termosifone saccentemente proclamiamo sentenze, scriviamo facezie,
ridiamo di nulla: tous va bien, madama la Marchesa. Siamo diventati un
po’ français, un poco anglais ed anche un tantino allemand
per il piacere dei tanti, impotenti scialacquatori di cazzate che ci hanno
imboniti per decenni.
La cosa ha
funzionato al punto – curiosità! – che gli italiani non trombano quasi più:
almeno, lo fanno più “correttamente”, “coscienziosamente”, “responsabilmente” e
“consapevolmente”. Per meglio dire, con troppa “mente” e poco corpo, meno sudore
e più docce, poca passione e tanto calcolo. “Posso invitarti a cena” è diventato
quasi sinonimo di “forse, possiamo farci una scopata”: un tempo, queste cose si
lasciavano al linguaggio non scritto dei corpi aggrappati nel ballo, attratti,
sfregati dalla voglia e sfrenati nella passione.
Dal momento che, se si tromba poco o male non si fanno figli, gli italiani sono
destinati nell’arco di un secolo all’estinzione: bene fanno le competenti
autorità e l’esimia società “Dante Alighieri” – insieme ai Lincei ed alla Crusca
– a difendere l’italico idioma, perché sarà la sola cosa che rimarrà della
cosiddetta “Italia”, od “Ausonia”, oppure “Enotria” che dir si voglia.
Insieme
alla pizza ed alla lupara, che diventeranno “patrimonio dell’umanità”.
«Ciò che è
vuoto è destinato inevitabilmente a riempirsi, e ciò che è pieno a vuotarsi»
affermava nella notte dei tempi Lao-Tze, forse mentre osservava l’acqua scorrere
nelle risaie a terrazza dell’antica Cina, oppure mentre ascoltava fremere il
corpo dell’amata.
Ci siamo
riempiti le case di cazzate e le abbiamo svuotate di figli, di parenti, d’amici.
Non sapremmo più vivere nelle vecchie case a ballatoio, con il cortile a fare da
teatro per tutte le passioni e le miserie del caseggiato: avremmo paura. La
privacy: ah già, più il tempo passa e più mi sembra sinonimo del fascista
“me ne frego”.
Svuotati di
passioni, privati di sentimenti, annegate persino le idee nel nome del
“politically correct”, ci coaguliamo – statici – di fronte ad uno schermo di
vetro dove scorrono gli stereotipi della nostra vita, l’ammaestramento che ci è
necessario per continuare a morire di noia.
“La demografia italiana ne soffre” sussurrano dal più alto Colle fino all’ultima
sacrestia dello Stivale: non ci sono più stuoli di ragazzini che riempiono gli
oratori ed i campi di calcio – quelli “liberi”, ovviamente – perché quelli
“targati” qualcosa – fosse anche la squadra del Ranuncolo Rampante – diventano
subito il sogno dei genitori, quello di vedere trasformati i polpacci del
proprio figlio in dobloni.
Con i quali
comprare subito l’ultimo modello di cellulare che invia nell’etere anche frecce,
chewing-gum e pannolini.
Cellulari e viaggi
“last minute”, portatili dei quali useremo il 5% delle risorse e televisori in
ogni angolo della casa: soldi, servono soldi, lavorare, mungere, sfruttare,
vincere per avere altri cellulari, altri viaggi…
A questo ci siamo ridotti: via, non voltiamo il capo dall’altra parte.
E poi non si
fanno figli?
Gli italiani sono civilmente divisi in due grandi squadre: la prima – quella dei
“posso” – non fanno figli perché i figli – quando “puoi” – sono un ingombro.
Come fai ad acchiappare l’ultima offerta di volo per Puerto Escondido se devi
cambiare i pannolini ogni tre ore?
L’altra squadra – quella dei “vorrei, ma non posso” – in genere ha altri
grattacapi cui pensare invece di fare figli: sono la popolazione più strapazzata
d’Europa da tasse e gabelle, da circa quindici anni sono bersagliati da
Finanziarie che tolgono anche l’aria. Sono diventati il tiro al bersaglio delle
classi politiche: provate a fare figli quando vi tocca giocare la parte
dell’orso nel tiro al bersaglio del Luna Park.
Scopate e fate
“Booo” quando vi centrano: sincronizzati, mi raccomando.
Il risultato?
Ecco alcune risultanze sulla demografia italiana.
L’ISTAT ha comunicato nei giorni scorsi i dati sull’andamento demografico
italiano aggiornati al 1/1/2006: si tratta di una rilevazione intermedia fra i
due censimenti, quello del 2001 e quello che ci sarà nel 2011.
Un dato ha attratto la mia attenzione: non quello bruto sul numero degli
abitanti, ma quello che si riferiva al saldo demografico della popolazione
italiana (ossia dei cittadini d’origine italiana residenti in Italia) e quello
degli immigrati.
Risultato: nel
2005, il saldo demografico per gli italiani è stato negativo per un -62.120,
mentre quello degli immigrati è stato un +48.538. Questo non significa che la
popolazione sia diminuita – in realtà rimane grosso modo stabile, perché sono
cittadini comunitari anche polacchi, lituani, ecc – ma cambia, e in fretta, la
composizione della società italiana.
Mancano all’appello circa 62.000 bambini italiani, ed al loro posto ne sono
giunti più o meno 48.000 figli d’immigrati: oramai, il 10% circa delle nuove
generazioni non è più figlia d’italiani.
Se le cifre possono apparire aride, riflettiamo che – ogni anno che passa –
sparisce la popolazione italiana equivalente ad un piccolo capoluogo di
provincia – Vercelli, Teramo o Savona – e nasce una cittadina di giovani
africani ed asiatici di quasi pari grandezza.
Il fenomeno inizia
ad apparire evidente perché svaniscono generazioni numerose, mentre i giovani
italiani sono sempre più pochi. Il calo è iniziato in questi anni? No, il primo
segno d’inversione demografica apparve intorno al 1970 quando – per la prima
volta, ad eccezione degli eventi bellici – una generazione fu meno numerosa di
quella precedente.
|
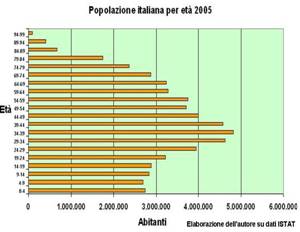 |
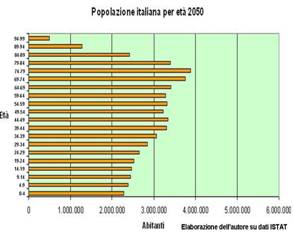 |
|
Popolazione italiana per età 2005 |
Popolazione italiana per età 2050 |
Intorno al
1970, ci fu la prima generazione che era minore della precedente – le persone
che oggi hanno circa 35 anni – e dopo ci fu il crollo: intorno al 1995 si toccò
il minimo, e dopo avvenne un modesto aumento.
La ragione? Gli
immigrati, la prima generazione dei figli degli immigrati nata in Italia.
Il primo grafico è riferito al 2005: si nota chiaramente il decremento di
prolificità degli italiani, che con l’avvento della TV a tutto spiano, delle
Finanziarie straccione, delle crisi economiche, delle classi politiche incapaci,
delle legioni di corrotti – da Tangentopoli a Calciopoli – hanno smesso di
credere nella vita, e non fanno più figli. Il grado di felicità e, soprattutto,
di speranza nel futuro è direttamente proporzionale alla libido ed all’eros:
vorrei sapere con quale serenità scopa chi non sa se il mese dopo avrà ancora un
posto di lavoro, chi aspetta di sapere se la prossima Finanziaria gli toglierà
il sussidio per l’affitto, chi sa di dover emigrare soltanto perché è nato dalla
parte sbagliata.
L’altro grafico
è invece lo scenario immaginato dall’ISTAT per il 2050, che già prevede un
costante flusso migratorio! Senza di esso, l’Italia non esisterebbe praticamente
più!
Come si può notare dal confronto fra i due grafici, la “base” del 2050 è assai
più larga (in termini relativi) di quella del 2005, anche se in termini assoluti
la popolazione è minore. Per riequilibrare la demografia italiana dobbiamo
rendere più omogenei i “numeri” delle varie generazioni, altrimenti ci
scontriamo con l’evidente squilibrio del grafico per il 2005. L’unico rimedio?
Più immigrati.
Tutti lo raccontano e riconoscono che l’unico modo per risolvere il problema è
l’arrivo di “carne fresca”, perché il nostro modello è oramai fottuto: siamo
andati troppo oltre – sia quelli che partono per il Kenya sia coloro che sostano
di fronte all’agenzia di lavoro interinale – e per noi, intesi come “razza
italiana”, non c’è più speranza.
“Il periodo
critico economico inizia con il 2005 – sono presenti i molti nati negli anni
1945-'58 ormai verso la pensione (13 milioni che si assommeranno ai precedenti
degli anni '30-'45, circa 7 milioni e ciò significa maggiori spese di previdenza
e di assistenza) – più quelli altrettanto numerosi del 1960-'78 con poco reddito
per il calo della produzione, dovuta alla contemporanea carenza di soggetti
della fascia giovanile 1980-'99 (che sono i maggiori consumatori).
Nell'ambito della produzione si accavallano quindi due fenomeni fortemente
negativi: sono presenti i morigerati consumatori della prima fascia demografica
(quasi un terzo della popolazione in pensione) che non dispone di grandi mezzi
economici per il consumismo, e contemporaneamente la presenza di una bassissima
fascia giovanile nella misura del 50% in meno rispetto agli anni precedenti il
1980 (negli anni '60 e '70 nascevano circa 1.000.000 di italiani
(l’anno, n. d.
A.), negli anni '90 la metà, 500.000, quindi in entrambe le due fasce (tanti
vecchi – pochi giovani) ci sarà un numero bassissimo di consumatori, in
particolare nei secondi (scuole, divertimenti, sport, vestiario, consumismo
tipico delle fasce in piena vigoria fisica e antagonistica).”
(www.cronologia.it)
La situazione
preoccupa anche i Giovani Industriali:
“Intanto nel nostro Paese cresce in modo esponenziale il “bisogno
demografico” di immigrati.
I paesi europei sono tra i più vecchi al mondo e tra questi
il primo posto spetta proprio all’Italia, dove già oggi il 24,5 per cento della
popolazione è costituito da ultrasessantenni.”
E
ancora:
“A determinare questa inversione della piramide demografica, in Italia, è –
prima ancora che il rapido allungamento della vita media – il crollo della
natalità degli ultimi decenni e quindi, negli ultimi anni, della popolazione in
età lavorativa.”
Infine:
“Uno scenario del genere traccia un’unica strada per il mantenimento degli
attuali livelli di benessere del nostro Paese: governo e integrazione dei flussi
migratori.
Né si può
riporre troppa fiducia in politiche tese a favorire la fecondità degli italiani,
politiche che potrebbero solo rallentare il declino della popolazione giovane in
età lavorativa.”[1][1]
Come si può notare,
Confindustria non crede in un ribaltamento della natalità degli italiani – anche
prevedendo misure economiche “ad hoc” – e non sposa affatto le teorie
isolazioniste e xenofobe di certi ambienti politici nostrani: i grandi difensori
della piccola e media impresa – con la Lega Nord in testa – sono sconfessati
proprio da coloro che ritengono essere i loro referenti. Perché?
Perché lor signori pensano soltanto a salvare quel modello economico che si è
rivelato perdente, al punto da condurre intere generazioni alla sterilità
psicologica!
I consumi, per Dio!
Non sia mai che crollino i consumi, altrimenti l’anno prossimo mi potrò solo
sognare il trekking sulle Ande ed il safari fotografico in Kenya!
La
produzione, per Dio! Se non c’è nessuno che lavora, come produciamo per
consumare?
E poi noi saremmo dei folli, soltanto perché predichiamo da anni che l’economia
liberista non solo conduce al collasso ecologico del pianeta, ma ci sta
uccidendo nella psiche e nel corpo?
Quale segnale
attendere ancora, quale messaggio è più forte di una specie che non si riproduce
più? Non
basta riflettere che metà della popolazione – chi più e chi meno – fa uso di
psicofarmaci?
Come delle serpi,
ipnotizziamo le future prede che attraversano il mare su malferme barchette dopo
aver morso l’esca fatta di talk-show e telefonini, oppure sospinte come branchi
d’acciughe verso la rete dagli squadroni della morte che seminiamo nel mondo,
dal Kurdistan al Sudan, dalla Colombia alla Cecenia.
Siamo i colonizzatori culturali del pianeta, ovvero coloro che predicano un
modello vincente per l’accumulazione capitalista e perdente per la biologia
dell’essere umano.
Che gran
premi Nobel siamo.
Quando le nostre prede sono finalmente giunte da noi – perché senza di loro
andremmo a fondo in mezzo secolo – vogliamo che acquisiscano – e in fretta! – i
nostri usi e costumi, abbandonando immediatamente le loro tradizioni.
Così
mandiamo in scena i mezzi busti e le mezze cosce per tentare l’ennesima
operazione di colonizzazione culturale, deridendo chi ha un imprinting culturale
diverso dal nostro. Migliore? Peggiore? Limitiamoci a ricordare che da mezzo
millennio siamo noi che andiamo per il pianeta con le cannoniere, non gli
africani e gli asiatici. Inoltre, ricordiamo che la parola “stupro” non esiste
nei linguaggi primitivi del pianeta, ma solo nei cosiddetti paesi “civili”.
Proporrei per le prossime trasmissioni d’inserire, oltre ai mezzi busti ed alle
mezze cosce, anche le “Veline” – ovviamente velate – per completare il tripudio
di stupidità con il quale cerchiamo d’affrontare un problema semplice, ma serio,
come quello dell’immigrazione.
Se ne
abbiamo bisogno, perché fare tante storie?
Una volta stabiliti alcuni punti fermi: il viso scoperto, ed io aggiungerei la
laicità della scuola, ciascuno potrà professare come meglio crede la propria
fede, senza scatenare battaglie fra mezze cosce e mezzi veli.
Vorrei concludere con le parole di un grande giornalista italiano – Paolo Rumiz
– che così sintetizzava ciò che avvenne in Bosnia – primo sentore della frattura
dei due mondi, prima dell’11 settembre – quando fu distrutto il ponte di Mostar,
simbolo e crocevia di più culture.
“Ripensando
a quel crollo col senno di poi, vedi che il conflitto di civiltà nacque allora,
e non fu uno scontro fra Cristianesimo e Islam.
Non fu nemmeno una
resa dei conti fra democrazia dell'Ovest e assolutismo dell'Est, moscovita o
ottomano che fosse. Fu l'aggressione della modernità contro un mondo che si
ostinava a credere nell'invisibile, la rabbia di una civiltà senza più miti e
senza più fede contro un Oriente che condensava troppi simboli.”[2][2]
I figli, più che il
prodotto del denaro, sono il frutto dei nostri sogni, oramai azzerati. A futura
memoria.
Starbucks e
l'Etiopia alla guerra del caffè
Appoggiato dall'ong Oxfam il
governo di Addis Abeba lancia una campagna globale contro il gigante
Usa:"Sfrutta i contadini"
di FRANCESCA CAFERRI
 In
uno qualunque degli oltre 10mila negozi Starbucks sparsi nel mondo,
portarsi al tavolo o sulla scrivania dell'ufficio una tazza fumante
di caffè Sidamo costa circa 2,20 dollari. In tazza non ci sono che
pochi grammi dei chicchi neri che danno il nome alla bevanda: tanto
che se fosse venduto al chilo il prezioso Sidamo costerebbe
all'avventore la bellezza di 50 dollari. Eppure a chi quel chilo di
caffè lo ha piantato, coltivato e raccolto in tasca non arrivano che
2,40 dollari. La vicenda sarebbe una delle tante storie di economia
deviata dalla globalizzazione, se non coinvolgesse due dei più noti
volti della globalizzazione stessa: Starbucks, la catena del caffè
regina in America e nel mondo, passata alla storia anche perché
riesce a vendere in tutto il mondo una bevanda dal nome di "frappuccino"
facendola passare per una tipica specialità italiana, e Oxfam, una
delle più vecchie e rispettate associazioni non governative del
mondo, che da Londra ha fatto del suo marchio un sinonimo di "giusto
e buono" riconosciuto in tutti i paesi. In
uno qualunque degli oltre 10mila negozi Starbucks sparsi nel mondo,
portarsi al tavolo o sulla scrivania dell'ufficio una tazza fumante
di caffè Sidamo costa circa 2,20 dollari. In tazza non ci sono che
pochi grammi dei chicchi neri che danno il nome alla bevanda: tanto
che se fosse venduto al chilo il prezioso Sidamo costerebbe
all'avventore la bellezza di 50 dollari. Eppure a chi quel chilo di
caffè lo ha piantato, coltivato e raccolto in tasca non arrivano che
2,40 dollari. La vicenda sarebbe una delle tante storie di economia
deviata dalla globalizzazione, se non coinvolgesse due dei più noti
volti della globalizzazione stessa: Starbucks, la catena del caffè
regina in America e nel mondo, passata alla storia anche perché
riesce a vendere in tutto il mondo una bevanda dal nome di "frappuccino"
facendola passare per una tipica specialità italiana, e Oxfam, una
delle più vecchie e rispettate associazioni non governative del
mondo, che da Londra ha fatto del suo marchio un sinonimo di "giusto
e buono" riconosciuto in tutti i paesi.
La storia: Oxfam accusa Starbucks -
che del corretto rapporto con i coltivatori e della sua politica
commerciale etica ha fatto negli ultimi anni uno dei cavalli di
battaglia della sua strategia di marketing - di aver bloccato,
nascondendosi dietro alla National coffee association, di cui è uno
dei più potenti membri, il tentativo dell'Etiopia di far registrare
i nomi di tre delle sue più pregiate varietà di caffè - Sidamo,
Harar e Yirgacheffe - presso l'ufficio americano dei brevetti, l'Uspto.
Addis Abeba ha presentato la domanda
più di un anno fa ma la richiesta è bloccata dall'opposizione della
Nca, che vuole che l'utilizzo dei nomi, e dei chicchi, resti libero
da ogni copyright. Fra carte bollate e avvocati, tutto è fermo da
mesi e la battaglia legale non sembra destinata a finire presto, con
grande delusione dei coltivatori etiopi. Se la registrazione fosse
approvata, chiunque utilizzasse chicchi di queste piante dovrebbe,
oltre a garantire la loro origine, pagare un diritto di sfruttamento
del marchio al governo di Addis Abeba: una mossa che porterebbe
nelle casse del paese - uno dei più poveri del mondo, con un Pil
pro-capite di 160 dollari l'anno e un'aspettativa di vita media di
47 anni - 88 milioni di dollari l'anno, un incremento sostanziale
rispetto ai 156 milioni (dati 2002) che vengono ricavati
dall'esportazione del caffè.
Starbucks nega decisamente di essere
il regista dell'impasse: "Non ci siamo mai opposti alla
registrazione del governo etiope, né abbiamo preteso di avere la
proprietà di nessuno dei nomi regionali che usiamo per descrivere
l'origine dei nostri caffè", spiega la società in un comunicato in
cui si sottolinea anche come il gruppo abbia incrementato in quattro
anni gli acquisti dall'Etiopia del 400%, con beneficio dei
coltivatori a cui è stato pagato un prezzo di poco meno di 3 dollari
al chilo, il 23% in più del prezzo di listino medio per quelle
stesse qualità di caffè. "Il nostro approccio, fatto di investimenti
in progetti di utilità sociale e di microprestiti alle popolazioni
delle regioni di coltivazione sono stato riconosciuti per la loro
leadership nell'industria del caffè", conclude la nota.
Ma le spiegazioni non sono bastate a
Oxfam: sentitisi traditi da un vecchio alleato - Oxfam e Starbucks
hanno collaborato per il 2004 in progetti di sviluppo rivolti
proprio ai contadini etiopi - i responsabili dell'ong hanno portato
a parlare con i giornalisti nel giorno del lancio della loro
campagna Tadesse Maskela, capo di una cooperativa di coltivatori di
caffè etiopici. La donna ha dato voce alla rabbia di 15 milioni di
contadini del suo paese che sui ricavati della vendita dei chicchi
neri basano la loro sopravvivenza. "Starbucks vende i caffè Sidamo e
Harar a 26,29 dollari alla libbra (450 grammi) proprio a causa della
particolare qualità dei chicchi - ha detto la donna - ma i contadini
in Etiopia guadagnano fra i 30 e i 59 centesimi per la stessa
quantità".
Un grido di disperazione che da solo
non creerebbe molti preoccupazioni a Starbucks, ma che sposato alla
potenza mediatica di Oxfam - già ieri la storia era su tutti i
principali giornali europei - di danni potrebbe invece crearne
parecchi, anche a un gigante globale come Starbucks.
26 ottobre
Tanti straordinari e poca paga
La funambolica vita dei
collaboratori

Lavorano anche fino a 45 ore a settimana. Nel
settore privato il 63% dei lavoratori con contratti atipici rimane al
lavoro per più di 38 ore a settimana. Stagisti e tirocinanti più di
tutti. Due collaboratori su tre nella stessa azienda da oltre due anni.
I risultati dell'indagine Ires-Cgil. di FEDERICO PACE
La loro è una vita da funamboli.
Tutta trascorsa, passo dopo passo, sopra l'esile filo del contratto a tempo
che li difende dallo spazio vuoto che s’apre sotto di loro. Una vita “a
tempo” pervasa dal timore di non riuscire ad arrivare dall’altra parte del
filo. Così gli atipici vivono nelle aziende come se dovessero sempre
dimostrare, ogni giorno, quel che valgono. Tanto che negli uffici rimangono
sempre più tempo. Volenti o nolenti. Molti di loro possono arrivare a
lavorare 45 ore per ciascuna settimana del loro impiego “a tempo”. Nel
settore privato, più di sette stagisti e tirocinanti su dieci, lavorano per
un tempo che supera costantemente le 38 ore a settimana. Ma è il complesso
del mondo degli atipici che si misura con orari di lavoro lunghi o
lunghissimi nonostante l’incertezza del posto, o proprio a causa di questo.
Sono questi alcuni dei risultati
dell’indagine “Il lavoro para-subordinato a rischio di precarietà in Italia”
dell’Ires (Istituto di ricerche economiche e sociali) che ha analizzato le
condizioni di lavoro, i percorsi e le prospettive dei lavoratori e delle
lavoratrici con contratto di collaborazione. La ricerca è stata presentata
oggi a Roma in occasione dell'uscita del 1° Rapporto dell'Osservatorio
permanente sul lavoro atipico in Italia ("I parasubordinati nel 2005.
Analisi dei dati Inps gestione separata".)
Nel dedalo del contratto di
collaborazione ci sono finiti un po’ di tutti. I traduttori, gli psicologi e
i giornalisti. I geometri, i tecnici informatici e i webmaster. Ma anche, e
soprattutto, gli operatori di call center, gli stagisti e i borsisti.
Comunque sia, sta il fatto che tutti loro, spesso, hanno davvero poco dei
collaboratori autonomi. Piuttosto sembrano avere molte delle caratteristiche
dei dipendenti.
Otto su dieci svolgono un lavoro
per un solo committente. Soprattutto se hanno un contratto di lavoro a
progetto o un co.co.co. nel pubblico. Due su collaboratori su tre lavorano
nella stessa azienda da oltre due anni. Questi elementi, dicono gli autori
dell’indagine, “alludono a una dipendenza di fatto, almeno di natura
economica, confermata dal fatto che, anche dal punto di vista
dell’organizzazione del lavoro, pressoché tutti i collaboratori intervistati
hanno un rapporto di quasi dipendenza.” L’80% lavora presso la sede del
committente, il 77% deve garantire un presenza quotidiana e il 71 per cento
deve rispettare un orario di lavoro.
Il tutto senza una paga
commisurata agli sforzi e con poche certezze riguardo le prospettive future.
Il 31% di questa categoria di lavoratori guadagna meno di 800 euro netti al
mese e un altro 26 per cento arriva a guadagnare mensilmente una cifra
compresa tra 800 e mille euro. Solo uno su dieci di loro riesce a superare i
1.500 euro . E all’aumentare degli anni trascorsi nello stesso posto di
lavoro, fanno notare gli autori della ricerca, “diminuisce la propensione a
concepire quella come una esperienza transitoria destinata ad arricchire il
proprio curriculum professionale mentre aumenta la rassegnazione a non avere
affatto alcuna prospettiva professionale” .
Ma non solo. Le condizioni
economiche e l’incertezza relativa ai percorsi e alle prospettive
professionali sembrano avere un diretto impatto sulla possibilità di dare
vita a un progetto familiare: il 51,2 per cento di chi ha più di 35 anni non
ha figli e accade all’82% di tutti i collaboratori senza distinzioni di età.
C’è ancora tempo per fare
qualcosa per ridurre l’ambiguità delle collaborazioni? “Non si può più
aspettare - ci ha detto Giovanna Altieri , presidente dell’Ires e
coordinatrice della ricerca realizzata da Eliana Como -. Sono dieci anni che
studiamo questo fenomeno, e molti risultati assomigliano ai dati delle prime
indagini. Non si tratta più di capire questo mondo, ma di dare delle
risposte a questo mondo. Non si deve trascurare il fatto che le
collaborazioni corrispondono a un modello di flessibilità basato sulla
riduzione del costo del lavoro. Ma usare forza lavore in termini di
riduzione di costi non aiuta il Sistema Italia. Le persone vanno intese come
capitale sociale e come valore delle imprese.”
Televisione
L'inchiesta di Report sulla piovra dei «cattivi consigli»
Gli uomini d'oro dei Cda pubblici
Riproponiamo ampi stralci del programma di Raitre dedicato ai compensi
«eccellenti» dei consiglieri di amministrazione degli enti pubblici. Dalle
autostrade alla Rai
Report - L'Enel Poste Italiane,
L'Anas, Ferrovie Dello Stato, Alitalia, sono le più grandi aziende pubbliche
italiane. Nei loro consigli d'amministrazione siedono i manager che fanno
funzionare i servizi primari del paese. Il numero di membri minimo previsto
dalla legge sarebbe 3. Alle poste i consiglieri sono 11. La Rai ne ha 9, il
Poligrafico dello Stato 10. Alitalia e Ferrovie 5. Gestore della rete
elettrica 7, all' Eni sono in 12, all'Enel 9.Quanto costa il consiglio di
amministrazione di Enel?
Paolo Scaroni, vicentino, studi alla Bocconi e a New York, all'inizio degli
anni '90 è Amministratore Delegato della Techint ma inciampa nell'inchiesta
Mani Pulite e viene arrestato per aver pagato tangenti ai partiti per
ottenere appalti da Enel. Patteggia la pena e va in esilio in Inghilterra
dove si ricicla come manager della Pilkington. Poi torna in patria e il
governo Berlusconi e lo nomina Amministratore Delegato proprio di Enel. Nei
tre anni della sua gestione secondo i dati Istat la nostra bolletta è
aumentata del 3,5 %. . Sulle fonti alternative però non abbiamo fatto nulla.
Inoltre Scaroni ha venduto impianti, aziende ed immobili, in sostanza ha
arricchito l'azionista e impoverito l'Enel. E questo sarebbe il
miglioramento di gestione che spiega la milionaria buonuscita. Nel 2005
Scaroni va all'Eni, il suo stipendio è di 1 milione e mezzo di euro l'anno.
Il consiglio di amministrazione costa 2milioni 600 mila euro l'anno ma, come
all'Enel, la cifra sul bilancio è più alta perché comprende incentivi per
gli amministratori e 9 milioni 649mila euro di liquidazione a Vittorio
Mincato, il predecessore di Scaroni. Ed è vero che se Scaroni andasse via
anche da ENI prenderebbe un'altra liquidazione di più o meno 8 milioni?
Roberto Ulissi, Direttore affari societari Eni - Queste
previsioni sono contenute nel contratto.
Report - Il contratto dice che se il mandato non viene rinnovato saranno
pagati altri 3 anni di stipendio. Scaroni decide lui di andare all' Eni ma
esige comunque dall' Enel i 3 anni di buonuscita. Giancarlo Cimoli se ne
andò da Ferrovie nel 2004. Il suo mandato era scaduto e non fu rinnovato.
Ebbe una buonuscita di 6,7 milioni di euro. Lunardi lo manda a risanare
Alitalia, gia' sommersa dai debiti: aveva previsto che il 2006 sarebbe stato
l'anno del pareggio invece, dopo 2 anni dal suo arrivo, Alitalia è sull'orlo
del fallimento.
Andrea Cavola, Sindacato Unitario Lavoratori Trasporti - La
semestrale di quest'anno parla di 221 milioni di passivo, le previsioni a
fine anno sembrerebbero 350 milioni di passivo, negli ultimi 2 anni oltre
3mila lavoratori hanno lasciato l'azienda, i nostri contratti sono bloccati
da anni quindi il costo del lavoro è stato attaccato pesantemente ed è uno
dei più bassi rispetto ai nostri competitor europei.Dati ufficiali iscritti
a bilancio: l'Ad di Air France guadagna 30mila euro al mese, quello di KLM
45mila, quello di British 64mila e parliamo di 3 compagnie in attivo. Il
nostro amministratore delegato prende 190.000 euro al mese.
Report - Il consiglio di Ferrovie costa circa 2 milioni di
euro l'anno. L'amministratore delegato, Elio Catania, è stato costretto a
dimettersi, e come prevede il contratto si è portato via il risarcimento. A
quanto ammonta lo abbiamo chiesto all'azionista ma il Ministero del Tesoro
ci ha scritto che non possono essere rese note per una clausola di
riservatezza. Quel che è noto è che Catania era arrivato due anni fa, doveva
far viaggiare le ferrovie e invece lascia Trenitalia con un buco di 1
miliardo e 700 milioni di euro.
Sergio D'Antoni, Sottosegretario allo Sviluppo Economico -
Io non li avrei dati.
Report - Anche perché Catania ha lasciato un buco di 1
miliardo e 6?
Sergio D'Antoni - Sono contrario a dare soldi per fare
andar via le persone assolutamente. Perché mi pare che questo sia un errore.
è stato fatto: Amen.
Report - Ma chi stabilisce le regole d'ingaggio? Il
consiglio d'amministrazione presieduto da loro stessi e quando una poltrona
si sfila di solito ce n'è una pronta. L'Anas ha una rete stradale di 20.182
chilometri e oltre 6.000 dipendenti. è l'azienda che decide come fare una
strada o un'autostrada. L' Anas è appunto la viabilità. Per ampliare e
risanare le nostre infrastrutture il presidente del consiglio aveva promesso
in diretta tv, l'8 maggio 2001, 158 miliardi di investimenti. E nel 2003
ribadiva l'impegno.Siamo a settembre 2006 e sulla tangenziale di Mestre ci
sono i 4 chilometri di coda di sempre. Mestre era 1 delle grandi opere della
legge obiettivo del 2001: il passante costa 750 milioni, ne abbiamo spesi
150 ma solo 63 per i lavori. E siamo fermi. Per le Grandi opere mancano più
di 100 miliardi di euro e nemmeno il 30% risulta finanziato. Ci sono state
anche finte inaugurazioni come la Palermo Messina. Secondo i magistrati gli
ultimi 41 km non avevano i requisiti minimi di sicurezza: semafori, vie di
fuga e così via. Gli indagati sono 8. Azionista unico di Anas è il Ministero
del Tesoro che decide chi la deve dirigere insieme al Ministero delle
Infrastrutture, con il nuovo governo Lunardi se ne va e arriva Di Pietro.
Chiede la verifica dei conti e i conti non gli tornano. Non ci sono i soldi
per andare avanti con i cantieri. Consegna i dati alla Procura e invita il
Consiglio di Amministrazione dell' Anas ad andare a casa.
Antonio Di Pietro - Ministro delle Infrastrutture L'Anas ha
cercato di moltiplicare pane e pesci per cercare di venire incontro alle
persone politiche per fare le opere non avendo i soldi ha dato anticipi in
relazione a opere non coperte completamente.
Report - Il cdao di Anas si è dimesso. Di Pietro dice che
il buco è di 5 miliardi di euro e parla di consulenze e buonuscite per i
manager e sospetta il falso in bilancio.
Mario Virano - Consigliere Anas fino al 2006 - Il falso in
bilancio non esiste. Questi rilievi sono stati controdedotti dalla direzione
generale, dal collegio sindacale, dalla Corte dei Conti e sono stati
riassunti all'interno di un bilancio che è stato certificato dalla Kpmg
senza riserve.
Antonio Di Pietro - A un certo punto è stato detto siccome
quelle opere di cui ai residui passivi non si fanno più con quei soldi ci
facciamo un'altra cosa. In realtà con quei soldi ci stavano già facendo la
prima cosa. Sicché con gli stessi soldi ci hanno fatto due cose
contemporaneamente, ma siccome i soldi erano sempre quelli ci siamo trovati
con un debito. Con un indebitamento di 3 miliardi e mezzo di euro circa.
Report - Ma allora perché questo consiglio di
amministrazione dell'Anas non ha detto prima non abbiamo i soldi?
Mario Virano - Nel momento in cui il governo impone con
legge finanziaria un tetto di 1,9 miliardi di euro si sa che con quella
somma lì si arriva poco più che a metà anno dopodichè ci si deve bloccare.
Questo lo si sapeva al momento della promulgazione della legge finanziaria,
è stato immediatamente segnalato all Presidente del Consiglio, al ministro
Tremonti, al ministro Lunardi, cioè a tutto il governo.
Report- Quindi tutti zitti e al loro posti fino alle
elezioni. Era andata così anche nel 2001, con l'arrivo di Lunardi tutti a
casa, addirittura lui li paga molto più del dovuto perché lascino libere le
poltrone. D'Angiolino, ex ufficiale della Gdf, era il presidente. Da
contratto avrebbe dovuto restare altri 4 anni, ma Lunardi lo manda a casa.
Lei ha una liquidazione di 2 miliardi e 800 milioni circa?
Giuseppe D'Angiolino- Presidente Anas fino al 2001 - Il
contratto non è stato rispettato, io non ho ricevuto, gli importi che erano
indicati sul contratto di risoluzione del rapporto di lavoro e dovrò
chiedere conto a chi ha firmato il contratto con me: il ministro Lunardi.
Report - Lunardi li manda a casa in fretta in cambio di una
buonuscita o risarcimento: 2 miliardi e 8 per il presidente, 650 milioni per
ogni consigliere, in totale sono quasi 6 miliardi di lire. Le lettere
arrivano sul tavolo di tutti i consiglieri il 19 ottobre 2001, la firma è di
Pietro Lunardi. Si liquida un cda e si paga per intero intanto se ne assume
un altro che si paga per intero. È una doppia spesa con soldi pubblici o
sbaglio?
Ivan Cicconi - Consigliere Anas fino al 2001 - Esatto!
Report - Ma lei lo sa che il ministro che l'ha preceduta
per mandare via il precedente consiglio d'amministrazione di Anas aveva dato
più di 5 miliardi e mezzo di lire. Lei ha dato dei soldi a questi per
andarsene?
Antonio Di Pietro - Manco una lira! Ho chiesto alla corte
dei conti di valutare. Non so se mi spiego. Glielo ripeto: perché io ho
l'impressione che questi soldi chi li ha presi li deve rimettere, quelli
della scorsa amministrazione. Ho chiesto alla Corte dei Conti di farseli
ridare.
Report - Da Lunardi che ha dato l'ordine come se fossero
soldi suoi, da chi li ha incassati o dal ministero.
Ivan Cicconi - Personalmente dal ministro delle
infrastrutture, dall'ing. Pietro Lunardi perché il cambiamento è avvenuto
solo per un interesse personale del ministro Lunardi. Ce l'aveva a morte con
D'Angiolino perché quando era Presidente Anas gli revocò degli incarichi.
Report - Per tutta la storia Rocksoil?
Ivan Cicconi - Si lui era consulente dell'Anas per un paio
di gallerie e normalmente quando interveniva Lunardi i costi aumentavano a
dismisura. Lui gli revocò un paio di incarichi e gliela teneva carica e
appena è andato lì gli ha chiesto le dimissioni.
Report - La famiglia Lunardi ha una società che costruisce
gallerie, è la rocksoil. Per eseguire i lavori occorre l'autorizzazione
dell'anas. Secondo d'Angiolino, presidente di Anas, qualche progetto della
Rocksoil è troppo caro e chiede a Lunardi di abbassare il preventivo.
Giuseppe D'Angiolino - Ricordo un progetto particolarmente
costoso arrivato alla mia firma, la firma finale. L'avevo ritenuto
eccessivamente costoso e non lo lasciai passare. Lo feci rivedere e il costo
dell'opera venne abbastanza ridimensionato.
Report - Poi Pietro Lunardi diventa ministro e cede la
Rocksoil ai figli Martina e Giuseppe. Interpellanze parlamentari, una era
finita in procura: quella sugli appalti per un raccordo autostradale in Val
d'Aosta. Un'altra riguardava una consulenza per la Torino-Lione. Lunardi
fece sapere che quel rapporto era chiuso. Altre interpellanze, riguardano
Ergotecna che fa progettazione e direzione. Il cugino di Lunardi, Giacomo
Rozzi, ha il 65%. Invece la stone di Milano, che era dei Lunardi, viene
venduta e da quando passa di mano diventa una delle più potenti società per
i lavori in galleria. Il responsabile è Mario Cangiano, socio del cugino di
Lunardi in ergotecna. Non conosciamo la versione di Lunardi sulla vicenda
perché non accetta l'intervista.
Report - Lei come ci è entrato nel Cda dell'Anas?
Ivan Cicconi - Nominato dal ministro dei lavori pubblici
Nerio Nesi.
Report - Poteva aspettarselo che se cambiava governo la
mandavano via.
Ivan Cicconi - Potevo aspettarmelo però non c'erano i
presupposti per un ministro che si fosse comportato rispettando la legge.
Chiedere le dimissioni e obbligare alle dimissioni e pagare i dimissionari.
Direi che è la prima volta che capita questo caso dell'Anas di 5 anni fa.
Report - Si considera deplorevole essere mandati a casa
dietro compenso ma nessuno rifiuta di incassare. Anche con Di Pietro il CDA
dell'Anas ha dovuto dimettersi senza però sborsare una lira. Ma quanto costa
il consiglio di amministrazione dell'Anas? Il presidente Vincenzo Pozzi,
appena uscito, nel 2005 ha dichiarato 438mila euro di reddito. Quanto
prendeva invece D'Angiolino 4 anni prima? 350 milioni all'anno, ora siamo
passati a 400 mila euro, lo stipendio del presidente è raddoppiato. Mentre
l'Anas perdeva 496 milioni.
Ivan Cicconi - I consiglieri di amministrazione prendevano
150 milioni all'anno lordi. Era prevista una riunione ogni settimana.
Report - E voi quanto prendete?
Giovanbattista Papello, Consigliere Anas fino al 2006 - Il
compenso diciamo era articolato e andava da 40.000 a 140.000 euro a seconda
diciamo...
Report - 40.000 più 140.000 no?
Giovambattista Papello - 40mila più 140mila per le attività
che si svolgevano sotto forma di delega o incarico.
Paolo Brutti - senatore DS - Il punto è che l'Anas è un
organismo unitario, con tanto di strutture tecniche, direttore generale,
direttori centrali. A che serve uno che tratta il personale quando c'è un
direttore del personale? A che serve uno che tratta i lavori nel mezzogiorno
quando c'è un direttore generale dei lavori del mezzogiorno?
Report - Una lettera all'ex Presidente Pozzi dell'allora
Ministero dell'Economia dice che le deleghe non sono opportune. Dovete
vigilare sui soldi e invece poi lavorate dentro. La delega dell'ing. Papello
dice che deve coordinare e monitorare la direzione centrale dei lavori
compresi quelli sulla Salerno- Reggio Calabria. E lui è calabrese.
Paolo Brutti - C'è una struttura centrale presso Anas che
si occupa dei lavori relativi a questa infrastruttura. Non c'era nessun
bisogno della nuova delega se non per dare un potere di intervento e avere
un santo in paradiso come si dice...
Il testo integrale del programma si può consultare sul sito internet
www.report.rai.it
Report e la Banda Bassotti
Norma Rangeri
E non abbiamo avuto lo spazio sufficiente per deliziare il lettore con le
pingui storielle di altri celebri Consigli di amministrazione, eccellenti in
debiti e autopromozioni. Manca il gioiello di Sviluppo Italia, la società
che avrebbe dovuto attirare finanziamenti dall'estero e che invece tratta
affari per conto di onorevoli clientele. Manca la fotografia del Cda della
società marchigiana Quadrilatero, che pensa alle opere pubbliche stradali,
un doppione indecente di Anas. Mancano i consigli di amministrazioni zeppi
di parlamentari di tutti i partiti, che anziché provvedere alle leggi
amministrano e si fanno controllori di se stessi. Manca l'affresco del Cda
della scuola di cinema, dove le relazioni pericolose seguono sceneggiature
tutte politiche. Negli ampi stralci che sintetizzano una parte del programma
di Milena Gabanelli non c'è nemmeno la perla del finale, dove l'autrice di
Report cita il caso, altrettanto clamoroso del Cda della Rai, dove grazie al
voto dei consiglieri di maggioranza (berlusconiana) pende sul servizio
pubblico (cioè sulle nostre tasche) una multa milionaria per aver nominato
un direttore generale, Alfredo Meocci, compatibile solo con gli accordi di
sottogoverno. Niente di nuovo, ma l'inchiesta di Giovanna Boursier, mettendo
in fila la catena delle sanguisughe, ha disegnato l'immagine di un paese
senza dignità. Lo stesso che vede i partiti di ogni schieramento associarsi
ogni volta che generose prebende si affacciano all'orizzonte. E neppure
stupisce che questo o quel nome del firmamento dei consiglieri d'oro si
risetna e dichiari alle agenzie tutto il suo sdegno. Del resto, di fronte
all'inchiesta di Michele Santoro su mafia e politica in Calabria, si sono
levate le proteste del presidente Loiero. Se uno indica la luna c'è sempre
chi se la prende con il dito.
SALUTE|
Tumori al seno, nel mirino
la chimica
 
In Italia aumentati
del 29% i casi di cancro alla mammella. Lo studio della London University: «Meno
della metà deriva da fattori genetici». Wwf: «Nel mirino i falsi ormoni» / PDF:
La ricerca
 I
distruttori endocrini - alias "falsi ormoni" - presenti negli inquinanti
chimici, sono sostanze di sintesi non prodotte dall'organismo umano in grado di
mimare gli ormoni naturali. Sono questi i 'maggior indiziati' per l'aumento di
casi di cancro al seno. È quanto emerge da uno studio commissionato dal Wwf Gran
Bretagna alla London University. Contaminanti ambientali e cancro al seno:
cresce l'allarme sulle sostanze chimiche con proprietà di distruttori endocrini
- lo studio realizzato dal dott. Andreas Kortenkamp, responsabile del centro di
Tossicologia della scuola di Farmacia della London University - mette in luce
che meno della metà dei casi di cancro al seno può essere imputata a fattori
legati allo stile di vita o alla genetica. I
distruttori endocrini - alias "falsi ormoni" - presenti negli inquinanti
chimici, sono sostanze di sintesi non prodotte dall'organismo umano in grado di
mimare gli ormoni naturali. Sono questi i 'maggior indiziati' per l'aumento di
casi di cancro al seno. È quanto emerge da uno studio commissionato dal Wwf Gran
Bretagna alla London University. Contaminanti ambientali e cancro al seno:
cresce l'allarme sulle sostanze chimiche con proprietà di distruttori endocrini
- lo studio realizzato dal dott. Andreas Kortenkamp, responsabile del centro di
Tossicologia della scuola di Farmacia della London University - mette in luce
che meno della metà dei casi di cancro al seno può essere imputata a fattori
legati allo stile di vita o alla genetica.
È proprio di questi giorni, tra l'altro, la notizia - diffusa dall'Istituto
Superiore di Sanità – secondo cui i casi di tumori alla mammella sono aumentati
nel nostro paese del 29%. Nel mirino potrebbero esserci i distruttori endocrini,
prendendo in esame la loro azione in due scenari chiave: il primo è il
cosiddetto "effetto cocktail" che si rileva quando c'è un'esposizione simultanea
a diverse sostanze chimiche con proprietà estrogeniche (ossia che 'agiscono come
estrogeni' - ormoni naturali prodotti dalle ovaie) e il secondo è l'esposizione
ai contaminanti durante le fasi di maggiore sensibilità, vale a dire durante la
pubertà e lo sviluppo intrauterino.
«Un recente studio condotto in Spagna - avverte il prof. Kortenkamp – ha
dimostrato che è possibile associare il rischio di cancro al seno unicamente al
carico di sostanze chimiche estrogeniche presenti nell'organismo, escludendo del
tutto gli ormoni naturali. Questa è la prima prova del fatto che i contaminanti
ambientali con proprietà estrogeniche 'accidentali', e non solo gli ormoni
naturali o gli estrogeni farmaceutici, possono contribuire allo sviluppo del
cancro al seno». Tali contaminanti hanno causato già gravi alterazioni negli
ambienti naturali - specie nell'Artico - compromettendo le funzioni riproduttive
e ormonali e aumentando i casi di tumore.
GRANDI OPERE|
 Crepe nello Stivale Crepe nello Stivale

Diga Blufi
in costruzioneIn Italia oltre un terzo delle
dighe sorge in zone sismiche. Storie di sprechi e inefficienze intorno
agli invasi della penisola, soprattutto al Sud / di ANTONIO PERGOLIZZI
 Se la Cina è il paese che ha più dighe al mondo (più di 20mila), anche
l’Italia non se la passa male: 8.350 invasi (dati ministero dell'Interno) con 13
miliardi di metri cubi d'acqua. Di grandi dighe (più alte di 15 metri o con
oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua) nel nostro Paese ce ne sono 552: 514 in
funzione, 38 in costruzione. Oltre un terzo di queste sorge in zone classificate
sismiche. Del totale delle dighe, secondo il Cnr, solo 800 sono controllate dal
Servizio nazionale dighe (Snd), per le altre nessun controllo sistematico e
quindi alta pericolosità. In sostanza, il sistema dighe italiano mostra gravi
crepe, soffre di mali vecchi e nuovi: sprechi, inefficienze, malaffare e
impunità. Una classica storia italiana. Nel nostro meridione, ad esempio, la
vecchia Cassa del mezzogiorno ha finanziato la costruzione di dighe e acquedotti
che più che portare acqua hanno portato soldi nelle tasche dei soliti noti,
mafia compresa. In Sicilia, Calabria, Puglia, gli esempi abbondano. In Calabria,
secondo gli ultimi dati risalenti al 2003, in più di cinquant’anni sono state
progettate e avviate alla costruzione ben 36 dighe: peccato che solo 10 di
queste sono attualmente in esercizio. Nel dettaglio: 7 sono utilizzate
esclusivamente a fini idroelettrici e hanno un utilizzo plurimo (irriguo,
potabile); 5 non sono mai state completate; 6 sono state completate ma non
erogano acqua per mancanza delle opere di distribuzione; 15 sono soltanto
progettate e molte di esse presentano appena lo studio di fattibilità. Se la Cina è il paese che ha più dighe al mondo (più di 20mila), anche
l’Italia non se la passa male: 8.350 invasi (dati ministero dell'Interno) con 13
miliardi di metri cubi d'acqua. Di grandi dighe (più alte di 15 metri o con
oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua) nel nostro Paese ce ne sono 552: 514 in
funzione, 38 in costruzione. Oltre un terzo di queste sorge in zone classificate
sismiche. Del totale delle dighe, secondo il Cnr, solo 800 sono controllate dal
Servizio nazionale dighe (Snd), per le altre nessun controllo sistematico e
quindi alta pericolosità. In sostanza, il sistema dighe italiano mostra gravi
crepe, soffre di mali vecchi e nuovi: sprechi, inefficienze, malaffare e
impunità. Una classica storia italiana. Nel nostro meridione, ad esempio, la
vecchia Cassa del mezzogiorno ha finanziato la costruzione di dighe e acquedotti
che più che portare acqua hanno portato soldi nelle tasche dei soliti noti,
mafia compresa. In Sicilia, Calabria, Puglia, gli esempi abbondano. In Calabria,
secondo gli ultimi dati risalenti al 2003, in più di cinquant’anni sono state
progettate e avviate alla costruzione ben 36 dighe: peccato che solo 10 di
queste sono attualmente in esercizio. Nel dettaglio: 7 sono utilizzate
esclusivamente a fini idroelettrici e hanno un utilizzo plurimo (irriguo,
potabile); 5 non sono mai state completate; 6 sono state completate ma non
erogano acqua per mancanza delle opere di distribuzione; 15 sono soltanto
progettate e molte di esse presentano appena lo studio di fattibilità.
Il discorso non cambia in Sicilia. La diga Rosamarina a Caccamo (PA) già
inaugurata nel 1990 e che avrebbe dovuto raccogliere 80 milioni di metri cubi di
acqua, finora ha raccolto solo soldi: a Palermo di quell’acqua nessuno ne ha mai
visto una goccia. E poi la diga di Blufi, nel cuore delle Madonie. L’opera venne
appaltata nel 1989 a trattativa privata per un importo di 180 miliardi di
vecchie lire. Alla costruzione si opposero gli ambientalisti siciliani che già
prevedevano ciò che di fatto avvenne: lo sfregio indelebile dell’area.
L’assessore dell’epoca convinse tutti che la diga avrebbe dissetato per sempre
le province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento e che nel bacino artificiale
ricavato si sarebbero pure organizzate gare di canottaggio e windsurf.
Risultato: la diga non è mai stata completata, il suo costo è schizzato a ben
364 miliardi di vecchie lire e di acqua nelle case dei siciliani nemmeno
l’ombra.
Canta
il Lucherino
di Carlo
Bertani – (tratto da www.disinformazione.it)
Chissà
come chiamavano i genitori – quand’era bambino – l’attuale “signor FIAT”, ossia
Luca di Montezemolo? Luchino? No, c’era un altro Luchino – il regista Visconti –
e non fosse mai che i due s’incontrassero. Luchetto? No, ricorda troppo un
chiavistello…Lucherino? Può essere…in fondo si tratta di una specie di
passerottino simpatico e grazioso, con un solo difetto: canta, canta sempre,
anche quando gli altri uccelli tacciono.
Mentre
il centro destra s’inventa le manifestazioni di piazza – a Vicenza! La prossima
potrebbero farla al confine austriaco…a Lampedusa – per cercare di rendere
un’impossibile pariglia a Prodi, ossia quando il centro destra governava ed il
sindacato portava in piazza un milione di persone, il nostro Lucherino di
Montezemolo è andato a gorgheggiare all’assemblea della Piccola Industria a
Prato: grandi proclami per dieci piccoli indiani.
Quale
romanza ha strimpellato il nostro cantore di fronte alla platea amica? Scendere
in piazza con Berlusconi? Oh no, my God, non fa “tendenza” mettersi al
fianco con quelli che strombazzano che “l’hanno duro”, non è roba da Lucherini
ma da merli, corvi…insomma, uccellacci neri.
Meglio, invece, cinguettare di fronte ad una platea amica e – tutto sommato –
soddisfatta: certo…si poteva ottenere di più…ed allora via con l’attacco alla
Finanziaria! Tanto si sa, la Finanziaria è una diligenza che passa una sola
volta l’anno: giochiamo un po’ al tiro a segno!
Al buon
Lucherino non va giù che ci sia questa sinistra “estrema”, “massimalista” che
frena l’espansione economica del paese, che pretende – quasi fossero loro a
comandare! – salari più alti, niente pensioni a 65 anni…mio Dio che
disgusto…quando avevo parlato con Romano m’era parso d’aver inteso un’altra
musica…
I lucherini amano cibarsi di lombrichi e di briciole, ed il nostro Lucherino non
ha considerato sufficienti quelle che il governo ha destinato loro dopo aver
scosso la tovaglia sul balcone. Che affronto.
“Volevamo la Luna ”. Grazie, quella la vogliono tutti. “ La Finanziaria è
vecchia, non procede al risanamento del Paese…”
Oh,
finalmente uno che parla chiaro: volevamo di più dal taglio del cuneo fiscale,
volevamo la gente in pensione a 65 anni, volevamo veder licenziati i dipendenti
statali. Basta con gli sprechi in stipendi e pensioni! Pensiamo al futuro del
Paese ed alle prossime generazioni (di Lucherini).
Ognuno canta la sua canzone, ma il signor FIAT avrebbe tante ragioni per trovare
un sicuro nido in una grotta, starci il tempo necessario e riflettere su cosa va
dicendo. Perché, se voleva la “macelleria sociale”, non si è rivolto a
Berlusconi? Ovvio: sperava d’ottenere l’intero “piatto” da Prodi e il buon
Romano – se avesse potuto – avrebbe accontentato lui e Goldman & Sachs, Standard
& Poor, il FMI e la Banca Mondiale.
La
vendetta per le aspettative mancate è giunta – in pieno stile mafioso – con un
vano declassamento dell’Italia da parte delle agenzie di rating; no, Romano,
così non va: possibile che non sai usare lo scudiscio con quella gente?
Tutti s’aspettavano di più dal buon Romano, ma il Prode bolognese ha imparato la
lezione che Bertinotti gli diede nel 1998: la sinistra comunista non può
giocarsi il suo elettorato per fare una Finanziaria che piaccia solo ai “poteri
forti”. Almeno, si deve trovare un compromesso accettabile, bisogna salvare la
faccia.
Ma il signor FIAT – prima d’accusare la sinistra massimalista d’essere la rovina
della nazione – dovrebbe guardare dalle proprie parti, in senso politico e
geografico, per verificare se sia stata solo la sinistra comunista ad affossare
il paese.
C’era
una volta una grande azienda di nome FIAT, che produceva automobili popolari, le
quali valevano tanto quanto le consorelle europee: oddio, una Opel era più
robusta di una “Millecento”, ma le differenze non erano abissali.
A quel tempo c’erano in Italia altre case automobilistiche e vigeva un regime di
concorrenza; quando ci sono dei competitori si deve scegliere fra due strategie:
competere nello stesso segmento di mercato oppure difendere un segmento e
tralasciare gli altri.
Il signor FIAT dell’epoca – e non stiamo qui ad illustrare i mezzi, altrimenti
ne uscirebbe un libro – scelse la terza via: quella di mangiarsele.
Anche in
questo caso, però, non è detto che tutto il male venga per nuocere: Wolkswagen
assorbì Skoda, ma entrambe campano tuttora abbastanza bene.
Il signor FIAT acchiappò prima la Lancia , storica casa che produceva auto
lussuose e di prestigio: nell’estate del 1978 – quando da pochi anni la Lancia
era diventata FIAT – nel centro di Londra campeggiavano enormi pubblicità della
“Beta Montecarlo”, considerata dagli inglesi quasi un sogno proibito. Se non
potevi permetterti Jaguar od MG, potevi sempre acquistare una “Beta Montecarlo”
e non sentirti proprio un “signor nessuno”.
Il
prestigio della Lancia era principalmente dovuto ai successi ottenuti dalle
mitiche “Fulvia HF” nei campionati di rally, ma anche le “ammiraglie” – Aprilia,
Aurelia (leggendario il “coupé”), Flaminia e Flavia – erano lo “status symbol”
del successo economico.
Per chi occupava uno scalino più basso c’erano sempre le “Fulvia” (berlina e
coupé), che erano in ogni modo delle signore automobili, invidiate anche
all’estero.
La filosofia Lancia poggiava sulla qualità e la qualità ha dei costi:
carrozzerie in alluminio, cambi ZF di derivazione sportiva, motori a prova di
bomba. Il tutto costava, ma il risultato era all’altezza delle aspettative.
La buona
borghesia italiana viaggiava in Lancia e pochi acquistavano lussuose auto
straniere: c’era il timore di ricambi più costosi…di lunghi tempi d’attesa per
riceverli…e poi, perché comprare all’estero quando le Lancia ci erano
addirittura invidiate per la loro classe?
Appena il nuovo management FIAT s’insediò in Lancia sparirono le carrozzerie in
alluminio dalle Fulvia Coupé – ma questa era solo la prima avvisaglia – perché
bisognava pensare ad una nuova serie di “ammiraglie”.
Per la nuova Lancia Gamma – versione berlina e coupé – il management Lancia
propose (e non rivelerò la mia fonte) una “rivisitazione” del motore 2500 cm3
della Flaminia, un ottimo propulsore per una vettura di quel livello. I nuovi
padroni – analizzando i costi – iniziarono a storcere il naso: perché non
equipaggiare le nuove “ammiraglie” con un motore più economico, di casa FIAT?
Le
proteste della vecchia dirigenza Lancia furono inutili: un propulsore maggiorato
rimaneva sempre un’incognita; come avrebbe reagito un motore, nato per vetture
di una categoria inferiore, alle modifiche per “spremergli” qualche decina di
cavalli in più?
La nuova Lancia Gamma fu equipaggiata con un “economico” motore FIAT e messa in
vendita ad un prezzo “Lancia”, ossia ben superiore a quello delle grosse
cilindrate FIAT: tutti gli affezionati clienti Lancia (la media ed alta
borghesia italiana) acquistarono fiduciosi la nuova nata. Che colpaccio per i
bilanci FIAT.
Come
andò a finire?
Con i piazzali della Lancia colmi di “Gamma” restituite dai concessionari: la
maggior parte di esse aveva il pessimo gusto di bucare i pistoni nei primi 1.000
Km di percorrenza. Fu il primo di una serie di colossali errori, e chi oggi
vorrebbe santificare Gianni Agnelli come un gran capitano d’industria dovrebbe
riflettere e contare almeno fino a venti. Un uomo arguto, colto e simpatico: un
grande capitano d’industria? Beh…
A meno
di credere che un capitano d’industria sia solamente un uomo che moltiplica per
un certo periodo i profitti di un’azienda, non si può concedere quella patente
agli Agnelli perché le vacche grasse durano appunto “per un certo periodo”, dopo
svaniscono.
In quegli anni, avvenne la grande penetrazione dell’industria automobilistica
tedesca nel mercato italiano: oggi, marchi come Audi, Mercedes e BMW sono
praticamente sinonimi di vetture eleganti di grossa cilindrata, le ammiraglie,
appunto. Le stesse che sapevamo produrre anche in Italia, e che per uno
scherzetto da nulla – vendere alla miglior clientela delle ciofeche – ci è
costato l’uscita dal segmento delle auto di lusso.
Oggi il
marchio Lancia è praticamente limitato alle piccole cilindrate che sono il
frutto di un’altra acquisizione – Autobianchi – poi confluita in Lancia: dalla
Autobianchi A112 parte la linea evolutiva che conduce oggi alle attuali Lancia
Y, ma questo non ha nulla a vedere con quello che era il punto “forte” del
mercato Lancia, ossia soddisfare una clientela esigente con auto costose ma di
gran valore. Berlino ringrazia.
Il rampante Lapo – grande amante, come il nonno, dello sci e delle “piste” – si
lamentò perché la classe politica italiana snobbava le attuali ammiraglie
Lancia: come, costruiamo dei gioielli e voi non li accogliete? Che Stato balzano
è mai questo, che snobba la “crema” della produzione nazionale?
Difatti,
le ammiraglie Lancia le vediamo solo più in televisione: le usano i politici e
basta. Provate a circolare per Roma quando passa il codazzo urlante della
polizia: in mezzo c’è la Lancia del ministro di turno. E poi gridano agli
sprechi: provassero a viaggiare con una Punto, invece d’essere gli unici
acquirenti dei “misteri” Lancia.
Dopo Lancia venne l’ora dell’Alfa Romeo – anche qui ci sarebbe da scrivere un
bel romanzo nazionalpopolare – e lo Stato si ritirò dal mercato automobilistico
cedendo tutto ai potenti signorotti torinesi.
Per quanto riguarda alcune produzioni d’elite, FIAT cercò di non cadere nel
vecchi errore commesso con la Lancia , ma l’Alfa Romeo produceva in Campania una
vetturetta popolare dal motore grintoso: la “Alfasud”.
Ebbene,
con l’ingresso in FIAT, avvenne un fenomeno curioso: si raccontava che le auto
partissero da Napoli e, giunte a Milano, già iniziassero a marcire.
Gli italiani sono anche patrioti, ma non sono fessi.
Anche le auto straniere erano preda della ruggine – solo negli anni ’90 la
protezione divenne più efficace, grazie a nuove tecniche – ma una Renault od una
Ford non lasciavano una scia di ruggine come le FIAT. Potevi portarti appresso
una calamita e legarla al paraurti posteriore: a fine mese depositavi il tuo
chiletto di metallo al demolitore e ci ricavavi qualcosa.
Niente da fare: nonostante tutte le cure, le verniciature, la copertura anche
del minimo graffio, 128 ed Alfasud, 126 e furgoncini si scioglievano come se
fossero stati a bagno nell’acido. Sembrava che la ruggine partisse dall’interno
del metallo e non dagli agenti atmosferici esterni: come si spiegava un simile
fenomeno?
Il
risparmio è sempre stato il vero pallino degli Agnelli, sin dai tempi di
Valletta: risparmi un centesimo il giorno e, siccome i giorni di una potente
casata sono molti, alla fine si fanno i miliardi.
La Grecia vendeva il suo acciaio ad un prezzo stracciato? Eh sì, pagavano meno
il personale…i greci sono gente paziente, che lavora per un pezzo di
pane…saranno pure stati dei gran filosofi, ma oggi sono dei poveracci e – pur di
lavorare – ci fanno ottimi prezzi.
Treni colmi di rotoli d’acciaio giungevano a Torino, sbarcati dalle navi giù
rugginosi, rossi come le terre argillose del Monferrato che attraversavano prima
di diventare portiere e parafanghi.
La
Grecia – nazione così povera d’acqua – dove trovava l’enorme quantità di
prezioso liquido per raffreddare le colate ed i laminatoi a caldo? Le
raffreddavano con l’acqua di mare.
Qualcuno ha sentito parlare di NaCl, cloruro di sodio, il comune sale da cucina?
Quale effetto pensate che generi se incluso nell’acciaio? Un bel risparmio.
Dopo essere stati presi in giro per alcuni decenni, gli italiani iniziarono a
non farsi più incantare dalle sirene torinesi e volsero la loro attenzione
altrove: iniziarono gli anni bui, ed i guai.
La FIAT perdeva contemporaneamente percentuali di mercato e miliardi ad ogni
bilancio, che si traducevano in cassa integrazione e mobilità per i lavoratori
FIAT, ed in semplici licenziamenti per le piccole fabbriche dell’indotto. A
questo servono le piccole dimensioni di un’azienda: fungono da “polmone” per
assorbire le crisi, che se le trovano tutte sul gobbo i lavoratori, mica i
Lucherini.
Oggi
l’azienda torinese è in ripresa – perché l’alternativa era soccombere – e si è
messa a produrre un po’ meglio. Un po’. Gli altri, nel frattempo, sono andati
avanti e presto arriveranno vetturette cinesi a prezzi stracciati: altri guai in
vista per chi non sa lavorare sulla qualità. La soluzione FIAT? Una joint
venture con la Tata indiana, andranno a costruire le Punto in India, come
costruivano le “ 600” in Jugoslavia quando l’Europa era già zeppa di Golf.
E così
la colpa del pessimo andazzo economico è dei lavoratori: la volete smettere di
mangiare a colazione, pranzo e cena? Noi, affermano i Lucherini in coro, siamo
la testa e voi il corpo – ricordate Menenio Agrippa? – e sappiamo solo pensare.
S’è visto come.
Pare che la memoria sia il punto debole dei Lucherini: cantano senza spartito, e
non ricordano mai che il costo del lavoro, in Italia, è uno dei più bassi
d’Europa. Se quei lavoratori fossero utilizzati per produrre beni ad alto valore
aggiunto – ma anche solo buone automobili, non quelle che un mese dopo
l’acquisto devono già rientrare alle concessionarie per mille piccoli guai –
quel lavoro produrrebbe più ricchezza e ci sarebbero più risorse, per tutti.
A chi
tocca operare queste scelte? Perché in Italia si tagliano i fondi per la
ricerca? Perché non si cerca d’entrare nel futuro delle nuove tecnologie in
campo energetico, elettronico, informatico, biologico, elettromedicale? Che sia
proprio vero – come affermano i napoletani – che “’O pesce fete da ‘a capa?”
Da tutte queste vicende, se vogliamo trovare un comune denominatore, non c’è
tanto da scegliere: quando si guadagna sono per noi (Autostrade), quando si
perde sono dello Stato (Ferrovie). Negli anni di vacche grasse FIAT è una grande
azienda privata che compete sul mercato mondiale, in quelli di vacche magre
diventa una “risorsa per la nazione”.
Ora, il
Lucherino vorrebbe farci lavorare fino a 65 anni perché non ci sono i denari per
pagare le pensioni. Domanda: dove sono finiti i versamenti del lavoratori?
Ah, già…i Lucherini sanno gorgheggiare a meraviglia ma hanno scarsa memoria: non
ricordano mai il balcone dove si sono recati per fare incetta di briciole.
Dove sono stati presi i denari per pagare decenni di (doverosa) cassa
integrazione ai lavoratori, quando la FIAT era una “risorsa per la nazione”?
Dalle casse dell’INPS, perché in Italia non siamo nemmeno capaci di separare la
Previdenza dall’Assistenza: almeno, questo è ciò che ci raccontano.
Se la
Previdenza fosse destinata soltanto alle pensioni, per l’Assistenza bisognerebbe
provvedere altrimenti: magari con la creazione d’appositi fondi che le aziende
dovrebbero rifornire negli anni di vacche grasse. Niente di molto diverso da
quanto facevano gli Egizi tremila anni or sono.
Purtroppo, non si riesce a separare la Previdenza dall’Assistenza…eh già, è un
problema che ci trasciniamo da decenni…tutte le classi politiche ne sono
responsabili, non una sola parte. Quando si presenta il problema ai politici, in
genere parte questo pianto antico da coccodrilli: “tutti insieme
appassionatamente” a denunciare le omissioni d’interi decenni, uno scaricabarile
planetario.
Chissà
cosa succederebbe se i soldi destinati alle pensioni fossero utilizzati per
quello scopo, e le aziende dovessero accollarsi, almeno in parte – con la
costituzione d’appositi fondi – i costi dei loro errori strategici?
Peccato davvero, perché sarebbe un interessante esperimento evoluzionista:
osservare se i Lucherini – sbattendo la tovaglia in un diverso balcone ad ore
alterne – ritroverebbero la memoria.
Purtroppo non si riesce proprio a portare a termine l’esperimento, ed i
Lucherini continuano a becchettare dove trovano briciole, senza mai serbare
memoria dei luoghi che visitano e, soprattutto, di chi rifornisce di preziose
briciole quei balconi.
Sensazionale: Centrofondi declassa gli Usa!
Pierluigi
Paoletti -
www.centrofondi.it
La notizia del giorno,
strombazzata da tutti i mass media, è ovviamente il declassamento del nostro
rating che oramai ci vede soli al penultimo posto in Europa davanti solo a
Grecia e Polonia con una misera A+ al pari di Botswana, Corea del Sud, Kuwait,
Malesia, Trinidad e pochi altri.
Dire che l’avevamo previsto da tempo (http://www.centrofondi.it/report/report_03_04_06.pdf
e http://www.centrofondi.it/report/report_04_01_06.pdf
) sarebbe come sparare sulla croce rossa. Non siamo veggenti, solo
abbiamo imparato a leggere le cose economiche con occhi disincantati per cui
diventa facile prevedere le mosse scontate di chi manovra. Tranquilli, non siamo
complottisti ad oltranza, non vogliamo vedere il marcio anche dove non c’è. Sono
i fatti, per come si stanno svolgendo, che ci impongono almeno di farci qualche
domanda.
Se diamo uno sguardo ai paesi
che hanno la massima valutazione del rating (ovvero sono ottimi debitori)
vediamo che ci sono tutti i paesi anglofoni come Stati Uniti, Australia,
Inghilterra e sappiamo anche che il rating è un servizio per gli investitori che
rivela il grado di affidabilità delle obbligazioni emesse da parte di uno stato.
Non c’è anche nessun dubbio che noi abbiamo uno dei debiti pubblici più elevati
tra i paesi occidentali ovvero, leggendo la cosa in termini di signoraggio,
abbiamo chiesto denaro fresco alla Banca Centrale per un importo di poco
superiore alla nostra produzione annuale ed a fronte di queste emissioni di
nuovo denaro, che non ha, lo ribadiamo ancora una volta, alcuna copertura di oro
o altra ricchezza alle spalle, la banca centrale ci ha chiesto in contropartita
l’emissione di altrettante obbligazioni che poi vengono in parte rivendute dalle
banche ai risparmiatori, privati o istituzionali, di tutto il mondo.
Bene, per semplificare
riportiamo il classico esempio della tipografia ( la BC ) che invece di chiedere
il pagamento dei costi più suo sacrosanto guadagno per la stampa dei biglietti
della partita richiede, tramite l’emissione di obbligazioni (cambiali), l’intero
valore facciale dei biglietti. La tipografia (sempre la BC ) poi vende (in tutto
o in parte) le obbligazioni intascandosi il controvalore ed il cliente deve
pagare gli interessi agli acquirenti finali delle obbligazioni.
Già qui appare chiaro che c’è qualcosa che non va nel meccanismo, o la
tipografia e troppo furba o il cliente è troppo scemo oppure i due (BC e
politici) si sono messi d’accordo per fare fesso un terzo che poi è quello che
alla fine paga sempre (cioè tutti noi).
Il punto è che alla fin fine
questo è un debito
che non esiste se
pensiamo che ci sono stati venduti “solo” dei pezzi di carta a fronte di
ricchezza “vera”, pagati con varie finanziarie, tasse ecc. oltre naturalmente
agli interessi che ogni anno ammontano ad oltre 60 mld di euro. L’attuale
declassamento comporterà un maggior onere per gli interessi che serviranno per
appetire i compratori dei nostri titoli e enormi sacrifici (e soprattutto ancora
svendite del patrimonio pubblico) per ricondurre un debito che ormai, grazie
agli interessi sugli interessi, è ormai fuori controllo.
Ora vediamo invece un altro tipo di debito che è quello che uno stato ha nei
confronti di tutti gli altri, ovvero il deficit commerciale, quello che ai tempi
di Bretton Woods veniva pagato in oro dai paesi debitori. Al contrario del
debito pubblico di cui abbiamo visto sopra la natura, il deficit commerciale è
scambio di ricchezza reale ovvero io stato importo beni e servizi in misura
superiore a quanto riesco ad esportare.
Valutando questo gli Stati
Uniti hanno 800 miliardi di dollari di debiti con l’estero (il 6% circa del PIL)
in picchiata dagli anni ‘90, l’Australia idem contro appena l’1,8% dell’Italia.

L’Inghilterra, ma anche Usa e
Australia hanno numeri simili, pur avendo un Pil di poco superiore al nostro, ha
un indebitamento dei privati che secondo alcune stime arriva a valori
impressionanti ovvero 2.000 miliardi di euro ovvero addirittura superiore al
nostro debito pubblico che è intorno ai 1500 mld di euro.
Come si può spiegare allora il massimo rating dato a questi paesi?
Difficile da dire si può solo dire che tutte le società di rating sono società
private, che FMI, Banca Mondiale, BCE, FED, BRI, Commissione europea ecc. sono
tutti organi sovranazionali che fanno gli interessi esclusivi di chi li
controlla e che nei confronti dell’Italia c’è un interesse speciale per le
ricchezze che questo paese ancora può offrire ai nuovi
conquistadores
e la nostra ipotesi di un
nuovo 1992 alle porte vedrete che non è tanto campata in aria.
Nel nostro piccolo oggi
facciamo un’azione sensazionale. Declassiamo Usa, Inghilterra e Australia da
tripla A a un B--!
Credete che qualcuno ci stia a sentire?
Dal fronte dei dati macroeconomici intanto arrivano una raffica di dati che
evidenziano una crisi incipiente dell’economia americana come i prezzi
all'ingrosso a -1.6% sul mese scorso, la produzione industriale a -0.6% mese su
mese mentre l'utilizzazione della capacità è calata anche questa
inaspettatamente di uno 0.6%. Giorni fa erano usciti i consumi con il segno meno
-0.4% e venerdì scorso gli occupati a 50mila invece di 120mila attesi. Tutto
questo mentre gli indici azionari toccano i massimi di maggio o addirittura, è
il caso del Djones, toccano i massimi di tutti i tempi.
Se le borse anticipano di
circa sei mesi gli andamenti economici, allora o stanno guardando un altro film
o sono proprio in ritardo (che centrino qualcosa le elezioni americane?).
Nel secondo caso è probabile che all’improvviso girino verso sud recuperando
tutto il tempo perso e lasciando sul campo i corpi (per fortuna solo finanziari)
dei soliti creduloni dell’ultim’ora.
C’è un’altra notizia che merita la nostra attenzione ed è la crescita del grano
che da metà settembre ha avuto un’impennata dei prezzi

Quest’anno avremo la più
bassa produzione di grano degli ultimi 25 anni
http://www.ft.com/cms/s/0c021878-5a16-11db-8f16-0000779e2340.html e gli
esperti già parlano di crisi
senza precedenti e sono seriamente preoccupati per i prossimi anni.
Purtroppo questo è
il frutto della politica agricola suicida, dove si è cercato
l’industrializzazione e la globalizzazione di un settore che NON PUO’ e NON DEVE
essere industrializzato né tantomeno globalizzato.
E nel nostro piccolo
rinnoviamo l’appello agli imprenditori agricoli a sganciarsi dalla folle
politica agricola comunitaria per attuare nuove politiche imprenditoriali anche
redditizie come quella da noi proposta
http://www.centrofondi.it/sapore_cuore.htm per rivitalizzare
l’agricoltura e le economie locali. Noi da parte nostra mettiamo tutta la nostra
esperienza e siamo disponibili a dare il nostro aiuto e la nostra collaborazione
a tutti coloro che vorranno attuare o proporre ad altri questo progetto.
Il futuro è solo nostro, solo noi possiamo decidere se vivere in un inferno o in
un paradiso, ma bisogna scegliere…il tempo stringe.
Sul fronte valutario
probabilmente il recupero del dollaro sull’euro ha le ore contate la volatilità
in questa fase di sostanziale stallo dagli 1,25 a 1,3 è arrivata ai minimi dal
2001
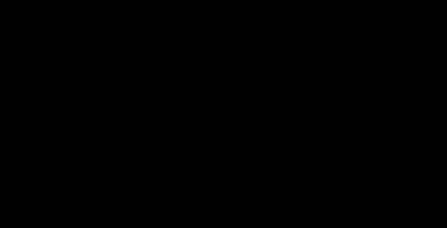
Un suo aumento, come dimostra
il passato, indicherebbe un nuovo apprezzamento dell’euro sul dollaro Dal fronte
dell’oro sembrerebbe che questa volta il nuovo ciclo fosse partito
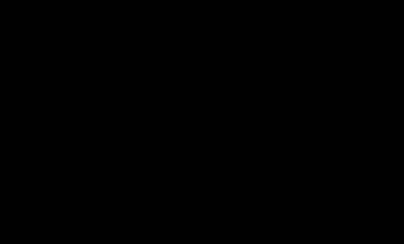
ed il superamento della trend
line rossa ne sarebbe la conferma. Questo nuovo ciclo porterebbe l’oro a
crescere fino a dicembre-gennaio dopodichè inizierà la fase discendente del
ciclo annuale iniziato a giugno scorso.
Poiché qualcuno ha parlato di bolla speculativa dell’oro, vi mostriamo un
grafico dell’oro dal 1971 in poi aggiustato con l’inflazione
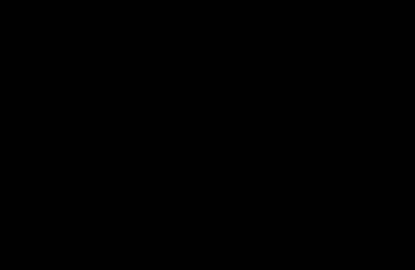
Da questo grafico si vede
come la corsa dell’oro dal 2000 sia solo un adeguamento dei prezzi
all’inflazione, di bolla se ne potrà parlare (vi consigliamo di rileggervi il
report sulla sequenza delle bolle speculative
http://www.centrofondi.it/report/report_09_02_05.pdf) solo quando i
prezzi saranno a ben altri livelli e comunque quando sentirete parlare di oro
dal fornaio allora quello sarà uno dei sintomi della bolla sull’oro, non prima.
Per il lungo periodo lo vediamo ancora un buon investimento e badate bene che
l’oro non dà nessun interesse, è da vedere solo come un qualcosa che mantiene il
suo potere di acquisto nel tempo al contrario di tutte le altre cose che si
svalutano in mano giorno dopo giorno
Naturalmente questo fino a quando non ci libereremo anche di questa convenzione
(l’ultima) ed a quel punto ci potremo considerare uomini liberi, ma allora
saremo ritornati al denaro non come riserva di valore, ma solo come mezzo di
scambio, non avremo più timore del futuro e avremo tutti la ricchezza e
l’abbondanza che ci meritiamo…ma questa è un’altra storia.
That’s all folks
25 ottobre
Stipendi, la quasi inarrestabile disfatta
degli impiegati

Quest’anno gli impiegati si ritrovano in
busta paga un quarto di quanto va ai dirigenti. 25 mila euro contro 100
mila euro l'anno. Nel 2001 il rapporto era un terzo. Peggiorato anche il
rapporto con le retribuzioni dei quadri. I settori che pagano meglio.
di FEDERICO PACE
Rappresentano una delle
componenti più ampie della forza lavoro. A lungo sono stati il motore degli
uffici. Eppure gli impiegati, in Italia, ma non solo, riescono a trarre
sempre meno da quel che fanno sul lavoro. E’ come se per loro, le fette
della torta della ricchezza dell’azienda si siano fatte sempre più piccole.
Chi sta nel mezzo, viene da dire, è il primo a rimetterci.
Negli ultimi anni
l’evoluzione è stata quasi inarrestabile. Secondo i dati elaborati dal 7°
Rapporto sulle retribuzioni in Italia realizzato da OD&M, nei primi otto
mesi del 2006 i dirigenti italiani hanno mostrato in media una retribuzione
pari a quasi quattro volte quella di un impiegato. Più di quanto non fosse
qualche anno fa. Nel 2001 la proporzione era di poco più di tre a uno (vedi
tabella). La stessa evoluzione si è registrata anche in rapporto alle
retribuzioni dei quadri. Se nel 2001 la paga di un impiegato era quasi il
60% di quella di un quadro ora è scesa a poco più alla metà. Insomma chi
guadagnava più degli impiegati, oggi guadagna ancor di più.
“La difficoltà della
situazione impiegatizia rimanda a tre fattori - ci ha detto Andrea Panzeri
di OD&M (leggi
intervista integrale) - Per prima cosa ci sono le trasformazioni
tecnologiche e organizzative che hanno finito per impoverire il contenuto
professionale di molte professioni. Collegato a questo c’è il rapporto tra
l’offerta di lavoro e la domanda. In particolare siamo di fronte a
un’offerta di lavoro sempre più scolarizzata e a una domanda che è relativa
a profili non necessariamente qualificati. In fine ci sono gli effetti di
quella che è stata la flessibilizzazione del mercato soprattutto in termini
di ingresso.” Insomma si va verso una polarizzazione dell’occupazione e, di
riflesso, delle retribuzioni e gli impiegati sono nel bel mezzo di un
ciclone che rimette in discussione la loro stessa identità.
I dati del 7° Rapporto
sulle retribuzione di Od&M consulting prendono in considerazione 1,5 milioni
di profili retributivi di cui il 63,7 per cento è relativo agli impiegti, il
21% per cento di quadri, il 9,5 di dirigenti e il 6% di operai.
Le retribuzioni del 2006. Se si guarda ai valori espressi nei primi otto
mesi del 2006 ci si accorge che un dirigente si ritrova in busta paga circa
centomila euro lordi l’anno, un quadro arriva intorno ai 50 mila euro mentre
gli impiegati superano di poco i 25 mila euro e agli operai spetta poco meno
di 22 mila euro.
Rispetto all’anno
scorso, quest’anno sono stati i dirigenti (vedi
tabella) ad avere avuto il più elevato incremento. La loro retribuzione
è infatti cresciuta in termini nominali del 6,7%. In leggera ripresa anche
quella degli impiegati (+4,9 per cento) ovvero circa 1.239 euro in più in
termini nominali che però in termini reali (al netto del costo della vita)
valgono circa la metà, ovvero 661 euro. Dal 2001 a oggi (vedi
tabella) è la prima volta che gli impiegati vedono crescere le proprie
retribuzioni più di quanto non succede ai loro diretti superiori, ovvero i
quadri.
I quadri nei primi mesi
del 2006 si ritrovano in busta paga 2.227 euro in più (+4,7%) rispetto al
2005. In termini reali l’incremento è però di 1.126 euro (+2,4%). Dal 2001 a
oggi lo stipendio annuo lordo è passato dai 40.885 euro ai 50.114 euro.
Ovvero un incremento di quasi diecimila euro che in termini reali si riduce
a 4.194 euro (vedi
tabella). Le retribuzioni degli operai hanno registrato, rispetto al
2005, l’incremento meno elevato pari al 4,2% (vedi
tabella).
I comparti. Per quanto riguarda i dirigenti il comparto che remunera
meglio è quello delle banche e delle società finanziarie con una media di
123mila e 130 euro annui, seguono le imprese di telecomunicazioni dove la
retribuzione annua arriva in media a 104.861 euro (vedi
tabella). Gli stessi settori sono anche quelli dove i quadri trovano le
migliori opportunità retributive (vedi
tabella). Gli impiegati invece guadagnano lo stipendio più elevato nella
fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici (28 mila e 454 euro)
seguiti da quelli che lavorano nell’alimentare (vedi
tabella). Il comparto invece con i valori retributivi più bassi è quello
degli studi professionali con 21mila e 540 euro.
Gap di genere. Si va riducendo invece, secondo i dati di OD&M il divario
tra le retribuzioni degli uomini e quelle delle donne. Per quanto riguarda i
dirigenti la differenza in termini assoluti passa da 6.187 euro a 5.233, per
i quadri da 2.409 a 1.908, per gli impiegati da 3.182 a 2.843 e per gli
operai da 1702 a 623.
Diversi studi
confermano l’attuale evoluzione che mostra come in diversi paesi, come
Germania, Regno Unito, Stati Uniti la polarizzazione delle retribuzioni stia
crescendo incessantemente. Secondo i dati Ocse, l’Italia è tra i paesi in
cui la disparità è cresciuta di più insieme a Regno Unito e Giappone.
Secondo i dati Eurostat sono le metropoli le aree dove le retribuzioni
tendono ad essere più elevate e dove si ampliano le distanze tra i "più
ricchi" e i "più poveri". Il picco continentale si registra nell’area di
Londra dove la retribuzione media del 10 per cento più ricco è pari a
104.034 euro mentre lo stipendio lordo medio di chi guadagna meno è di
16.931 euro con un rapporto che raggiunge il 6,1. Rapporto "meno equo" anche
a Bruxelles (3,7), Madrid (4,5), Amburgo (4,2) e Parigi (3,9).
L’ineguaglianza,
scriveva L’Economist a propostito della crescente disparità retributiva
negli Stati Uniti, non è di per sé negativa ma per non esserlo deve
soddisfare tre condizioni: la società nel complesso deve diventare più
ricca; ci deve essere una rete di sicurezza per i più poveri; e terzo,
ognuno, al di là della classe, etnia, credo o sesso, deve potere avere un’oppurtunità
per migliorare la propria condizione.
Il rapporto sullo stato di salute
della Terra indica un crollo
della biodiversità e la riduzione vertiginosa delle risorse
Allarme del Wwf: "Un pianeta non
basta
Entro il 2050 risorse insufficienti"
"Bisogna cambiare, se non lo faremo
conseguenze certe e terribili"

ROMA - Gli ecosistemi naturali si
stanno degradando a un ritmo impressionate, senza precedenti
nella storia della specie umana e la conseguenza più immediata è
la perdita di biodiversità. Le conseguenze di questi processi
sono catastrofiche già nel medio periodo: entro il 2050 le
risorse della Terra non saranno più sufficienti, se continueremo
a sfruttarle a questi ritmi. Sono le conclusioni del "Living
Planet Report 2006", l'ultimo rapporto del WWF, giunto
alla sua sesta edizione, presentato oggi a livello mondiale
proprio da uno dei paesi a più rapido sviluppo, la Cina. "Fare
dei cambiamenti che migliorino i nostri standard di vita e
riducano il nostro impatto sulla natura non sarà facile - ha
detto il direttore generale di Wwf International, James Leape -
ma se non agiamo subito le conseguenze sono certe e terribili".
L'uomo distruttore. Secondo il rapporto, che è stato
redatto dopo due anni di studi, la perdita di biodiversità già
segnalata nelle precedenti edizioni è sempre più marcata e il
consumo di acqua, suolo fertile, risorse forestali e specie
animali ha raggiunto livelli intollerabili per il pianeta. Il
rapporto dimostra che in 33 anni (dal 1970 al 2003) le
popolazioni di vertebrati hanno subito un 'tracollo' di almeno
1/3 e nello stesso tempo l'impronta ecologica dell'uomo - cioè
quanto 'pesa' la domanda di risorse naturali da parte delle
attività umane - è aumentata tanto che la Terra non è più capace
di rigenerare ciò che viene consumato.
Il ruolo dell'Italia. Il consumo incontrollato riguarda
tutti i paesi e l'Italia, sebbene dietro al resto dell'Europa, è
al 29esimo posto nella classifica mondiale delle nazioni
scialacquatrici. E' evidente, secondo il Wwf, che anche l'Italia
deve cambiare rotta al più presto e imboccare la strada della
sostenibilità del proprio sviluppo, integrando le politiche
economiche con quelle ambientali.
Correre ai ripari. "Siamo in un debito ecologico
estremamente preoccupante, considerato che i calcoli
dell'impronta ecologica sono per difetto - ha spiegato
Gianfranco Bologna, direttore scientifico del Wwf Italia -
Consumiamo le risorse più velocemente di quanto la Terra sia
capace di rigenerarle e di quanto la Terra sia capace di
'metabolizzare' i nostri scarti. E questo porta a conseguenze
estreme ed anche molto imprevedibili".
Per questo, secondo Bologna, "è tempo di assumere scelte
radicali per quanto riguarda il mutamento dei nostri modelli di
produzione e consumo. Il nostro futuro dipenderà da come
impostiamo oggi la costruzione delle città, da come affrontiamo
la pianificazione energetica, da come costruiamo le nostre
abitazioni e da come tuteliamo e ripristiniamo la biodiversità".
I dati. Il rapporto del Wwf ha analizzato in tutto 695
specie terrestri, 344 di acqua dolce e 274 specie marine. Negli
oltre trent'anni presi in considerazione le specie terrestri si
sono ridotte del 31%, quelle di acqua dolce del 28% e quelle
marine del 27%. Il secondo indice, l'Impronta Ecologica, misura
la domanda in termini di consumo di risorse naturali da parte
dell'umanità. Il "peso" dell'impatto umano sulla Terra è più che
triplicato nel periodo tra il 1961 e il 2003. Questo rapporto
mostra che la nostra impronta ha già superato nel 2003 del 25%
la capacità bioproduttiva dei sistemi naturali da noi utilizzati
per il nostro sostentamento. Nel rapporto precedente era del
21%.
In particolare, l'impronta relativa alla CO2,
derivante dall'uso di combustibili fossili, è stata quella con
il maggiore ritmo di crescita dell'intera impronta globale: il
nostro "contributo" di CO2 in atmosfera è cresciuto di nove
volte dal 1961 al 2003. L'Italia ha un'impronta ecologica (sui
dati 2003) di 4,2 ettari globali pro capite con una biocapacità
di 1 ettaro globale pro capite, dimostrando quindi un deficit
ecologico di 3,1 ettaro globale pro capite.
24 ottobre
La lezione di
Gomorra
di Gianluca Di Feo
Dopo le minacce decisa la scorta a
Roberto Saviano. Per il quale si è mobilitata tutta Italia. Ma ora
bisogna colpire il sistema dei boss
Lo Stato ha fatto il primo passo:
Roberto Saviano verrà protetto. Il Comitato per l'ordine e la
sicurezza, guidato dal prefetto di Napoli Renato Profili, aveva
aperto la procedura per la tutela armata dopo le minacce contro lo
scrittore che ha sfidato i boss tre volte: con il suo libro, con i
suoi articoli e con le sue parole. Ma l'eco internazionale che ha
avuto l'articolo de 'L'espresso' con la descrizione delle
intimidazioni ha spinto anche il ministro Giuliano Amato a
intervenire in prima persona. E più della scorta, a garantire
l'incolumità fisica dell'autore di 'Gomorra' provvederà il muro di
solidarietà che è sorto intorno a lui. Si sono schierate al suo
fianco le massime istituzioni campane, dal governatore Antonio
Bassolino al cardinale Crescenzio Sepe. Si sono mobilitati
tantissimi scrittori, che hanno aggiunto le loro parole all'appello
lanciato da Sandrone Dazieri con le firme di Massimo Carlotto e
Giancarlo De Cataldo. Umberto Eco in un'intervista al Tg1: "Il caso
di Saviano si lega a Falcone e Borsellino. Perché in questi caso
sappiamo da dove arriva la minaccia, sappiamo persino i nomi e i
cognomi. Si tratta di intervenire preventivamente e pubblicamente su
un fenomeno di cui si sa tutto". Ma soprattutto c'è stato un coro di
sostegno a Saviano da Napoli e dagli altri centri della Campania, la
sua terra: quella che lui ha raccontato nelle pagine di 'Gomorra'
come vittima di un 'sistema' criminale che distrugge tutto: le
persone, l'ambiente, l'economia.
Lo Stato ha fatto il primo passo. Ma
adesso è necessario che vada avanti. Perché 'Gomorra' è diventato
una denuncia nazionale, che mette sotto gli occhi di tutti
l'inarrestabile ascesa della camorra campana e delle sue
ramificazioni internazionali. Una denuncia che presto verrà tradotta
e pubblicata in 20 paesi, dagli Stati Uniti alla Svezia, e che ha
già conquistato le pagine dei quotidiani europei. Roberto Saviano ha
scritto tutto quello che ha visto: integra con la sua testimonianza
gli atti di centinaia di indagini che non sono quasi mai riuscite a
raggiungere condanne definitive. O che sono state vanificate
dall'indulto o da evasioni beffa, come quella del boss Lauro
scomparso dopo la scarcerazione per un cavillo burocratico. 'Gomorra'
ha dato voce a tutti i campani che non si arrendono allo strapotere
della criminalità organizzata. Negli articoli de 'L'espresso' la sua
denuncia si è allargata all'incapacità della classe politica di dare
una risposta: di liberare i cittadini dalla camorra e
dall'immondizia, il nuovo oro nero delle mafie. Poi, al fianco del
presidente della Camera Fausto Bertinotti, nella piazza di Casal di
Principe, la città che negli Novanta aveva il record mondiale di
omicidi, si è rivolto direttamente ai padrini, invitandoli ad
andarsene. Ecco quale deve essere il secondo passo. Partire da Casal
di Principe e dal Casertano, nuovo polmone di capitali finanziari
delle cosche che marciano su Roma. E da Secondigliano, periferia
disumana diventata centro di traffici mondiali.
Banlieues un anno dopo
Parigi teme una
nuova rivolta
Violenze nelle periferie. I
Servizi: intatte le radici dell'odio
di BERNARDO VALLI
ALLE 18,12 DEL 27 ottobre 2005, a
Clichy-sous-Bois, nella periferia parigina, due giovani, Bouna
Traoré, 15 anni, e Zyed Benna, 17 anni, morivano fulminati nella
cabina elettrica in cui si erano introdotti scavalcando una rete
metallica. Muhittin Altun, 17 anni, sopravvissuto con gravi ferite,
raccontava di essersi nascosto con i compagni nel trasformatore
dell'EdF (Electricité de France) per sfuggire ai poliziotti dai
quali pensava di essere inseguito.
La notizia ha scatenato sommosse nelle
grandi banlieues del Paese per ventuno notti consecutive, durante le
quali sono state incendiate novemila automobili, sono stati
devastati o danneggiati numerosi edifici pubblici, in gran parte
scuole, e sono state fermate più di tremila persone, per lo più
adolescenti.
Per tre settimane la Francia ha
assistito stupita, sconvolta a quella esplosione di collera ai
margini delle metropoli.
Una collera che non traboccava mai dai
quartieri popolari in quelli residenziali, o nei centri commerciali,
come se fosse una rabbia rispettosa delle frontiere sociali, e
osasse sfogarsi soltanto nella desolata intimità dei sobborghi
slabbrati, riservati ai poveri. I quali hanno distrutto le
automobili dei vicini di casa, spesso altrettanto sfortunati, e
danneggiato le proprie scuole.
Prima i francesi hanno temuto che la
protesta degenerasse e si macchiasse di sangue, poi hanno cominciato
a interrogarsi sui motivi che spingevano i figli di immigrati,
spesso nati in Francia e con la nazionalità francese, a lanciarsi in
quella che i commentatori più precipitosi chiamavano un'"intifada
alla francese", e che Jacques Chirac, uscito da un lungo silenzio,
si decise a definire "une crise d'identité, de sens et de repères".
Per il presidente quei giovani piromani avevano smarrito il senso
della vita e non avevano un punto di riferimento. I sociologi
lessero nella sommossa delle banlieues tre messaggi: una ribellione
contro la polizia (considerata un nemico e colpevole di avere
provocato la morte dei ragazzi di Clichy-sous-Bois); un sentimento
di abbandono nei confronti della scuola; e il rifiuto della
discriminazione subita dai figli degli immigrati quando cercano un
lavoro.
Si accese inevitabilmente un dibattito
sul modello di integrazione francese basato sull'assimilazione; e
non furono in pochi a denunciarne il fallimento. La rivolta degli
immigrati, in larga parte di origine africana, annunciava il
prevalere del comunitarismo, specificità anglosassone considerata
una degenerazione nella Repubblica giacobina. I difensori del
modello francese sono subito insorti. Fallito? È falso.
Affermarlo equivale a un insulto.
Quando è stato applicato quel modello ha funzionato. Esso si
articolava in più capitoli tutti tesi all'assimilazione.
I principali erano: la scuola
repubblicana; il servizio militare; la forza dei sindacati
integratori; l'assenza di ghetti etnici. E ancora, naturalmente, il
primato della lingua e dell'insegnamento della cultura francese su
quelli dei paesi d'origine degli immigrati.
Ma quasi tutto è finito in un
disordine e in una passività che hanno favorito il comunitarismo,
tanto denunciato ma ormai solidamente installato.
Ci fu anche chi sostenne che la
violenza dei giovani delle banlieues, in gran parte magrebini, era
la prova di una reale integrazione, poiché con quella violenza si
esigeva l'applicazione dei principi repubblicani anche ai figli
degli immigrati, che si sentivano discriminati. Lo sostenne uno
storico, Emmanuel Todd, il quale fu subito sommerso dalle critiche.
I ragazzi delle periferie non erano dei ribelli, hanno sentenziato i
censori più severi.
Erano degli esclusi, spesso
autoghetizzatisi, diventati dei rivoltosi nihilisti. Senza patria e
senza principi. Come i protagonisti del film (L'Odio) di Mathieu
Kassovitz.
Un anno dopo i Renseignements Généraux,
il servizio della polizia che segue gli avvenimenti politici e
sociali, insomma "l'orecchio del governo", sostiene in un rapporto
confidenziale (rivelato dal Figaro), che "la maggior parte delle
condizioni dodici mesi fa all'origine dello scatenamento della
violenza collettiva sono ancora presenti". Il documento è esplicito:
nelle banlieues può esplodere una nuova rivolta. L'allarme riguarda
soprattutto la regione parigina, dove tutto è cominciato nel 2005.
Il testo contrasta con la relativa
fiducia manifestata pubblicamente dal ministro degli Interni,
Nicolas Sarkozy, secondo il quale non ci sarebbero finora segnali
allarmanti. I poliziotti fanno tuttavia confidenzialmente notare che
basta molto poco per mettere in agitazione le borgate. In settembre
sono avvenuti 7 mila 327 episodi di violenza urbana; un netto
aumento rispetto al mese precedente; nei primi sei mesi dell'anno ce
ne sono stati oltre 50 mila. Nelle ultime settimane dei poliziotti
sono stati aggrediti da bande di giovani, in alcuni casi sono caduti
in veri e propri agguati. Questi fatti, "non più spontanei ma
strutturati", sono sottolineati nel rapporto dei Renseignements
Généraux e presentati come indizi rivelatori di possibili imminenti
disordini, questa volta organizzati.
L'allarmata analisi della polizia è
condivisa da tutti i sindaci delle città in cui ci sono quartieri
definiti "sensibili" dalla burocrazia. Ed entrambi, sindaci e
poliziotti, sono d'accordo nel denunciare quello che per loro è
l'eccessivo zelo dei giornalisti in questi giorni impegnati a
sondare gli umori delle banlieues, un anno dopo la sommossa.
L'insistente attenzione della stampa potrebbe sollecitare
l'esibizionismo dei giovani e spingerli a diventare i protagonisti
di una nuova rivolta. Ma cosa è cambiato, che cosa è stato fatto in
questi dodici mesi per distogliere i rivoltosi del 2005 dal compiere
gli stessi vandalismi nel 2006? Secondo Claude Dilain, sindaco
socialista di Clichy-sous-Bois, i suoi amministrati "non hanno visto
cambiare lo sguardo sprezzante che la società getta su di loro". In
sostanza per lui non è cambiato nulla, o molto poco.
Il governo agisce in due direzioni. Da
un lato il primo ministro Dominique de Villepin esalta l'azione
dell'Associazione nazionale per la coesione sociale, dotata di mezzo
miliardo di euro da spendere nel 2007; ed enumera altresì le "cento
misure" prese per agevolare la vita nelle periferie più disastrate.
Si tratta di iniziative che chiedono tempo prima di dare risultati.
Come del resto il ribasso della disoccupazione sul piano nazionale
non ha effetti immediati tra i giovani, il quaranta per cento dei
quali in certe banlieues è senza lavoro, e non ha alcuna prospettiva
di trovarne uno nel futuro scrutabile.
Quando il sindaco di Clichy-sous-Bois
dice che "lo sguardo sprezzante" della società non è cambiato,
significa che la discriminazione nei confronti dei figli degli
immigrati africani è immutata.
Assai più vistose e publicizzate sono,
sull'altro versante, le iniziative di Nicolas Sarkozy, il quale
nella sua veste di ministro degli Interni critica i magistrati
perché troppo clementi nell'esercitare la giustizia, minaccia
provvedimenti più severi nei confronti di chi aggredisce la polizia,
e dichiara che i minorenni recidivi devono essere giudicati come se
fossero maggiorenni. Favorito dal clima elettorale (tra sei mesi si
terranno le presidenziali), il problema della sicurezza trova, come
è inevitabile, largo spazio nei discorsi degli uomini politici e
nelle preoccupazioni della gente. E le banlieues interessano
soprattutto sotto quell'aspetto.
Solo il 29% delle città ha piano
aggiornato
Il territorio
del Lazio è fragile
Otto comuni su dieci hanno case in
aree pericolose. Legambiente e Protezione civile presentano il
rapporto Ecosistema rischio. Maglia rosa a Latina, buono il voto di
Roma, Rieti insufficiente
Il Lazio è ancora esposto a frane e
alluvioni. Otto comuni su dieci hanno case in aree a rischio, e il
76% è in ritardo nella prevenzione. Solo il 29% dei comuni laziali
ha un piano d’emergenza aggiornato. Latina è il comune più virtuoso
contro le frane e le alluvioni, Roma si aggiudica un “buono” e Rieti
non raggiunge neanche la sufficienza. Tra i comuni del Lazio a più
alto pericolo di alluvioni e frane il 78% ha abitazioni in aree a
rischio idrogeologico e il 29% presenta in tali aree addirittura
interi quartieri. Tre su cinque vi vedono sorgere fabbricati
industriali, che comportano in caso di alluvione, oltre al rischio
per le vite dei dipendenti, anche lo sversamento di prodotti
inquinanti nelle acque e nei terreni. A fronte di un territorio così
marcatamente fragile soltanto il 20% dei comuni ha intrapreso
delocalizzazioni di strutture presenti in zone a rischio e il 59%
non svolge una manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e delle
opere di difesa idraulica. Carente la situazione per quanto riguarda
le attività locali di protezione civile per rispondere all’emergenza
in corso. Solo il 59% dei comuni che si è dotato di un piano
d’emergenza e appena il 29% lo ha aggiornato negli ultimi due anni.
Complessivamente solo un comune su cinque svolge un positivo lavoro
di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.
Questi sono solo alcuni dati di
“Ecosistema Rischio 2006”, l’indagine inedita di Legambiente e
Dipartimento della Protezione Civile presentati oggi a Rieti durante
la conferenza stampa organizzata nel corso della tappa laziale di
"Operazione Fiumi 2006". Con "Ecosistema rischio" Legambiente ha
concentrato l’attività di monitoraggio proprio sui 366 comuni del
Lazio, ben il 97% del totale, classificati a rischio da Ministero
dell’Ambiente e UPI nel 2003, per verificare cosa facciano realmente
le amministrazioni per prevenire il pericolo a cui sono esposti
territorio e cittadini. «Sono ancora pochi i comuni del Lazio che
complessivamente sembrano aver posto le tematiche di protezione
civile tra le priorità del loro lavoro – spiega Daniel Noviello
portavoce della campagna – i piani di emergenza che permettono alla
popolazione di sapere cosa fare e dove andare in caso di alluvione e
di organizzare soccorsi tempestivi sono pochi e troppo spesso
datati. La nostra Regione paga un ritardo accumulato in passato
rispetto ai nostri vicini su queste tematiche. Un ritardo su cui
negli ultimi due anni – conclude Noviello – non vediamo segnali
significativi di recupero».
È Latina il comune più meritorio della
regione, che raggiunge la classe di merito d’eccellenza “ottimo
lavoro svolto”. Dopo un’attenta verifica delle azioni che afferma di
aver realizzato sarà premiata con la bandiera bosco sicuro da
Legambiente e dal Dipartimento della Protezione Civile come
riconoscimento del buon lavoro svolto. Tra gli altri capoluoghi Roma
raggiunge un buono, con un 7,5 in pagella. Insufficiente il giudizio
complessivo su Rieti. Maglia nera nel Lazio al comune di Ariccia (Rm)
che, pur avendo industrie e quartieri in area a rischio, non ha
svolto praticamente nessuna attività di prevenzione.
«La pesante eredità di un passato
fatto di abusivismo e urbanizzazione delle aree a rischio
idrogeologico con abitazioni, insediamenti industriali, attività
agricole e zootecniche - spiega Lorenzo Parlati, presidente di
Legambiente Lazio – rende preoccupante la fragilità del nostro
territorio. Lo scorso anno il Tevere come il Marta nel viterbese
hanno dimostrato come bastino semplici temporali per causare nel
migliore dei casi allagamenti e disagi per la popolazione. Una
fragilità cui si mette mano con troppa timidezza – conclude Parlati
– non vediamo ancora all’orizzonte una decisa azione di abbattimento
delle costruzioni abusive lungo i fiumi e la delocalizzazione dalle
aree a rischio di quelle strutture che non possono essere messe in
sicurezza, anzi ci sono amministrazioni che continuano ad approvare
sanatorie o nuove costruzioni in queste aree».
23 ottobre
I dati forniti a un convegno
nazionale sul tema organizzato dall'Associazione italiana di
oncologia. Il primato degli sbagli in traumatologia e ortopedia
Sanità, gli
errori dei medici provocano 90 morti al giorno
Oltre 14 mila decessi e 10 miliardi
di euro di costi all'anno
ROMA - Provocano più vittime degli
incidenti stradali, dell'infarto e di molti tumori. In Italia le
cifre degli errori commessi dai medici o causati dalla cattiva
organizzazione dei servizi sanitari sono da bollettino di guerra:
tra 14 mila (secondo l'Associazione anestesisti rianimatori
ospedalieri) e i 50 mila decessi all'anno, secondo Assinform. Il che
signifuca circa 80-90 morti al giorno (il 50% dei quali evitabile),
320 mila le persone danneggiate. E con costi pari all'1% del pil: 10
miliardi di euro l'anno.
A fornire le cifre è L'Associazione
italiana di Oncologia medica (Aiom), che in collaborazione con Dompé
Biotec, ha organizzato un convegno nazionale proprio su questo tema.
Che si tiene, oggi, all'Istituto dei Tumori di Milano. ''Il tema del
rischio clinico - afferma il professor Emilio Bajetta, presidente
nazionale dell'Aiom - si propone come un argomento di grande
attualità, con un forte impatto socio-sanitario. Lo scopo è
migliorare la prestazione sanitaria e garantire la sicurezza del
paziente oncologico''.
Anche perché, nella speciale
classifica delle specialità dove si commettono maggiori errori
stilata dal Tribunale del Malato, l'oncologia con un 13% si colloca
al secondo posto, preceduta solo dall'ortopedia e traumatologia con
il 16,5%; seguono ostetricia (10,8%) e chirurgia (10,6%). A guidare
invece la graduatoria dei reparti più a rischio c'è la sala
operatoria (32%), seguita da dipartimento degenze (28%),
dipartimento urgenza (22%) e ambulatorio (18%).
Riguardo specificamente al settore
oncologico, prosegue Bajetta, "quelli relativi al farmaco e alla
corretta esecuzione dei protocolli terapeutici sono fra gli errori
più frequenti in oncologia. Dagli ultimi studi internazionali
risulta però che, sempre in questo ambito, le controversie per
errori medici sono in diminuzione. La cosa però non deve sollevare
in alcun modo il clinico dai propri doveri e responsabilità: una
maggiore chiarezza nel comunicare i limiti della medicina e gli
eventuali errori non può che giovare al rapporto col paziente".
In ogni caso, c'è da registrare che il
contenzioso in oncologia è in calo, con percentuali attualmente
scese dal 13% al 10%. E il 90% dei medici o degli ospedali citati in
giudizio viene assolta. Ma resta il problema dell'aumento
esponenziale delle cause intentate ai medici e dei premi richiesti
dalle assicurazioni agli ospedali (fino a due milioni di euro
l'anno, per le strutture più grandi). Questo malgrado i progressi
registrati in termini di sopravvivenza: più 7% negli ultimi dieci 10
anni.
I dati nazionali disponibili
provengono da varie fonti (Anestesisti Ospedalieri, Assinform,
Tribunale dei Diritti del Malato e altre): oppure sono proiezioni
dalla letteratura internazionale (a partire dal rapporto Usa del
2000 "To err is human"); o ancora si riferiscono a studi e
sperimentazioni condotti in grandi e piccoli centri di cura
italiani.
Via comunale intitolata ad
Alessandro Pavolini. E i comunisti insorgono
Mozione urgente al consiglio
regionale del Lazio per bloccare l'iniziativa
Una strada al
gerarca fascista. Bufera sul sindaco di Rieti
Anche i Ds si schierano contro. La
difesa di An: "Era un intellettuale"
Alessandro Pavolini
RIETI - Il Comune di Rieti dedica una
strada al gerarca fascista Alessandro Pavolini e scoppia la
polemica. Con il Pdci che parte all'attacco presentando una mozione
urgente al Consiglio regionale del Lazio per bloccare l'iniziativa.
E i Ds pronti a dare battaglia.
Secondo il sindaco di Rieti, Giuseppe
Emili, Pavolini è stato "comandante delle Brigate nere, capo del
Minculpop, segretario del partito fascista di Salò, ma soprattutto
intellettuale". Da qui la decisione di intitolargli una via.
Scelta che scatena la protesta del
Pdci: "Una strada, nel Comune di Rieti dedicata ad Alessandro
Pavolini - spiega il capogruppo dei Comunisti italiani alla Pisana,
Maria Antonietta Grosso - è un'offesa alla nostra democrazia, alla
sua Costituzione, alle migliaia di vittime innocenti che subirono la
barbarie nazifascista, a tutti coloro che diedero la vita per una
società libera".
Ecco perchè, aggiunge sempre Grosso, è
un atto dovuto presentare una mozione urgente al consiglio regionale
del Lazio al fine di evitare "che uno dei più grandi organizzatori
dell'inganno di un popolo, un guerrafondaio, un uomo ammirato da
Hitler, che a sua volta ammirava, il responsabile di tragedie
inaudite che costarono la vita anche ai propri camerati, il numero
due di un regime che ha riempito un ventennio di storia col sangue
di tanti sinceri democratici, sia ricordato come 'uomo di cultura' e
come persona con profondi legami con un territorio che ha visto gli
eccidi nazi-fascisti di Leonessa, di Poggio Bustone, delle fosse
reatine".
Il segretario regionale dei Comunisti
Italiani Mario Michelangeli sottolinea poi che non si deve
"valorizzare chi ha fatto del fanatismo e della menzogna, della
guerra di sterminio e della ferocia la propria bandiera,
sintetizzando l'agire di Alessandro Pavolini. Dedicare una strada ad
un oscuro personaggio come Pavolini non è neppure mero revisionismo
storico, al quale ci vorrebbero abituare, ma una vera e propria
aberrazione, una spudorata buffonata".
Enzo Foschi, consigliere Ds-Ulivo alla
regione Lazio, dichiara in una nota il suo appoggio alla mozione del
Pdci: "Non è assolutamente pensabile che si possa calpestare la
memoria di persone che hanno sacrificato la propria vita per la
nostra libertà, intitolando una via di Rieti a una persona che fece
del fascismo e della sua barbarie la sua vita".
Prende invece le difese del Comune
Antonio Cicchetti, capogruppo regionale di An: "È giusto che la
toponomastica rispetti e rispecchi la storia d'Italia, non una
fazione ideologicamente armata di italiani di oggi. Non deve
destare, pertanto, meraviglia che anche Alessandro Pavolini,
intellettuale, operatore di cultura, ministro, caduto per le sue
idee, abbia una sua strada".
Critiche alla decisione rietina
vengono anche dall'assessore alla cultura della Provincia di Roma
Vincenzo Vita convinto che sia "totalmente inopportuno riabilitare
implicitamente, con l'intitolazione di una via, il fascismo e la
repubblica di Salò". Riguardo poi la levatura intellettuale di
Pavolini, Vita non vuole pronunciarsi ma, "senza comunque voler
offendere nessuno", dichiara che "se si volesse intitolare una via a
tutti gli intellettuali avremmo bisogno non di una, ma di più
Italie'".
(23 ottobre 2006)
20 ottobre
Migliaia d'ordigni micidiali
Nei villaggi del
sud, dove l'incubo delle cluster bomb durerà anni
Un milione di bombe a grappolo sul
Libano, già una ventina di morti, agricoltura danneggiata. E Israele
non fornisce all'Onu le mappe delle zone più colpite
Michele Giorgio, inviato a Deir Qanun
La sigla di colore rosso su un mattone
sistemato a pochi centimetri da una scatoletta nera è inquietante.
«CB», cluster bomb, bomba a grappolo. Due parole che sono diventate
un incubo per decine di migliaia di libanesi che vivono nel sud del
paese e che continueranno ad esserlo per anni. «Avevo sentito
durante un programma televisivo che dobbiamo stare attenti a dove
mettiamo i piedi, perché i nostri terreni sono pieni di queste
cluster bomb sganciate dagli israeliani sul Libano (durante la
guerra della scorsa estate, ndr) ma non mi aspettavo di trovarne una
proprio nel mio giardino», racconta Hassan Remlawi, di Deir Qanun,
indicando il mattone con la scritta «CB». «Qualche giorno fa, mentre
ero seduto davanti casa, ho visto vicino all'albero un oggetto
strano. Ho telefonato a mio fratello che mi ha detto di tenermi a
distanza di sicurezza, perché probabilmente era una di quelle
dannate bombe. Aveva ragione». Da allora Hassam Remlavi e la sua
famiglia vivono nel timore che l'ordigno esploda all'improvviso,
magari a causa del passaggio di un gatto o di un altro animale. Gli
artificieri della «Mag» - un'organizzazione non governativa
britannica che si occupa di sminamento in Libano del sud - hanno
promesso che arriveranno al più presto. Ma sino a quel momento la
famiglia Remlawi vivrà nell'ansia.
Gli specialisti della Mag vengono da vari paesi, in gran parte sono
ex militari divenuti pacifisti, che hanno deciso di impegnarsi per
salvare vite umane in Libano del sud. «È una corsa contro il tempo,
perché ogni volta che scopriamo e facciamo brillare uno di questi
ordigni sparsi dagli israeliani vuol dire che un essere umano,
soprattutto un bambino, ha un pericolo in meno dal quale guardarsi»,
dice Alain, francese, giunto a Deir Qanun nelle scorse settimane,
dopo aver trascorso 12 anni nello sminamento marino per conto di una
società privata.
Chiuso nella sua tuta da lavoro protettiva, con la visiera del casco
abbassata sul volto, Alain passa le giornate assieme ai suoi
colleghi alla ricerca delle cluster bomb. «Sappiamo dove sono le
concentrazioni maggiori di questi ordigni oppure ci chiamano gli
abitanti - spiega -, per il momento ci stiamo impegnando nella
bonifica di edifici e giardini pubblici, strade e case, i luoghi più
popolati e frequentati. Questo lavoro richiederà anni, ma non ci
perdiamo d'animo». Il cauto ottimismo di Alain non basta a placare
la paura in decine di villaggi. Nel Libano meridionale infatti
potrebbero trovarsi almeno un milione di bombe a grappolo israeliane
e sino ad oggi lo Stato ebraico non ha acconsentito a fornire all'Onu
informazioni dettagliate sulle incursioni nelle quali sono state
utilizzate queste armi insidiose e letali. Dal cessate il fuoco del
14 agosto fino ad oggi gli ordigni hanno causato la morte di 20
persone, fra cui due bambini, e il ferimento di altre 120. Ad oltre
200mila sfollati è stato sconsigliato di rientrare subito nelle
proprie abitazioni, perché sono a rischio. «Al momento sono stati
identificati 770 siti sui quali sono state sganciate bombe a
grappolo, e sono stati eliminati 30mila ordigni», ci dice
accogliendoci nel suo ufficio di Tiro Dalia Farran, portavoce dell'Unmacc,
l'agenzia dell'Onu che dal 2000 si occupa dello sminamento del
Libano del sud. «Abbiamo dovuto interrompere il lavoro ordinario
perché siamo in emergenza. Pensate che dal 2000 a oggi 30 libanesi
sono stati uccisi delle mine antiuomo e ora in appena due mesi sono
morte già 20 persone a causa delle bombe a grappolo - prosegue,
sottolineando che oltre al milione di cluster bomb - in Libano del
sud restano ancora 400mila mine antiuomo».
Le bombe a grappolo non sono proibite dalle leggi di guerra, sebbene
la Convenzione di Ginevra ne sottolinei i rischi per la popolazione
civile. Impiegabili sia dall'artiglieria che dall'aviazione, sono
progettate per dividersi in volo. «Un proiettile di artiglieria è in
grado di disperdere 88 cluster bomb in un'area di 20 km, un missile
sganciato da un aereo ne sparge 644 in 50 km», continua Dalia Farran,
mostrandoci una mappa del Libano del sud con una miriade di punti di
colore rosso indicanti altrettante località dove sono state
individuate le bombe. «Quando un essere umano finisce su uno di
questi ordigni nel migliore dei casi perde un arto, altrimenti muore
dilaniato». I bambini sono i più esposti al pericolo e proprio per
tutelare i più piccoli e più in generale i civili, l'Unmacc ha più
volte sollecitato Israele a fornire le mappe militari con
l'indicazione delle aree dove sono state sganciate le bombe. «Ma da
Tel Aviv non abbiamo ancora ricevuto risposte. Pensate solo di
recente Israele ci ha fornito le informazioni su dove si trovano
parte delle mine antiuomo. E non è da sottovalutare il fatto che
gran parte delle cluster bomb siano state sganciate nelle ultime ore
della guerra (della scorsa estate) prima che entrasse in vigore il
cessate il fuoco con Hezbollah», conclude Farran. Alcuni sminatori
che in passato sono stati impegnati in Kosovo, Sudan, Kuwait, Iraq,
Bosnia e Afghanistan, hanno riferito di non aver mai operato in
un'area tanto «contaminata» come il Libano del sud.
Per questa ragione gran parte delle attività agricole si sono dovute
fermare. «Abbiamo già perduto la stagione del tabacco e ora
perderemo quella della raccolta delle olive», dice Maher A-Surawi,
un contadino di Yanur «ma non possiamo fare diversamente, abbiamo
paura e tra quei pochi di noi che si sono avventurati nei campi,
alcuni hanno perduto la vita». Un disastro per l'intero Libano del
sud che dipende per il 70% dall'agricoltura ma anche per migliaia di
manovali palestinesi dei campi profughi che vivono con la raccolta
della frutta, uno dei pochi lavori che sono autorizzati a svolgere.
Resta in silenzio la comunità internazionale che pure ha condannato
con forza Hezbollah per gli oltre mila katiusha sparati contro i
centri abitati (dove hanno fatto più di 30 morti civili). Le cluster
bomb nei villaggi sudlibanesi invece non generano sdegno.
La città
sotterranea
Guglielmo Ragozzino
Qualcuna delle duecento persone che
contano in Italia (o anche delle mille che credono di contare) è mai
scesa nella metropolitana di Roma? S'intende, non per un tragitto
finto, per un'inaugurazione, con la vettura pulita e le hostess
sorridenti, ma in una prima mattina vera, una qualsiasi; o anche tra
le otto e le nove, evitando così l'alzataccia. Sarebbe un'esperienza
senz'altro utile, per capire il mondo che si muove, i giovani e gli
anziani, il commercio, la scuola, i sistemi di famiglia, i segni
complessivi del progresso, del ritardo, del ristagno e anche un bel
po' di globalizzazione. Un'esperienza che comunque i nostri vip non
faranno. Ai funerali si va con le auto di servizio.
Alle otto, alle nove del mattino nella metro di Roma molti e molte
vorrebbero leggere, se non altro il giornale. Si tratta per lo più
di un giornale gratuito fatto per loro che si chiama appunto Metro.
Molte donne leggono libri, quelle poche che sono riuscite a sedersi.
Se ci riescono, la loro giornata andrà meglio. Molti uomini le
guardano, pieni di curiosità. Lo spazio è così ridotto che non c'è
problema per reggersi in piedi, sempre che non ci siano brusche
frenate o brusche accelerazioni. Non è l'inferno, ma certo è molto
scomodo, sporco, degradante. Perché mai la parte più viva della
città debba essere tanto penalizzata, non è dato capire. A volte
sembra poi che l'unica manutenzione sia fatta dai graffitari che
amano lasciare memoria di sé rendendo oscuri i vetri e illeggibili i
nomi delle stazioni nei cartelli sulle pareti.
Sulla linea arancio, contrassegnata dalla A - come dice con una
punta di orgoglio la società comunale che svolge il servizio -
salgono in media quattrocentocinquanta mila utenti al giorno. Sulla
linea blu, indicata con la B sono trecento mila. E poi l'alfabeto,
il più corto tra quelli in uso in qualsiasi capitale, è già finito.
La metropolitana romana, così miserabile, così degradata è uno
strumento essenziale per vivere e spostarsi in una città infestata
dalle auto e dalle moto che provocano un inquinamento crescente,
anche se i duecento vip e i loro adepti fingono di non conoscerlo o
lo curano con palliativi domenicali. I tempi per allungare
l'alfabeto, per avere una terza linea metropolitana, si dilatano
continuamente; e i problemi di mobilità di abitanti e ospiti della
città crescono, come anche i sacrifici e i tempi di percorrenza.
Intanto il Comune, anche attraverso la società della metropolitana
costruisce parcheggi sotterranei, e facendolo, non solo spreca la
capacità tecnica e finanziaria disponibile che non è eccelsa, ma dà
in prima persona un chiaro segnale in una direzione opposta: più
auto, più traffico individuale in città.
Sarebbe un errore farne un caso solo romano. In Italia, in centri
grandi e piccoli l'auto e la sua sorellina a due ruote stanno
definitivamente espropriando le persone dalle loro vite. Strade come
confini, ponti, cavalcavia, tunnel, autostrade a otto corsie, sono
la nuova geografia, molto invadente. Le nuove rotaie servono solo
per far correre i treni ad alta velocità, inutili, come sanno tutti,
per ridurre il traffico delle automobili, quello vero, che consiste
in spostamenti brevi, di cinquanta chilometri o poco più. O per
girare come anime perse in città, alla ricerca di un parcheggio, in
attesa che il Comune, che la società della metropolitana gliene crei
uno.
Italia, tre
milioni di famiglie escluse dal sistema finanziario
Il 14,1% delle famiglie italiane -
quasi tre milioni - non è titolare neanche di un conto corrente
bancario o postale. Questa la fotografia dell'esclusione finanziaria
che emerge dall'ultima indagine della Banca d'Italia sui bilanci
delle famiglie. Tra le categorie a maggior rischio di esclusione
microimprese, lavoratori atipici, immigrati. Nel mondo il 90% della
popolazione, soprattutto nei Paesi poveri a medio e basso reddito,
non ha accesso al credito.
L'85,9% delle famiglie italiane è
titolare, alla fine del 2002, di almeno una attività finanziaria. Ad
esempio, il 77,9% ha un deposito bancario, il 16,9% un deposito
postale, il 9,4% titoli di Stato, il 14% obbligazioni e quote di
fondi comuni di investimento. Ma il restante 14,1% delle famiglie -
quasi tre milioni su un totale di 21,2 milioni - non è titolare di
nessuna attività, neanche nelle forme più semplici del conto
corrente bancario o postale. Anche se non necessariamente povero, è
escluso dal sistema finanziario.
I dati sono contenuti nel Supplemento
al Bollettino Statistico della Banca d'Italia "I bilanci delle
famiglie italiane nell'anno 2002", uscito quest'anno a marzo.
Esaminando le caratteristiche riferite al "capofamiglia", cioè al
maggior percettore di reddito all'interno della famiglia, otteniamo
una vera e propria mappa dell'esclusione finanziaria in Italia. Ci
riferiamo in particolare al più diffuso strumento finanziario, il
deposito bancario, che in larga misura - per quasi i tre quarti del
totale - è deposito in conto corrente. In qualche caso, come nei
piccoli centri o nel Mezzogiorno, altre attività come i depositi
postali sembrano attenuare l'effetto di esclusione. Viceversa, per
le attività finanziarie più sofisticate le disuguaglianze tra gruppi
sociali e territori appaiono più accentuate.
In primo luogo l'esclusione
finanziaria riguarda le donne: il 30,1% di esse non possiede un
deposito in banca contro il 18,7% di uomini. Le quote degli esclusi
sono in aumento rispetto alla rilevazione precedente del 2000:
allora non aveva un deposito bancario il 29,6% delle donne e il
17,9% degli uomini.
Sono maggiormente esclusi gli anziani:
non possiede un deposito in banca il 38% degli
ultrasessantacinquenni, mentre nelle altre fasce di età gli esclusi
sono sempre sotto il 20%, con l'eccezione dei più giovani (fino a
trent'anni) che vedono un 22,8% di loro senza conto in banca.
L'esclusione, inoltre, cresce al diminuire del livello di
istruzione: è privo di un deposito il 63,8% delle persone senza
titolo di studio e il 36,1% di coloro che hanno la licenza
elementare, mentre la quota si riduce sotto il 20% per chi ha
concluso la scuola dell'obbligo, sotto il 10% per i diplomati e al
4,2% per i laureati.
Sono più escluse le famiglie a basso
reddito: non ha depositi bancari il 67,7% di quelle con reddito fino
a 10 mila euro annui e il 33% di quelle con reddito tra 10 mila e 20
mila euro. Sopra i 30 mila euro l'esclusione di riduce al 5%. Ci
sono differenze anche tra i settori produttivi e le condizioni
professionali. Il 21,2% dei capofamiglia contadini non ha un
deposito bancario mentre nell'industria e nel terziario la quota
scende sotto il 15% e nella pubblica amministrazione sotto il 10%.
Tra i lavoratori dipendenti sono
maggiormente esclusi gli operai (23,2%) rispetto agli impiegati
(7,5%). Tra i lavoratori autonomi, soprattutto di nuova generazione,
è senza deposito in banca il 14,4% delle famiglie, mentre la quota
scende a meno del 2% per imprenditori e liberi professionisti. Il
dato dei pensionati - 32,5% di esclusione - conferma le difficoltà
delle famiglie con persona di riferimento anziana.
Altre indicazioni riguardano la
composizione del nucleo familiare e la localizzazione. Sono
maggiormente escluse dal sistema finanziario due tipi di famiglie:
quelle con 1 componente (non ha il conto il 35,7%) e le famiglie con
5 o più componenti (25,7% senza deposito). La mancanza di conto in
banca è più frequente quando in famiglia c'è un solo reddito: 32,2%
di esclusi.
L'esclusione è maggiore nei piccoli
centri: è senza deposito il 23,9% delle famiglie che abitano in
Comuni fino a 20 mila abitanti e il 23,1% di quelli dei Comuni fino
a 40 mila abitanti. Sono maggiormente escluse le famiglie del sud e
delle isole: il 44,9%, contro il 15% dell'Italia centrale e l'8,7%
dell'Italia settentrionale.
Francesco Terreri -
www.microfinanza.it
19 ottobre
Ma che state a
Fao?
Il diritto al cibo è stato
riconosciuto sin dai primi documenti elaborati dalle Nazioni unite,
a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.
Ma nell'opinione pubblica è ancora diffusa l'idea che se 852 milioni
di persone soffrono la fame è a causa solo di carestie, disastri
naturali, congiunture economiche sfavorevoli, cioè di condizioni non
del tutto controllabili da chi detiene il potere. Invece oggi è
possibile garantire a ogni abitante del pianeta un'adeguata
alimentazione e se ciò non avviene è soprattutto per mancanza di
impegno politico da parte di chi ha la possibilità e il dovere di
combattere la fame alla radice. E i capi di stato e di governo lo
sanno molto bene. Nel 1996 le delegazioni di 185 paesi più quella
dell'Ue si riunirono a Roma per il World food summit e approvarono
un Piano d'azione per dimezzare entro il 2015 il numero di persone
che patiscono la fame. Nel 2000, riuniti nell'Assemblea dell'Onu,
ribadirono questo impegno definendo gli Obiettivi del Millennio,
anche se nel farlo abbassarono un po' il tiro, proponendosi di
dimezzare - sempre entro il 2015 - non il numero assoluto bensì la
percentuale di persone che non godono di un'alimentazione
sufficiente. Ma gli impegni assunti sono rimasti in gran parte
lettera morta, tant'è che il numero delle persone che persone vanno
a dormire affamate è aumentato di 18 milioni.
Dal 30 ottobre al 4 novembre prossimi
i delegati di 180 paesi si incontreranno nuovamente, ancora a Roma,
nel palazzo della Fao. Per invertire la rotta dovranno affrontare
seriamente alcuni problemi cruciali, tra cui quello delle
insufficienti risorse che i paesi industrializzati destinano a
quelli in via di sviluppo. Ma altre questioni sono non meno
importanti, come il fatto che molti governi promuovano l'agricoltura
su vasta scala a scapito delle esigenze dei piccoli agricoltori;
oppure che sostengano la produzione di cibo ma non ne garantiscano
un'adeguata distribuzione a tutti i cittadini. Naturalmente
dovrebbero discutere anche del fatto che la Banca mondiale e il Fmi
concedono prestiti ai paesi poveri spingendo i governi a tagliare i
servizi alle comunità, con grave danno per i piccoli agricoltori,
nonché delle regole del commercio internazionale: grazie ai sussidi
dei loro governi, i contadini dei paesi più ricchi possono esportare
e vendere a basso prezzo i loro prodotti in paesi in via di
sviluppo, danneggiando seriamente gli agricoltori locali i cui
prodotti non reggono la concorrenza di quelli importati. ActionAid
International ha lanciato la campagna «Che state a Fao?», volta a
sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica sul vertice. Il ruolo
giocato dai cittadini comuni è cruciale: dobbiamo chiedere a gran
voce chiarezza sulle responsabilità dei governi, sulle promesse non
rispettate, sul ruolo della Fao.
Marco de Ponte Segretario generale di
Action Aid
La questione
monetaria
Ing. Lino Rossi
1 – Messa al passivo delle “banconote in circolazione”
Estratto dal bilancio presentato dal governatore Mario Draghi il 31
maggio 2006.
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ricec/relann;internal&action=_framecontent.action&Target=_top
I - IL BILANCIO DELLA BANCA D'ITALIA
PASSIVO
importi in unità di euro
2005
2004
1 BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE
94.933.679.360
84.191.125.720
È la Banca d’Italia stessa che nella
definizione delle “BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE” ci racconta che esse
sono REDDITO.1)
Nel momento in cui si pongono nelle passività i suddetti “redditi”
succede che gli stessi vengono sottratti al CONTO ECONOMICO, così
come definito dall’art. 2425 del C.C.. Significa due cose:
1) il reddito così trattato non viene sottoposto a nessun tipo di
imposizione fiscale, né a nessun tipo di rientro nelle casse dello
Stato;
2) lo stesso viene fatto sparire dalla contabilità per prendere la
misteriosa via del “NERO”.
Il mondo accademico prova a correre in soccorso a bankitalia
spiegando meglio la faccenda. Dal libro universitario di economia
aziendale (Produzione e Mercato - A. Birolo G. Tattara - Ed. Il
Mulino - 1991 - ISBN 88-15-02961-3): "Si osservi che il biglietto di
banca rappresenta un debito della banca centrale nei confronti di
chi lo possiede. Quando un biglietto torna alla banca centrale, il
debito che esso rappresenta è automaticamente estinto;
l'eliminazione del debito comporta dunque la distruzione della
moneta".
Quindi è tutto chiaro!? Bankitalia si è sbagliata a definire le
“banconote in circolazione” come “reddito” perché in realtà è un
debito e quindi fa benissimo a mettere quelle somme nelle passività.
La banconota che torna alla banca centrale viene distrutta.
Vengono spontanee alcune domande:
a) da quando in qua un soggetto percepisce gli interessi di un
debito da esso stesso contratto?
b) quando un debito non viene richiesto da nessuno è ancora tale?
Nessuno infatti ha titolo per andare alla Banca d’Italia ad esigere
la restituzione di quel “debito”!
c) da quando in qua un debitore “distrugge” il credito altrui?
Quelle banconote sono della collettività e servono per scambiare i
beni che la collettività stessa produce. Ciò verrà spiegato in
seguito.
Il mondo accademico in questo caso ha sicuramente svolto l’ingrato
compito di “Avvocato delle cause perse”.
Vediamo di quali cifre stiamo parlando. Dai bilanci ufficiali
presenti sul sito della nostra banca centrale troviamo:
|
anno |
Banconote in circolazione [€] |
|
1996 |
54.799.175.735 |
|
1997 |
58.914.304.307 |
|
1998 |
63.220.005.474 |
|
1999 |
70.614.050.000 |
|
2000 |
75.063.752.000 |
|
2001 |
64.675.772.000 |
|
2002 |
62.835.488.000 |
|
2003 |
73.807.446.000 |
|
2004 |
84.191.125.720 |
|
2005 |
94.933.679.360 |
|
2006* |
100.000.000.000* |
|
* stima
|
Si tratta quindi di circa il triplo
della manovra finanziaria in esame questi giorni. Sottolineo la
misteriosa forte contrazione degli anni 2001 e 2002. Si comprenderà
meglio in seguito l’assurdità di questa stranezza.
Quando troviamo:
- nella seconda edizione di “Euroschiavi” di Marco Della Luna ed
Antonio Miclavez, Arianna editore –
alle isole Cayman sono stati trovati i seguenti conti:
700 26891 A01 N BANCA D'ITALIA UFFICIO RISCONTRO VIA NAZIONALE, 91
I-00184 ROMA ITALIA
709 27154 A01 N BANCA D'ITALIA SERVIZIO RAPPORTI CON L'ESTERO,
UFFICIO RISCONTRO 2484 VIA NAZIONALE, 91 I-00184 ROMA ITALIA;
- sul web - http://spazioinwind.libero.it/cobas/finanzaloro/bancaditalia.htm
- La Banca d'Italia nel 1994, tramite l'Ufficio italiano cambi (Uic),
è entrata - con 100 miliardi di dollari - in una società controllata
dall'Hedge Fund Ltcm e costituita nel paradiso fiscale delle CAYMAN
ISLAND dai soci promotori dello stesso Ltcm !!!
- nel Corsera del 26-10-95 il Financial Time ha scritto che per
questo investimento la Banca d'Italia ha perso la sua "credibilità
morale";
- ne Il Sole 24 Ore dell’ 8-10-98 - "E' assurdo utilizzare riserve
nazionali per investire su un fondo come Ltcm, che era chiaramente
speculativo", dichiara Edward Thorp, "padre" degli Hedge Fund
americani;
- nel libro “Il Potere del denaro svuota le democrazie” di Giano
Accame, ed. Settimo Sigillo – un esplicito riferimento alla presenza
della Banca d’Italia alle isole Cayman.
COSA POSSIAMO PENSARE?
Possono essere informazioni vere o false; poco importa; andare a
rintracciare i fondi neri è sempre un’impresa complessa. Ciò che
conta è che quei soldi non sono dove dovrebbero essere, ovvero nelle
casse dello Stato a lenire il nostro enorme debito pubblico.
Ma l’argomento del contendere è “solo” di 100 miliardi di euro?
Dal sito http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/index.htm
scopriamo che il debito pubblico nazionale il 31/12/2005 era pari a
1.511 miliardi di € dei quali l’80% sono titoli di Stato; oltre
1.200 miliardi di €.
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/Dati-Stati/Composizio/2005/Composizione-dei-Titoli-di-Stato-in-11.pdf
Quindi apparentemente lo Stato è indebitato con i Cittadini
possessori di tutti questi titoli di debito pubblico. È questa solo
una parte della verità. La verità completa è scritta fra le righe
degli atti ufficiali.
Dalla sentenza con la quale il tribunale di Roma ha condannato il
Prof. Giacinto Auriti per temerarietà, il 20 settembre 1994,
apprendiamo: " .... la Banca d'Italia cede la proprietà dei
biglietti, i quali, in tale momento, come circolante, vengono
appostati al passivo nelle scritture contabili dell'Istituto di
emissione, acquistando in contropartita, o ricevendo in pegno, altri
beni o valori mobiliari (titoli, valute, ecc.) che vengono, invece,
appostati nell'attivo. "
Della seduta della Camera dei Deputati tenutasi il 17/03/1995, il
deputato Pasetto rivolse una interrogazione al Ministro del Tesoro
per sapere se non intendesse promuovere una riforma legislativa
diretta a definire la moneta un bene reale conferito, all'atto
dell'emissione, a titolo originario di proprietà di tutti i
cittadini appartenenti alla collettività nazionale italiana, con
conseguente riforma dell'attuale sistema dell'emissione monetaria,
che trasforma la banca centrale da semplice ente gestore ad ente
proprietario dei valori monetari. Nel rispondere a tale
interrogazione, il Sottosegretario di Stato per il Tesoro, Carlo
Pace, ha affermato: è inesatto sostenere che la banca centrale è
proprietaria dei valori monetari, avendo per legge il compito
istituzionale di emettere moneta e quindi crearla e di immetterla in
circolazione "mediante il trasferimento ad altri soggetti,
normalmente verso il corrispettivo di titoli o valute estere,
attraverso le operazioni a tal fine legislativamente previste
(quali, ad esempio, quelle di risconto o di anticipazioni,
disciplinate dagli articoli 27 - 30 del Regio Decreto 28 Aprile
1910, n. 204, e successive modificazioni)"; ciò premesso, "in
sostanza, per tutta la durata della circolazione, la moneta
rappresenta un debito una passività dell'Istituto di Emissione; e
come tale è iscritta, nel suo Bilancio, fra le poste passive".
Proviamo a seguire la procedura vigente passo dopo passo. La
collettività ha prodotto nuovi beni e servizi che non può immettere
con successo sul mercato perchè manca la necessaria monetizzazione
pari ad esempio a 5 miliardi di €. Lo Stato emette titoli di debito
pubblico pari a 5 mld di € per il quale l’autorità monetaria emette
nuova moneta.
Prima di questo istante ci trovavamo in questa configurazione:
- debito dello Stato: 1.500 mld di €;
- banconote in circolazione al passivo della situazione patrimoniale
della Banca d’Italia: 100 mld di euro.
Dopo l’effettuazione dell’operazione ci troveremo in questa
configurazione:
- debito dello Stato: 1.505 mld di €;
- banconote in circolazione al passivo della situazione patrimoniale
della Banca d’Italia: 105 mld di euro;
- nuovi 5 mld di € di titoli di debito pubblico all’attivo della
situazione patrimoniale della Banca d’Italia;
- nuovi 5 mld € virtuali monetizzano la società.
Qualora la Banca d'Italia decidesse o avesse la possibilità di
trasferire ai risparmiatori quei nuovi titoli di debito pubblico in
cambio di 5 mld di €, cosa succederebbe nella sua Contabilità in
termini di situazione patrimoniale, conto economico e trattamento
fiscale?
Succederebbe che la banca d'Italia incasserebbe 5 mld di € che
stornerebbe dalle banconote in circolazione, così come pure
stornerebbe dall'attivo i titoli di Stato.
Ma i 5 miliardi di € ricevuti dai risparmiatori che fine fanno? Essi
sono annullati contabilmente dalla messa al passivo delle monete
emesse a costi pressoché nulli nel passaggio precedente. La parola
“Cayman” in questi casi risulta particolarmente sinistra per la
collettività ed interessante per chi smaneggia quelle somme.
Otterremmo quindi la seguente configurazione:
- debito dello Stato: 1.505 mld di €;
- banconote in circolazione al passivo della situazione patrimoniale
della Banca d’Italia: 100 mld di euro;
- ritorno alla configurazione di partenza dei titoli di debito
pubblico all’attivo della situazione patrimoniale della Banca
d’Italia;
- 5 mld di € in nero da sistemare da qualche parte.
Il mondo accademico giura che quei 5 mld vengono distrutti, ma
qualche dubbio appare lecito. Ipotizziamo che gli si creda e si
creda anche alle tiepide ed incerte dimostrazioni presentate da
bankitalia nei suoi bilanci. Otterremmo la seguente configurazione:
- debito dello Stato: 1.505 mld di €;
- banconote in circolazione al passivo della situazione patrimoniale
della Banca d’Italia: 100 mld di euro.
Ma questo non è ciò che serve alla collettività; ad essa serve una
monetizzazione di 5 mld di euro SENZA contrarre nessun
indebitamento, perché è essa che ha prodotto quei nuovi beni e
quindi quei 5 mld di € sono dello Stato che la rappresenta.
La procedura è identica anche nei paesi “comunisti”. Non è difficile
ora comprendere la genesi del pressoché generalizzato indebitamento
pubblico di tutti gli Stati.
Se invece lo Stato emettesse per proprio conto le monete oppure la
banca centrale gli cedesse le monete emesse a costi tipografici e
questi ne postasse l’importo all’attivo del proprio bilancio, la
configurazione che si otterrebbe sarebbe la seguente:
- lo Stato non si indebiterebbe;
- il corpo sociale beneficerebbe dei 5 mld di € per effettuare le
transazioni necessarie alla messa sul mercato dei nuovi beni
prodotti da esso stesso.
È proprio questo ciò che serve alla collettività.
2 – Perché lo Stato ha delegato ad un organismo privato
sovranazionale la gestione della moneta?
Il motivo “ufficiale” è che storicamente spesso è successo che il
potere politico non ha operato ragionevolmente con le proprie
monete, provocando fenomeni negativi quali gli aumenti dei prezzi
determinati dalla produzione di troppa moneta.
In risposta a due interrogazioni del 3 novembre e 1° dicembre 1994,
rispettivamente dei senatori Natali e Orlando (appartenenti il primo
al gruppo di Alleanza Nazionale, ed il secondo al gruppo di
Rifondazione Comunista), il Sottosegretario di Stato per il Tesoro,
Vegas, ha ripetuto quale fosse il compito istituzionale
dell'Istituto di Emissione ed ha ribadito che questo non fosse
proprietario dei valori monetari e che per tutta la durata della
circolazione la moneta rappresentasse un debito, come tale iscritto
nel bilancio dell'istituto fra le poste passive.
Come ulteriore argomentazione il Sottosegretario Vegas ricordò come
nella attuale dottrina economica e nelle opinioni pubbliche degli
Stati europei fosse avvertita e radicata l'esigenza "di non
concentrare nelle mani di uno stesso soggetto politico, quale
potrebbe essere l'autorità di governo, il potere di creare moneta e
quello di spenderla, onde impedire che la moneta diventi strumento
di lotta politica"; e ricordò che tale esigenza aveva trovato
esplicito riconoscimento giuridico nel Trattato di Maastricht, che
"sancisce il principio cardine dell'autonomia delle banche centrali
dalle autorità governative statali, affidando in via esclusiva alle
prime le funzioni monetarie e lasciando invece alle seconde la cura
della politica fiscale e di bilancio".
Infatti un sistema economico si ha:
Dove:
P.I.L. è il prodotto interno lordo, espresso in €/anno;
V è la velocità della circolazione monetaria, espressa in utilizzi/anno;
M è la massa monetaria presente sul mercato, compresi i risparmi
correttamente impiegati negli investimenti ad esempio dal sistema bancario,
espressa in €;
P sono i prezzi dei beni e servizi prodotti e commercializzati in un
anno, espressi in €;
B sono i beni ed i servizi prodotti in un anno;
nel momento in cui
uno Stato mette in circolazione troppa moneta, cedendo alle richieste sindacali
e/o corporative e/o lobbistiche, “gonfiando” M, a parità di beni e servizi
prodotti, succede automaticamente che i prezzi aumentano.
Ma è anche vero che
se una collettività produce nuovi beni e servizi, deve disporre di una adeguata
monetizzazione senza indebitamento, perché altrimenti l’equilibrio non verrà mai
raggiunto (esattamente ciò che accade a noi).
Si aprono ora due scenari, quello attuale e quello che dovrebbe essere se si
rispettasse la Costituzione ed il Diritto Naturale.
COME FUNZIONA OGGI
Lo Stato
monetizza il sistema economico indebitandosi della necessaria nuova moneta,
introducendo un grave elemento di instabilità progressiva: la MONETA DEBITO. La
banca centrale di emissione in cambio di titoli di debito pubblico crea le
banconote dal nulla a costi tipografici, posta al passivo il valore nominale
delle suddette banconote ed aggrava perennemente e progressivamente la
situazione finanziaria dello Stato. Non è dato conoscere la destinazione delle
banconote ottenute dalla vendita dei titoli di debito pubblico ai risparmiatori,
azzerate contabilmente dalla suddetta fittizia messa al passivo del loro valore
facciale.
COME DOVREBBE FUNZIONARE
Lo Stato
monetizza il sistema economico stampando la necessaria nuova moneta e ponendo il
valore nominale delle stesse all’attivo della Sua contabilità: MONETA CREDITO.
ULTERIORI OSSERVAZIONI
Ipotizzando che sia corretto definire l’inflazione come l’aumento dei prezzi P,
perché l’autorità monetaria agisce su di essa sempre restringendo l’accesso al
credito, ovvero contenendo M, quando non è l’eccesso di M a cagionare
l’inflazione stessa?
Quando i prezzi P aumentano a causa del rincaro di alcune materie prime
importanti come ad esempio il petrolio, il rame, ecc. non abbiamo certamente la
circolazione monetaria in eccesso; anzi, per avere l’equilibrio bisognerebbe
aumentarla proporzionalmente senza indebitare nessuno. Gli attuali aumenti del
TUS sono del tutto ingiustificati; determineranno un peggioramento del debito
pubblico, con tutte le ricadute che conosciamo. L’emissione di “moneta
credito” risolve agevolmente il problema ristabilendo il necessario
equilibrio senza alcuna sorta di problema sociale.
Quando i prezzi P
aumentano a causa di carenze strutturali come ad esempio la mancanza di un
adeguato numero di punti vendita rispetto al fabbisogno (come in Italia negli
anni ’70 ed ‘80), non abbiamo certamente la circolazione monetaria in eccesso;
anzi, per avere l’equilibrio bisognerebbe aumentarla proporzionalmente senza
indebitare nessuno. Gli aumenti di quegli anni del TUS erano del tutto
ingiustificati; hanno drasticamente contribuito al peggioramento del debito
pubblico. L’emissione di “moneta credito” risolve agevolmente il
problema ristabilendo il necessario equilibrio senza alcuna sorta di problema
sociale.
Quando i prezzi P
aumentano a causa dell’aumento del debito pubblico, alimentato dalla spirale
perversa della “moneta debito” (come in Italia negli anni ’70 ed ’80, ma
soprattutto in America Latina ed in alcuni Paesi in via di sviluppo), non
abbiamo certamente la circolazione monetaria in eccesso; anzi, per avere
l’equilibrio bisognerebbe aumentarla proporzionalmente senza indebitare nessuno.
Gli aumenti del TUS sono del tutto ingiustificati; contribuiscono tragicamente
al peggioramento del debito pubblico ed al collasso sociale. L’emissione di
“moneta credito” risolve agevolmente il problema ristabilendo il
necessario equilibrio senza alcuna sorta di problema sociale.
Prima domanda per i
negazionisti:
come si può monetizzare un sistema economico in stato di carenza monetaria,
senza indebitarlo?
Per chi non è
negazionista la risposta è immediata: lo Stato stampa la moneta necessaria al
raggiungimento dell’equilibrio, postandone il valore facciale all’attivo.
La risposta dei negazionisti non è nota.
Seconda domanda per
i negazionisti:
vista l'autonomia delle banche centrali dalle autorità governative statali, qual
è l’autorità che valuta il comportamento delle banche centrali stesse? A chi
rispondono del loro operato? Che senso ha parlare di democrazia se lo strumento
fondamentale di gestione della cosa pubblica non è nelle mani dei rappresentanti
del popolo?
Va sicuramente
sottratta al potere politico la facoltà di violare il Diritto Naturale, ma non
si ravvisano certamente nelle questioni monetarie gli estremi per effettuare
questa sottrazione. La questione monetaria è un tutt’uno con la “res publica”.
Ing. Lino Rossi
NOTE
1)
A pagina 441 del bilancio bankitalia 2005 infatti troviamo:
BANCONOTE IN
CIRCOLAZIONE
La BCE
e le dodici BCN
dell’area dell’euro, che insieme compongono l’Eurosistema, emettono le banconote
in euro dal 1° gennaio 2002 (Decisione BCE 6 dicembre 2001, n. 15 sulla
emissione delle banconote in euro, in
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 337 del
20.12.2001, pp.52-54, e successive modifiche). Con riferimento all’ultimo giorno
lavorativo di ciascun mese l’ammontare complessivo delle banconote in euro in
circolazione viene redistribuito sulla base dei criteri di seguito indicati.
Dal 2002 alla BCE
viene attribuita una quota pari all’8 per cento dell’ammontare totale delle
banconote in circolazione, mentre il restante 92 per cento viene attribuito a
ciascuna BCN in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al
capitale della BCE (quota capitale). La quota di banconote attribuita a ciascuna
BCN è rappresentata nella voce di stato patrimoniale
Banconote in
circolazione. La differenza tra l’ammontare delle banconote attribuito a
ciascuna BCN, sulla base della quota di allocazione, e quello delle banconote
effettivamente messe in circolazione dalla BCN considerata, dà origine a saldi
intra Eurosistema remunerati. Dal 2002 e sino al 2007 i saldi intra Eurosistema
derivanti dalla allocazione delle banconote sono rettificati al fine di evitare
un impatto eccessivo sulle situazioni reddituali delle BCN
rispetto agli anni precedenti. Le correzioni sono apportate sulla base della
differenza tra l’ammontare medio della circolazione di ciascuna BCN nel periodo
compreso tra luglio 1999 e giugno 2001 e l’ammontare medio della circolazione
che sarebbe risultato nello stesso periodo applicando il meccanismo di
allocazione basato sulle quote capitale. Gli aggiustamenti verranno ridotti anno
per anno fino alla fine del 2007, dopodiché il reddito relativo
alle banconote verrà integralmente redistribuito in proporzione alle quote,
versate, di partecipazione delle BCN al capitale della BCE (Decisione BCE 6
dicembre 2001, n. 16, sulla distribuzione del reddito monetario
delle BCN degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio 2002, in
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 337 del 20.12.2001, pp.55-61, e
successive modifiche).
Gli interessi
attivi e passivi maturati su questi saldi sono regolati attraverso i conti con
la BCE e inclusi nella voce di conto economico
interessi attivi netti.
Il Consiglio
direttivo della BCE ha stabilito che il reddito da signoraggio
della BCE, derivante dalla quota dell’8 per cento delle banconote a essa
attribuite, venga riconosciuto separatamente alle BCN il secondo giorno
lavorativo dell’anno successivo a quello di riferimento sotto forma di
distribuzione provvisoria di utili (Decisione BCE 17 novembre 2005, n. 11, in
Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee L 311 del 26.11.2005, pp.41-42). Tale
distribuzione avverrà per l’intero ammontare del reddito da signoraggio,
a meno che quest’ultimo non risulti superiore al profitto netto della BCE
relativo all’anno considerato o che il Consiglio direttivo della BCE decida di
ridurre il reddito da signoraggio a fronte di costi sostenuti per
l’emissione e la detenzione di banconote. Il Consiglio direttivo della BCE può
altresì decidere di accantonare l’intero reddito in discorso o
parte di esso a un fondo destinato a fronteggiare i rischi di cambio, di tasso
di interesse e di prezzo dell’oro. La distribuzione dell’acconto sugli utili da
parte della BCE, corrispondente alla quota di reddito da signoraggio
della BCE stessa riconosciuta all’Istituto, è registrata per competenza
nell’esercizio cui tale reddito si riferisce, in deroga al
criterio di cassa previsto in generale per i dividendi e gli utili da
partecipazione.
Per
l’esercizio 2005 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che l’intero
ammontare del reddito da signoraggio resti attribuito alla BCE
stessa.
18 ottobre
Assalto alla
scuola
La finanziaria prevede tagli
all'istruzione per 4,5 miliardi e 50.000 posti. I tecnici della
Camera: la sentenza Ue sulla detraibilità Iva delle auto aziendali
la farà salire a 40 miliardi
Francesco Piccioni
Il diavolo si nasconde nei dettagli. E
proprio andando a spulciare nei meandri della «Relazione tecnica»
che accompagna la legge finanziaria per il 2007 si scoprono alcuni
dei (molti) rovesciamenti di segno tra annunci pubblici del governo
e atti concreti. E si scopre che il Prodi «europeo» - quello che si
fa intervistare da Repubblica al termine del vertice con Zapatero -
è decisamente più sincero del Prodi «italiano», che quotidianamente
ci tranquillizza con le sue dichiarazioni al cloroformio.
«Non abbiamo dato niente ai sindacati» - spiegava dalla Spagna -
«onestamente, i più favoriti dal progetto di legge di bilancio sono
la Confindustria, gli imprenditori». C'è poco da aggiungere: è
proprio così. Ne avevamo avuto qualcosa più di un sospetto quando
abbiamo titolato «Presi per il cuneo», ma è dalla «relazione
tecnica» che arriva la conferma più clamorosa. Per la scuola si
prevede un taglio degli organici di quasi 50.000 posti in tre anni,
per un risparmio complessivo di circa 4,5 miliardi di euro.
Il lavorio di forbici previsto è complesso. Si parte
dall'innalzamento dello 0,4% medio nel «rapporto alunni/classi». In
pratica si punta ad aumentare il numero degli alunni presenti in
ciascuna classe, con punte più elevate nelle elementari e nelle
medie superiori. Tenuto conto che negli istituti superiori le prime
classi sono già intorno alla media dei 30 ragazzi, si può immaginare
cosa può accadere. Da questa «pensata» dovrebbero risultare in
«esubero» 7.682 classi, per un totale di 19.032 insegnanti e 7.050
non docenti «risparmiati» (sono definiti proprio così).
Si prevede - ma non viene naturalmente messo nero su bianco - un
peggioramento drastico della didattica. I 185.000 ripetenti annui
sono sembrati decisamente troppi e «antieconomici»: si prevede di
ridurli di un 10%. E come? Non certo tramite l'individualizzazione
dell'insegnamento», visto che si deve peggiorare il rapporto
docenti/alunni. Si dovrà perciò «promuovere di più», a prescindere
dalla qualità della preparazione, per poter raggiungere il target di
soli 166mila ripetenti. Inutile dire che una simile manovra cozza
frontalmente contro la sbandierata necessità di accrescere lo
standard medio di preparazione degli studenti italiani.
Nella stessa direzione vanno la riduzione delle ore di lezione nei
professionali, quella degli insegnanti di inglese nella scuola
primaria, la «riconversione» (industriale?) degli insegnanti
«soprannumerari» e di quelli «di sostegno» (per «diversamente abili»
e «casi difficili»).
La ratio è esclusivamente economica: sfoltire i ranghi per ridurre i
costi. Anche il ringiovanimento della classe docente, tramite
l'inserimento in ruolo di 150.000 precari - uno degli annunci che
avevano sollevato più entusiasmo nei sindacati - si muove nella
stessa direzione: i giovani costano meno degli anziani. Tra l'altro,
fatti due conti, i neoassunti potrebbero essere soltanto la metà,
perché il governo prevede che nei prossimi tre anni andranno in
pensione rispettivamente 23, 24 e 27mila docenti. Come sia
conciliabile questa «cura dimagrante» con l'innalzamento
dell'obbligo scolastico ai sedici anni resta un mistero. Di certo
c'è solo che anche l'entità delle assunzioni sarà «da verificare
annualmente, di intesa col ministero dell'Economia». Ossia col
placet di Tommaso Padoa Schioppa.
Sarebbe facile obiettare che una finanziaria fatta da un abile
ragioniere rischia di sembrare indifferente alle conseguenze
sociali, ma almeno aggiusta i conti. Nemmeno questo, però, è vero.
Almeno secondo i tecnici del Dipartimento Bilancio del Servizio
studi della Camera.
Il governo, infatti, ha stabilito un saldo finale per la manovra
pari a 34,7 miliardi di euro; ma aveva anche deciso di non tener
conto degli effetti finanziari della sentenza della Corte di
giustizia Ue sulla detraibilità dell'Iva sui veicoli aziendali. Una
sentenza con effetti retroattivi e che costringerà lo stato italiano
a rimborsare le imprese interessate per un totale di 5,3 miliardi.
Et voilà, il totale della manovra sale perciò a 40 miliardi.
Una differenza così sensibile comporta il ricalcolo di tutto il
quadro delle entrate previste. Mentre i tecnici della Camera
avanzano dubbi anche sugli effetti finanziari della rimodulazione
delle aliquote Irpef, così come su quelli del trasferimento all'Inps
del tfr «inoptato». La «relazione tecnica» stima infatti «entrate» -
e già questo sarebbe tecnicamente opinabile, trattandosi in pratica
di un «prestito forzoso» - pari a 5,5 miliardi. Una speranza, perché
si basa su una previsione dei comportamenti dei lavoratori che andrà
verificata «solo a consuntivo». Ovvero dopo che sarà avvenuta. Se i
lavoratori, infatti, dovessero scegliere di trasferirlo alla
previdenza complementare, potrebbe «determinarsi un peggioramento
del quadro finanziario». Niente male, per un «tecnico della Bce» (Padoa
Schioppa) prestato alla politica per trarla d'impaccio.
In 4 andarono nella prigione Usa a
Cuba senza riferire ai pm. Almeno sei i detenuti fiurono sentiti dai
carabinieri
'Andammo a
Guantanamo per interrogatori'
La rivelazione di un agente dei Ros
MILANO - "Andammo in quattro a
Guantanamo tutti del Ros, a interrogare i detenuti nel campo nel
novembre 2002 su mandato del comando generale nella persona del
generale Ganzer. Non riferimmo all'autorità giudiziaria nulla sulla
nostra attività perché nessuna delle persone che sentimmo rispose
alle domande. Comunque a Guantanamo venimmo a sapere che eravamo gli
ultimi italiani a recarci in missione per svolgere attività
investigativa". E' quanto riferisce un maresciallo dei Ros di Torino
nell'aula della prima Corte d'assise di Milano, dove è in corso il
processo nei confronti di tre algerini, tra i quali l'ex imam Abdel
Vergout, accusati di terrorismo.
"Si trattava di colloqui informali,
durante i quali prendevamo appunti e su cui abbiamo redatto dei
report e durante i quali intendevamo capire se esistesse un rischio
di attentati in Italia", ha affermato il teste rispondendo alle
domande del pm Elio Ramondini, chiarendo poi che "nulla di quella
attività fu riversato nel processo in corso". In seguito, il
militare del Ros ha però ammesso che, "in via informale furono
avvisati della spedizione a Guantanamo il dottor Tatangelo e il
dottor Ausiello della Procura di Torino" che però, a detta del
teste, "hanno fatto finta di non sapere".
Dando poi indicazioni più precise sui
risultati dell'attività condotta a Guantanamo nel novembre del 2002,
durante quella che fu "la prima e l'unica missione del Ros" presso
la base americana in territorio cubano, il maresciallo ha chiarito
che furono probabilmente sei le persone cui furono poste domande
"senza la presenza di avvocati in quanto si trattava di colloqui
informali". Di queste "solo una rispose, a proposito delle sue
conoscenze a Bologna".
Tutte le altre decisero, invece, di
non rispondere. Il testimone nel processo della prima corte d'assise
di Milano ha spiegato di aver partecipato ai colloqui con due
persone in particolare: il magrebino Ben Abdul Mabruk e un ragazzo
di 18 anni che, a quanto poi ha appreso, sarebbe stato rilasciato
dalle autorità americane e rimandato in Marocco, il suo paese
d'origine. A quanto dichiarato in aula, il testimone aveva appreso a
Guantanamo, dalle stesse forze americane, che i detenuti sentiti
durante la 'spedizione' del Ros erano già stati ascoltati in
precedenza da altre forze di polizia, probabilmente la stessa
"polizia di Stato italiana" e alcuni investigatori "francesi,
tedeschi, svizzeri e sicuramente spagnoli".
A proposito degli interrogatori svolti
in precedenza da altre polizie, il militare ha riferito che il Ros
aveva "inoltrato richiesta formale all'autorità statunitense allo
scopo di acquisire i verbali di tali interrogatori", richiesta a cui
"non fu mai data risposta se non che quel materiale era stato
secretato".
17 ottobre
Smog e tosse
nelle aule europee
Lo studio del Cnr in cinque città. Il
77% ed il 68% dei bambini esposto a livelli elevati di Pm10 e Co2.
In Italia analisi a Siena e Udine. L'esperto: «Aumenta rischio
malattie»
A scuola ci si ammala, perchè i virus
passano di banco in banco fra i bambini ma anche perchè l’aria è
cattiva e provoca tosse e riniti. È quanto emerge dallo studio di
una ricercatrice dell'Ifc-Cnr, Marzia Simoni, che dopo aver messo
sotto osservazione un gruppo di scolari di cinque paesi europei
(Siena e Udine le città italiane coinvolte nel progetto) ha scoperto
che più di due bambini su tre respirano fra i banchi di scuola
elevate concentrazioni di anidride carbonica e di polveri sottili
pm10, cui appunto si devono probabilmente buona parte dei loro
malanni respiratori. Riguardo alle poveri sottili, la media
riscontrata è più del doppio del limite massimo stabilito come
pericoloso: 115 la misura consentita, con la città danese di Aarhus
in testa (169, con una punta massima di 214), seguita da Udine
(158), Siena (148), Reims (112), Oslo (54) e Uppsala (33).
L'anidride carbonica rilevata in aula
supera invece il limite di quasi la metà e purtroppo indica un
primato italiano: media di 1.467 ppm, con Siena a 1.954, Udine a
1.818 (qui la punta massima di 2.520), Reims a 1.660, Aahrus a
1.568, Oslo a 1.158 e Uppsala a 681. La conseguenza prevedibile, ma
anche allarmante, di questa situazione è che – come spiega Simoni –
«i bambini in aule scolastiche con elevati livelli di inquinamento
riportano con maggior prevalenza sibili, tosse secca notturna e
rinite, se paragonati ai bambini esposti a livelli bassi. In
particolare, i bambini esposti ad elevati livelli di CO2 hanno un
rischio superiore di circa 3,5 volte di riportare tosse secca
notturna e di circa 2 volte maggiore di soffrire di rinite, rispetto
a quelli esposti a bassi livelli.
Nei bambini esposti ad elevate
concentrazioni di Pm10, invece, è stata misurata una pervietà nasale
media (aree minime di sezione delle fosse nasali) significativamente
inferiore, del 9% anteriormente e del 19% posteriormente, rispetto a
bambini esposti a bassi livelli. Per effettuare la ricerca, sono
state selezionate 4 scuole in ciascuno dei cinque paesi (Francia,
Italia, Danimarca, Norvegia e Svezia) per un totale di 547 bambini
(età media 10 anni). Le misurazioni degli inquinanti sono state
effettuate durante la stagione fredda, quando il riscaldamento era
in funzione.
Il 77% ed il 68% dei bambini è
risultato rispettivamente esposto a livelli elevati di Pm10 (polveri
con diametro minore o uguale a dieci micron) e CO2 (anidride
carbonica). Sono state definite elevate , le concentrazioni
superiori a 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 ed a 1000 parti
per milione di Co2 sulla base degli attuali Indoor Air Quality
Standards statunitensi (Epa ed Ashrae). «È necessario – conclude la
dott.ssa Simoni – promuovere la consapevolezza dell'impatto che
l’aria può avere sulla salute dei nostri ragazzi, in modo da mettere
in atto strategie volte a garantire loro il diritto di respirare
aria pulita».
Michael Burda
Le ceneri di
Angela
Il governo di Angela Merkel, in
Germania, compie un anno. Con l’approssimarsi dell’anniversario in
molti si sono chiesti: ne è valsa la pena? Per diversi mesi, i paesi
della Vecchia Europa, e in particolare Italia e Francia, ma anche
molti all’interno della Commissione europea, hanno guardato
all’esperimento tedesco nella speranza che i gravi problemi
economici e sociali potessero essere risolti da una "grande
coalizione".
Le buone notizie
In teoria, ci sono due ragioni per dar
vita a una grande coalizione: La prima è tecnica: non esiste una
maggioranza per una coalizione guidata da un solo grande partito.
L’altra è il riconoscimento che è necessario un cambiamento profondo
e nessun governo espresso da un solo partito può sopravvivere
all’assalto delle lobby e di un’opposizione opportunista. Era questa
la speranza nella Germania di un anno fa: per avere un cambiamento
duraturo, era necessario che "tutti fossero a bordo", altrimenti una
parte politica avrebbe bloccato gli sforzi dell’altra, fino al punto
di capovolgere la passata legislazione.
Quest’ultima condizione non sembra valere più nella Germania di
oggi, e la grande coalizione sembra destinata a sciogliersi,
probabilmente molto prima delle elezioni politiche del 2008.
All’inizio, le cose si muovevano in fretta, molto in fretta per gli
standard tedeschi. Con un ministro delle Finanza socialdemocratico,
il cancelliere Merkel ha abolito gli aiuti all’edilizia residenziale
e tagliato gli sgravi fiscali per i pendolari: c’era un largo
consenso che si trattasse della cosa giusta da fare. Ma la stagione
dei tagli è finita presto: i sussidi continuano ad ammontare a circa
60 miliardi di euro l’anno di aiuti diretti e a 50 miliardi di
sgravi fiscali.
La coalizione è riuscita a riformare il sistema di "federalismo",
dando ai länder più autonomia in alcune aree, ma togliendo loro il
diritto di veto in altre. Sfortunatamente, non è stata toccato
l’aspetto fiscale, che avrebbe potuto contribuire a rendere più
responsabili le politiche regionali. (Infatti, i länder hanno finito
con l’avere più potere in molte materie). In nome dell’onestà
fiscale, la coalizione ha alzato l’Iva di 3 punti percentuali a
partire dal 2007. Com’era prevedibile questo ha stimolato la domanda
corrente di beni durevoli di "scontrino alto", e di conseguenza
tassi di crescita che non si vedevano dai tempi della
riunificazione.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la coalizione è rimasta
ben salda sul tracciato delle leggi Hartz: la mia interpretazione
delle recenti buone notizie dal mercato del lavoro è che queste
riforme hanno spostato verso il basso il "tasso di equilibrio",
proprio come avrebbe detto il premio Nobel 2006 per l’Economia,
Edmund Phelps. Da sottolineare che la Spd ha resistito alla
tentazione di abbandonare il campo anche quando l’Ufficio federale
per l’impiego ha tagliato programmi di spesa inutili per il mercato
del lavoro, arrivando a un considerevole surplus di 10 miliardi di
euro, di cui un terzo è forse dovuto proprio a questi tagli. Così,
Merkel e soci sono riusciti a mantenere le riforme proposte dal
predecessore Gerhard Schröder. Un risultato che da solo ha creato un
grande ottimismo nel mercato internazionale dei capitali sul fatto
che le riforme non sono solo salde, ma irrevocabili.
Questo è tutto per quanto riguarda le buone notizie: dopo dodici
mesi gli interventi facili sono finiti. I problemi difficili –
sanità, riforme più profonde del mercato del lavoro,
deregolamentazione del mercato dei prodotti e semplificazione del
sistema fiscale – sono ancora sul tavolo, ma servirà una buona dose
di energia, creatività, disciplina e capacità di resistenza per
trattare con lobby agguerrite e campioni dello status-quo. Più
importante ancora, è necessario arrivare a una diagnosi comune e
concordata del problema. L’arte del compromesso, orgoglio dei
politici tedeschi, non basterà.
Il test della riforma sanitaria
Prendiamo il test più importante che
la grande coalizione ha dovuto affrontare finora: la riforma della
sanità. Il sistema tedesco è difficile da spiegare e ancor più da
riformare. È un insieme di fondi assicurativi garantiti dallo Stato,
basati su contributi di aziende e lavoratori legati al salario,
obbligatori per tutti fuorché i meglio pagati. Dopo un lungo
dibattito, il governo ha proposto di introdurre forme di concorrenza
tra le compagnie di assicurazione sanitaria creando un fondo comune
per le contribuzioni, con cumulo dei rischi, e permettendo agli
assicurati di cambiare fondo assicurativo. Frutto di un compromesso,
la proposta evita il problema della redistribuzione: i lavoratori
dovrebbero pagare per la sanità in rapporto al reddito (Spd) o
indipendentemente da questo con una esplicita redistribuzione verso
chi sta peggio (Cdu)? La coalizione è riuscita a trovare un accordo
solo sulla creazione del fondo, uno scheletro burocratico che
sarebbe comunque necessario in entrambi i casi. Mentre litiga
praticamente su tutto il resto, compreso il controllo dei costi. I
lobbisti hanno tratto vantaggio dalla confusione dei politici e ora
sembra sempre più difficile che il compromesso raggiunto divenga una
legge prima del 2009, comunque dopo le prossime elezioni politiche.
I nemici di Merkel interni al suo partito potrebbero anche usare il
compromesso sulla sanità come un’arma – e togliere il loro appoggio
all’ultimo minuto: se Merkel dovesse essere costretta a ritirare la
proposta, ne uscirebbe molto indebolita.
Non soltanto la grande coalizione non è riuscita a proporre una
soluzione valida, ma grande è stato lo spreco di tempo ed energie,
oltre che di attenzione e pazienza dell’opinione pubblica. Non c’è
da meravigliarsi se i sondaggi danno Spd e Cdu ai livelli più bassi
in decenni.
Perché non ha funzionato
La grande coalizione tedesca sta
fallendo perché i politici non trovano un accordo sulla soluzione
giusta ai problemi della Germania. Ma non è solo colpa loro. In fin
dei conti, la Germania è una democrazia matura e si merita i
governanti e i politici che ha. Wolfgang Münchau del Financial Times
ha affermato di recente che i "tedeschi non credono più alle
favole". Non è affatto vero: i tedeschi sono ancora disperatamente
attaccati alla favola cara alla Vecchia Europa, secondo la quale le
riforme dolorose si possono evitare seguendo la "terza via". Non
sono pochi i politici, sindacalisti e lobbisti pronti a dire ai
tedeschi che si può fare a meno delle riforme e delle
riorganizzazioni viste negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in
Olanda così come nei paesi scandinavi. Era questo il messaggio del
risultato ambiguo delle elezioni di settembre 2005: procediamo a
piccoli passi e sarà meno doloroso. Vere riforme saranno ancora più
difficili ora che la ripresa è arrivata. Non importa se la Germania
ha perso più di un decennio di crescita degli standard di vita
registrato nelle economie Ocse di punta. No, la Vecchia Europa non
trarrà alcun beneficio da una grande coalizione finché non sarà
soddisfatta la condizione necessaria che ne è il centro: un
implicito consenso per un vero cambiamento diffuso nella popolazione
in generale e nella classe politica. Sotto tutti i punti di vista,
ne siamo ben lontani.
16 ottobre
Oggi la "Giornata modiale
dell'alimentazione", celebrata in 150 Paesi
Il direttore generale della Fao, Diouf: "Occorre anche l'impegno
dei privati"
La piaga della
fame per 854 milioni di persone
"Servono più investimenti in agricoltura"

ROMA -
"Oggi nel mondo 854 milioni di persone non hanno cibo a
sufficienza e hanno poche opportunità di lavorare e aumentare il
proprio reddito". Con queste parole il direttore generale della
Fao, Jacques Diouf, ha aperto a Roma la "Giornata mondiale
dell'alimentazione 2006", celebrata in 150 Paesi.
La Giornata, dedicata quest'anno al tema "Investire in
agricoltura per la sicurezza alimentare", segna il 61.mo
anniversario della fondazione dell'agenzia Onu.
Quello della fame nel mondo è un vero e proprio problema che
deve interessare tutti. Questo il messaggio del direttore
generale della Fao che prosegue: "Vi è stata di recente una
certa ripresa dei finanziamenti al settore agricolo, ma c'è
ancora molto da fare. Non solo occorre aumentare il volume degli
investimenti pubblici, ma questi devono essere accompagnati da
quelli del settore privato".
Già nel 2002 la Fao aveva stimato che per raggiungere il primo
obiettivo del Millennio, ovvero dimezzare il numero degli
affamati nel mondo entro il 2015, occorreva un costo
supplementare di investimenti pubblici di circa 19 miliardi di
dollari da destinare alla crescita agricola e all'aumento delle
produttività nelle aree rurali, e di altri 5 miliardi per gli
interventi di emergenza che forniscono accesso immediato al
cibo. Molto ancora è da fare.
Uno dei meccanismi concreti per diminuire gli affamati nel mondo
è la cosiddetta Piattaforma globale dei donatori per lo sviluppo
rurale, un consorzio di 26 agenzie per lo sviluppo, che, sempre
secondo Diouf, "deve essere rafforzato e rilanciato insieme
all'approccio cooperativo. E' questa l'unica via da seguire per
far crescere i piccoli e medi agricoltori e ridare loro
strumenti per sopravvivere e dignità".
Solo un "approccio cooperativo" che
coinvolga tutti i soggetti interessati, i produttori, le
industrie e i governi, secondo il direttore generale della Fao,
"può garantire la sicurezza alimentare. Spetta a tutti questi
soggetti coordinarsi per creare condizioni socio-politiche
stabili, promuovere norme per l'accesso all'acqua e alla terra,
applicare criteri di qualità e fornire infrastrutture rurali
essenziali per promuovere partnership remunerative".
Uno dei prossimi obiettivi della Fao sarà quindi quello di
attrarre investitori privati. Per farlo "occorre che i Governi
si adoperino per fornire accesso a condizioni fiscali, almeno
temporali, di vantaggio - ha dichiarato Claudio Gregorio, capo
divisione centro per gli investimenti della Fao - perché il
privato non deve e non può fare beneficenza".
L'agenzia Onu, in questo processo, svolge un ruolo di 'onest
broker', cioè di intermediario imparziale fra i grandi
investitori, come le banche di sviluppo e i governi, per
sviluppare le cosiddette 'public private partnership' (Ppp).
Dal 1964 la Fao ha aiutato 165 Paesi membri ad ottenere
finanziamenti per sostenere 1600 progetti per programmi
agricoli. Si tratta di investimenti che ammontano a 800 miliardi
di dollari.
Innocenti
evasioni
in un clima di complicità
di ILVO DIAMANTI
L'ANNUNCIO del ministro
Visco, che dichiara il proposito di "sradicare
l'evasione fiscale nei prossimi cinque anni", è
certamente sincero, oltre che da noi condiviso.
Il ministro, d'altronde, impersona questa
volontà come pochi altri. In modo quasi
fisiognomico. Il centrosinistra, inoltre, ne ha
fatto un obiettivo di bandiera. Tuttavia, al di
là delle intenzioni, ci sembra lecito dubitare.
Tante volte la lotta all'evasione fiscale è
stata annunciata come una priorità di governo.
E altrettante è stata lasciata cadere. D'altra
parte, è certamente difficile contrastare un
fenomeno così esteso. Che non si limita a quelle
zone, soprattutto (ma non solo) del Sud,
controllate dalla criminalità organizzata, dove
l'evasione fiscale e il lavoro nero
costituiscono "patologie ambientali". Ma è
diffuso, radicato un po' dovunque. Nel Nord
della piccola impresa, per esempio, dove è stato
usato, da sempre, come un "fattore" di
flessibilità, oltre che di risparmio. Tuttavia,
il problema maggiore è che la "pratica" si
confonde con la "cultura". Presso ampi settori
della società italiana, infatti, l'evasione
costituisce una sorta di "abitudine"
consolidata; un tratto del "carattere"
nazionale.
L'Italia: un Paese di "innocenti" evasori. Dove
non evade e non elude, soprattutto, anzitutto,
chi non lo può fare. Quelli che non hanno
possibilità di "fatturare" in nero almeno una
parte degli introiti. Quelli che non possono
"scaricare" le spese, reali o fittizie. In altri
termini: i lavoratori dipendenti, il cui
prelievo fiscale avviene alla fonte. Così
succede che i liberi professionisti, i
lavoratori autonomi, gli imprenditori - come
dimostrano, da ultime, le statistiche relative
alle denunce dei redditi 2005, pubblicate in
questi giorni - continuino, in molti casi, a
denunciare redditi inferiori agli operai, agli
impiegati, ai pensionati. (E, per questo,
vederli manifestare ieri a Treviso ci è sembrato
un po' troppo).
Tuttavia, le occasioni per sottrarsi e sottrarre
al fisco sono troppe e troppo frequenti, anche
per i lavoratori dipendenti, per non finirvi
impigliati. La prestazione dell'elettricista o
dell'idraulico, la visita dal dentista, la messa
in piega dalla parrucchiera, il lavoro di
restauro affidato all'artigiano in pensione. La
collaboratrice domestica, la badante. Figure
retribuite, spesso (non osiamo dire "perlopiù"),
in "nero". Mentre, parallelamente, molti
lavoratori dipendenti e molti pensionati
arrotondano la retribuzione, con altre attività.
Condotte perlopiù in modo informale. Senza
ricevute, senza contratti.
Certo, non possiamo porre sullo stesso piano chi
è pagato e chi paga in nero una prestazione,
sotto il ricatto dello "sconto". Né chi elude ed
evade gran parte del reddito proveniente dalla
sua remunerativa attività professionale con
l'operaio o il pensionato, che integra il suo
reddito limitato con qualche lavoretto.
Tuttavia, questa tela fitta di piccole e grandi
evasioni produce un generale clima di
complicità, condivisione. Rassegnazione. Con
l'esito che l'evasione tende a non essere
percepita, dai più, come un reato; né gli
evasori come malfattori, ma neppure come
"devianti". Al più, dei furbi. Specialisti
dell'arte di arrangiarsi, ritenuta, dagli stessi
italiani, la principale "virtù" nazionale.
I sondaggi fanno emergere indizi significativi,
al proposito. Seppure dissimulati nella nebbia
della reticenza. Perché tanto più è diffuso e
condiviso, un atto illegale (o, almeno,
irregolare), tanto più, nei discorsi della
gente, viene "eluso". Trattato con una certa
omertà (usiamo questo termine non per caso).
Tuttavia, la quota di persone che considera
"legittimi" o comunque "giustificabili" alcuni
comportamenti "illeciti", dal punto di vista
fiscale, appare comunque ampia. Infatti, il 36%
degli italiani (intervistati da Demos per "la
Repubblica", dicembre 2004: campione nazionale
rappresentativo di 1600 casi) ritiene lecito,
almeno in alcune occasioni, "pagare meno tasse
del dovuto" (in altri termini: evadere o eludere
il fisco); il 25% "pagare in nero" una
prestazione, per risparmiare. E una quota eguale
"lavorare in nero".
La stessa indagine, inoltre, dimostra come
l'atteggiamento permissivo nei confronti
dell'evasione fiscale e del lavoro nero alimenti
la sfiducia nello Stato e l'insoddisfazione
riguardo ai servizi pubblici. E viceversa.
L'evasione, quindi, sottolinea la distanza fra i
cittadini, il pubblico e lo Stato. Ma anche
l'ambiguità che ne caratterizza il rapporto.
Visto che gli italiani sono insoddisfatti dei
servizi pubblici, ma, al contempo, ne temono la
privatizzazione. E vorrebbero che tornassero
pubblici anche quelli privatizzati, come le
autostrade (Demos-Centro Studi Confindustria,
febbraio 2006).
Ciò suggerisce che all'origine dell'insofferenza
nei confronti delle tasse ci sia la svalutazione
del nostro welfare. Non solo perché produce
risposte poco efficaci. Ma perché è considerato
un diritto acquisito, piuttosto che una
conquista di civiltà, da coltivare e mantenere.
Un "bene comune"; quindi di tutti e di nessuno.
Regolato da logiche assistenziali e
particolaristiche, quanto condivise. Tanto che
il 50% degli italiani (Demos, dicembre 2004)
ritiene lecito ricorrere a raccomandazioni e ad
amicizie, per poter ottenere, in fretta, una
visita medica oppure un ricovero.
L'incertezza economica degli ultimi anni,
peraltro, ha generato delusione nei confronti
del privato, facendo crescere, in parallelo, la
domanda, ma non la soddisfazione nei confronti
del pubblico. Che resta molto bassa. Infelicità
privata e insoddisfazione pubblica, così, si
inseguono e si sommano, nel nostro Paese. Per
cui le tasse continuano ad essere percepite non
come il "prezzo della cittadinanza", necessario
a garantire servizi e tutela ai cittadini. Ma,
perlopiù, un balzello. Un vincolo, da subire,
perché e quando tocca; a cui sottrarsi, quand'è
possibile. D'altronde, lo stesso Berlusconi, da
presidente del consiglio, aveva giustificato
questa ideologia, che considera, nel caso
italiano, l'evasione spesso una necessità e il
lavoro informale un'opportunità.
Da ciò il paradosso del nostro sistema fiscale.
La cui pressione, va detto, non è inferiore alla
media europea. Al contrario, è di poco
superiore. Ciò significa che gli italiani pagano
le tasse. Non tutti nella giusta misura. Ma,
nell'insieme, le pagano. In misura massiccia.
Negli ultimi quindici anni hanno affrontato e
sopportato finanziarie pesantissime. Nel 1992,
nel 1993, nel 1996, nel 1997: hanno pagato
decine e decine di migliaia di miliardi di
vecchie lire. Senza inscenare rivolte. Solo
qualche mugugno e poche proteste. Eppure vengono
definiti e in parte si sentono: evasori. E
dunque: evasori e tartassati al tempo stesso.
Senza contraddizione e senza vergogna. Perché il
sistema fiscale è fondato sulla reciproca
sfiducia, fra i cittadini e lo Stato. Per cui lo
Stato, il governo di turno, tiene alta la soglia
della tassazione, e ricorre al prelievo fisso,
alla tassazione indiretta, quando può, perché
diffida dei cittadini. Sospetta che, per quanto
è nelle loro possibilità, sfrutteranno ogni
piega lecita e illecita, per limitare il
"danno". Li ritiene "peccatori a prescindere". E
per questo li invita, regolarmente, a chiedere
il perdono, o meglio, il "condono", pagando una
penale.
D'altro canto, i cittadini - quelli che possono,
se possono - coerentemente si difendono dallo
"Stato delle Tasse": eludendo, evadendo,
sfruttando le opportunità formali e non, offerte
dall'ambiente e dalle norme vigenti. Fino ad
ammettere colpe talora non commesse. Pagando il
periodico "condono di Natale". Così, per
precauzione. Non a caso, l'Italia è diventata il
paese con la più alta densità per chilometro
quadrato di commercialisti, consulenti
finanziari, fiscali e del lavoro.
Tutto ciò ci fa dubitare. Che
davvero il ministro Visco riesca nel suo
proposito (che noi condividiamo). Fin quando,
almeno, l'evasione apparirà ai più un'azione
innocente, un vizio minore, una virtù cinica.
Fino a quando "combatterla" risulterà non tanto
un'opera di giustizia, ma da giustiziere.
Mesi precedenti
>
Ottobre 2006 (1-15)
>
Settembre 2006
>
Agosto 2006
>
Luglio 2006
>
Giugno 2006
>
Maggio 2006
>
Aprile 2006
>
Marzo 2006
>
Febbraio 2006
>
Gennaio 2006
Anni precedenti
>
Anno 2005
>
Anno 2004
>
Anno 2003
TORNA ALLA
PAGINA INIZIALE
|





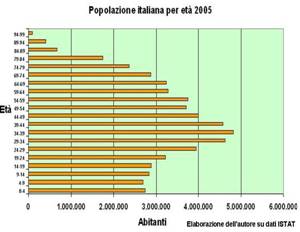
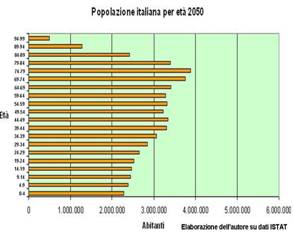
 In
uno qualunque degli oltre 10mila negozi Starbucks sparsi nel mondo,
portarsi al tavolo o sulla scrivania dell'ufficio una tazza fumante
di caffè Sidamo costa circa 2,20 dollari. In tazza non ci sono che
pochi grammi dei chicchi neri che danno il nome alla bevanda: tanto
che se fosse venduto al chilo il prezioso Sidamo costerebbe
all'avventore la bellezza di 50 dollari. Eppure a chi quel chilo di
caffè lo ha piantato, coltivato e raccolto in tasca non arrivano che
2,40 dollari. La vicenda sarebbe una delle tante storie di economia
deviata dalla globalizzazione, se non coinvolgesse due dei più noti
volti della globalizzazione stessa: Starbucks, la catena del caffè
regina in America e nel mondo, passata alla storia anche perché
riesce a vendere in tutto il mondo una bevanda dal nome di "frappuccino"
facendola passare per una tipica specialità italiana, e Oxfam, una
delle più vecchie e rispettate associazioni non governative del
mondo, che da Londra ha fatto del suo marchio un sinonimo di "giusto
e buono" riconosciuto in tutti i paesi.
In
uno qualunque degli oltre 10mila negozi Starbucks sparsi nel mondo,
portarsi al tavolo o sulla scrivania dell'ufficio una tazza fumante
di caffè Sidamo costa circa 2,20 dollari. In tazza non ci sono che
pochi grammi dei chicchi neri che danno il nome alla bevanda: tanto
che se fosse venduto al chilo il prezioso Sidamo costerebbe
all'avventore la bellezza di 50 dollari. Eppure a chi quel chilo di
caffè lo ha piantato, coltivato e raccolto in tasca non arrivano che
2,40 dollari. La vicenda sarebbe una delle tante storie di economia
deviata dalla globalizzazione, se non coinvolgesse due dei più noti
volti della globalizzazione stessa: Starbucks, la catena del caffè
regina in America e nel mondo, passata alla storia anche perché
riesce a vendere in tutto il mondo una bevanda dal nome di "frappuccino"
facendola passare per una tipica specialità italiana, e Oxfam, una
delle più vecchie e rispettate associazioni non governative del
mondo, che da Londra ha fatto del suo marchio un sinonimo di "giusto
e buono" riconosciuto in tutti i paesi.