|
Archivio Maggio 2007
29 maggio
Il canale Rctv era popolarissimo e trasmetteva in Venezuela dal 1953. Il presidente Chavez lo considerava troppo critico nei suoi confronti Caracas, spenta la tv dell'opposizione. Incidenti fra manifestanti e polizia Idranti e sfollagente su chi protestava contro la chiusura
CARACAS - Fine delle trasmissioni per
l'emittente televisiva privata Radio Caracas Television (Rctv) che,
tra accese proteste di piazza e incidenti, a mezzanotte (le 6 del
mattino italiane) è scomparsa dagli schermi venezuelani dopo 53
anni, sostituita dalla nuova Tv di servizio pubblico voluta dal
presidente Hugo Chavez, Televisione venezuelana sociale (TVes).
L'alibi dell'emergenza di MICHELE SERRA
DALLA meditata abiura del sindaco
Chiamparino sull'antiproibizionismo al cosiddetto "giro di vite"
cofferatiano sulla difficile convivenza urbana a Bologna, nella
sinistra italiana è ben percepibile un nascente clima
anti-permissivo. Che trova ulteriore conferma nella dichiarazione di
intenti del ministro della Salute, Livia Turco, favorevole all'invio
dei carabinieri dei Nas nelle scuole per "attività ispettiva"
anti-droga. Il quadro politico e psicologico nel quale matura questo
genere di prese di posizione non è da prendere alla leggera.
L'impressione di una de-regulation civile è diffusa. L'idea che
l'antiautoritarismo quasi congenito in una classe dirigente
formatasi negli anni Sessanta (noi, insomma) abbia indebolito oltre
il lecito, nelle famiglie e nelle scuole, anche ogni necessario
principio di autorità, è tutt'altro che immotivata.
Il Vajont tradito La solitudine dei parenti delle vittime a 40 anni di distanza. E uno Stato che non ha mai chiesto scusa Scritto da Lucia Vastano
Il 4 giugno i “Cittadini per la memoria del Vajont” arriveranno a Roma. Non lasciateci soli.
Il sogno del lustrascarpe Un viaggio per La Paz, attraverso gli occhi di un lustrascarpe dal nostro inviato Alessandro Grandi
“Ehi amico ti lucido le scarpe che
sono impolverate?” Con estrema gentilezza, e ostinazione, Luis, 17
anni, chiede a tutti i passanti della via principale del centro di
La Paz, me compreso, di farsi pulire le scarpe. E in questo modo
contribuire al suo sostentamento.
25 maggio
La denuncia di Flavio Bertoglio, presidente dell'Associazione Mucopolisaccaridosi "Il Bollettino regionale uscito a marzo impone di spendere il2% in meno rispetto al 2006 del File F" La Lombardia taglia i farmaci salvavita. A rischio le categorie di malati "speciali" Se le Asl superano la soglia, non vengono rimborsate dalla Regione L'interrogazione dei Verdi: "Quella del Pirellone è una decisione incredibile e inaccettabile" di CLAUDIA FUSANI
ROMA - Si chiama File F. E' una voce
della spesa sanitaria, molto particolare e delicata. Lo conoscono in
pochi ma quei pochi significa che hanno qualcuno in famiglia che o
prende determinati farmaci o rischia di morire.
«Italia apprendista stregone in Kosovo» «L'ostinazione a decretare la perdita di sovranità della Serbia, nonostante la risoluzione 1244, non trova riscontro in altra parte del mondo. Così si impone una soluzione di forza, violenta come la guerra "umanitaria"». Parla il generale Fabio Mini, ex comandante della Nato in Kosovo: «Si vuole imporre una secessione. Non mi scandalizzo per la realpolitik. Quello che mi dà fastidio è soltanto l'ipocrisia» Tommaso Di Francesco
Si va a tappe forzate all'Onu, dopo
che la «mediazione» dell'incaricato Martti Ahtisaari è stata sospesa
dal Consiglio di sicurezza. Gira una bozza di risoluzione che
prevede unilateralmente l'indipendenza, seppur «internazionalmente
controllata per un certo periodo». E' scontro. Washington è pronta
al riconoscimento anche se il Consiglio di sicurezza fosse bloccato
da un veto russo. Di questo parliamo con il generale Fabio Mini, ex
comandante delle forze Nato in Kosovo. «Penso che quello di
Ahtisaari - ci dice - è un tentativo fallito. La responsabilità più
grave sta nell'averlo messo nelle condizioni di gestire un negoziato
a senso unico. Così raccoglie i frutti di una manovra non tesa a
risolvere il problema di tutte le etnie kosovare, ma della ricerca
di una rottura con la Serbia anche con il ricatto».
Cessate il fuoco
22 maggio
Gli incendi della
spazzatura sprigionano composti tossici. Almeno 70 gli interventi dei
pompieri
Respinte le dimissioni di Guido Bertolaso che resta commissario straordinario per l'emergenza
Napoli, in strada 2.700
tonnellate di rifiuti
|
|
 Ordine
di sfratto. La notifica, datata 18 aprile, è arrivata
all'Unione russa dei giornalisti (Ruj) solo il 15 maggio scorso
dall'agenzia delle proprietà statali 'Rosimushchestvo': "Avete un mese
di tempo - recitava - per liberare gli uffici dove ha sede il vostro
quartier generale". Ricevuta l'intimazione a distanza di appena tre
giorni dalla scadenza, il più grande sindacato russo, che tutela oltre
centomila giornalisti, ha opposto un fermo rifiuto: "Non ci muoviamo".
La battaglia legale tra lo Stato e il sindacato è iniziata alla vigilia
della annuale conferenza della Federazione internazionale della stampa,
che si terrà il 28 maggio nella sede della Ruj sottoposta a sfratto.
Circa un migliaio di giornalisti si riuniranno per discutere della
sicurezza dei giornalisti e della 'crisi dell'impunità' per coloro
che perseguitano - e a volte uccidono - gli operatori dell'informazione
in Russia. L'ennesimo attacco contro la libertà di stampa è stato
definito dalla Ruj come un sabotaggio della conferenza, e ha ricevuto le
condanne delle principali organizzazioni che difendono il lavoro e
l'attività dei giornalisti. Il comunicato emesso dalla Ruj accusa l'ente
governativo - che possiede pacchetti azionari in tutti i settori-chiave
dell'economia russa, dal gas ai diamanti - di "gettare in mezzo a una
strada un'organizzazione che ha 90 anni di storia, che ha contribuito
alla costruzione della democrazia e che ha difeso senza compromessi gli
interessi della categoria, i diritti costituzionali e le libertà civili
della popolazione".
Ordine
di sfratto. La notifica, datata 18 aprile, è arrivata
all'Unione russa dei giornalisti (Ruj) solo il 15 maggio scorso
dall'agenzia delle proprietà statali 'Rosimushchestvo': "Avete un mese
di tempo - recitava - per liberare gli uffici dove ha sede il vostro
quartier generale". Ricevuta l'intimazione a distanza di appena tre
giorni dalla scadenza, il più grande sindacato russo, che tutela oltre
centomila giornalisti, ha opposto un fermo rifiuto: "Non ci muoviamo".
La battaglia legale tra lo Stato e il sindacato è iniziata alla vigilia
della annuale conferenza della Federazione internazionale della stampa,
che si terrà il 28 maggio nella sede della Ruj sottoposta a sfratto.
Circa un migliaio di giornalisti si riuniranno per discutere della
sicurezza dei giornalisti e della 'crisi dell'impunità' per coloro
che perseguitano - e a volte uccidono - gli operatori dell'informazione
in Russia. L'ennesimo attacco contro la libertà di stampa è stato
definito dalla Ruj come un sabotaggio della conferenza, e ha ricevuto le
condanne delle principali organizzazioni che difendono il lavoro e
l'attività dei giornalisti. Il comunicato emesso dalla Ruj accusa l'ente
governativo - che possiede pacchetti azionari in tutti i settori-chiave
dell'economia russa, dal gas ai diamanti - di "gettare in mezzo a una
strada un'organizzazione che ha 90 anni di storia, che ha contribuito
alla costruzione della democrazia e che ha difeso senza compromessi gli
interessi della categoria, i diritti costituzionali e le libertà civili
della popolazione".
 L'ombra
lunga del Cremlino. Il fatto che nessuna ragione sia stata
addotta a sostegno del provvedimento, il ridicolo periodo di tempo
concesso per lo sgombero dei locali e le voci semi-ufficiali che
vogliono all'origine dello sfratto la decisione di alloggiare nei locali
una nuova televisione (Russia Today), destinata a diffondere all'estero
un'immagine positiva della Russia, sono tutti fattori che suffragano l'opinone
corrente sul clima che giornalisti indipendenti e rappresentanti del
dissenso respirano nel Paese. Dal crollo del comunismo, i media russi
sono stati il campo di battaglia privilegiato tra Stato e soggetti
indipendenti. E' un dato di fatto che, negli ultimi 5 anni, compagnie
con stretti legami con il Cremlino abbiano acquistato media e network
(spesso con un curriculum di incontestabile obiettività), oltreché case
editrici e società tipografiche. L'ultima 'acquisizione' è quella del
magnate del metallo, il filogovernativo Alisher Usmanov, che si è
comprato il Kommersant, quotidiano economico notorio per i suoi giudizi
equilibrati e spesso elogiato per la sua posizione critica nei confronti
del governo.
L'ombra
lunga del Cremlino. Il fatto che nessuna ragione sia stata
addotta a sostegno del provvedimento, il ridicolo periodo di tempo
concesso per lo sgombero dei locali e le voci semi-ufficiali che
vogliono all'origine dello sfratto la decisione di alloggiare nei locali
una nuova televisione (Russia Today), destinata a diffondere all'estero
un'immagine positiva della Russia, sono tutti fattori che suffragano l'opinone
corrente sul clima che giornalisti indipendenti e rappresentanti del
dissenso respirano nel Paese. Dal crollo del comunismo, i media russi
sono stati il campo di battaglia privilegiato tra Stato e soggetti
indipendenti. E' un dato di fatto che, negli ultimi 5 anni, compagnie
con stretti legami con il Cremlino abbiano acquistato media e network
(spesso con un curriculum di incontestabile obiettività), oltreché case
editrici e società tipografiche. L'ultima 'acquisizione' è quella del
magnate del metallo, il filogovernativo Alisher Usmanov, che si è
comprato il Kommersant, quotidiano economico notorio per i suoi giudizi
equilibrati e spesso elogiato per la sua posizione critica nei confronti
del governo.
 Repressione
di Stato. E' dei primi di maggio il più recente rapporto sulla
libertà di stampa nel mondo. Redatto dall'organizzazione statunitense 'Freedom
House', colloca la Russia agli ultimi posti della classifica sulla
libertà di stampa (164esima su 195 Stati). Durante il mandato di Putin,
tredici giornalisti sono stati assassinati. In nessun caso mandanti o
esecutori degli omicidi sono stati assicurati alla giustizia. Il mese
scorso il presidente russo ha firmato un decreto che istituisce un nuovo
organo per la supervisione dei mass media e di internet, mentre lo
scorso anno una legge ad hoc ha reso la 'critica giornalistica'
passibile di inserimento nelle 'attività estremistiche' che la nuova
legge sanziona con misure assai drastiche. In ottemperanza al
provvedimento sono già state chiuse diverse organizzazioni non
governative, accusate di 'minacciare l'indipendenza politica della
Federazione russa'. E' il caso della Società per l'amicizia russo-cecena,
ente attivo nella tutela dei diritti umani e nelle pubblicazioni di
rapporti sulla situazione cecena, il cui direttore è stato accusato di
"fomentare l'odio etnico attraverso i media". Repressione, inettitudine
investigativa e indifferenza giudiziaria rimangono le caratteristiche
preminenti dell'atteggiamento di Putin nei confronti dei giornalisti.
Caratteristiche sublimate nell'omicidio di Anna Politkovskaya, la
principale accusatrice della politica russa in Cecenia. Per sette anni,
la giornalista ha raccontato abusi, sparizioni, corruzione, torture,
omicidi. Per sette anni è sopravvissuta a minacce, incarcerazioni, esili
forzati, avvelenamenti. Per morire nel luogo paradossalmente più sicuro
per lei: l'atrio di casa, a Mosca, colpita a morte da un sicario mentre
tornava dal fruttivendolo.
Repressione
di Stato. E' dei primi di maggio il più recente rapporto sulla
libertà di stampa nel mondo. Redatto dall'organizzazione statunitense 'Freedom
House', colloca la Russia agli ultimi posti della classifica sulla
libertà di stampa (164esima su 195 Stati). Durante il mandato di Putin,
tredici giornalisti sono stati assassinati. In nessun caso mandanti o
esecutori degli omicidi sono stati assicurati alla giustizia. Il mese
scorso il presidente russo ha firmato un decreto che istituisce un nuovo
organo per la supervisione dei mass media e di internet, mentre lo
scorso anno una legge ad hoc ha reso la 'critica giornalistica'
passibile di inserimento nelle 'attività estremistiche' che la nuova
legge sanziona con misure assai drastiche. In ottemperanza al
provvedimento sono già state chiuse diverse organizzazioni non
governative, accusate di 'minacciare l'indipendenza politica della
Federazione russa'. E' il caso della Società per l'amicizia russo-cecena,
ente attivo nella tutela dei diritti umani e nelle pubblicazioni di
rapporti sulla situazione cecena, il cui direttore è stato accusato di
"fomentare l'odio etnico attraverso i media". Repressione, inettitudine
investigativa e indifferenza giudiziaria rimangono le caratteristiche
preminenti dell'atteggiamento di Putin nei confronti dei giornalisti.
Caratteristiche sublimate nell'omicidio di Anna Politkovskaya, la
principale accusatrice della politica russa in Cecenia. Per sette anni,
la giornalista ha raccontato abusi, sparizioni, corruzione, torture,
omicidi. Per sette anni è sopravvissuta a minacce, incarcerazioni, esili
forzati, avvelenamenti. Per morire nel luogo paradossalmente più sicuro
per lei: l'atrio di casa, a Mosca, colpita a morte da un sicario mentre
tornava dal fruttivendolo.
Ancora le colonne d'Ercole
Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, era la porta d'ingresso in Europa per i migranti. La Spagna ora l'ha blindata
|
Ho comprato un rene in Nepal
Allora non è una leggenda metropolitana. La macelleria internazionale degli organi umani è una realtà concreta, prospera e diffusa. E adesso ha anche volti, nomi e indirizzi precisi, almeno in una delle sue tante incarnazioni: quella del traffico di reni che avviene tra il Nepal e l'India, i paesi più attivi dell'Asia - insieme al Pakistan - in questo oscuro mercato globale. 'L'espresso' ne ha percorso tutto il cammino, dai vicoli di Kathmandu fino alle cliniche di lusso di Calcutta, acquistando il rene di un ragazzo nepalese e prenotandone il trapianto con il consenso di un chirurgo indiano.
Al bazar dei documenti falsi
E' appunto a Kathmandu, l'ex capitale degli hippies oggi stremata da dieci anni di guerra civile e sovrappopolata da un'inurbazione selvaggia, che nel novembre del 2006 sento le prime voci sul boom locale dell'offerta di organi. Si dice che i contadini sfollati, la gente dei villaggi indebitata e le vedove senza speranza siano diventati il serbatoio di questo commercio gestito da una dozzina di 'middle men', gli intermediari tra pazienti benestanti (quasi sempre stranieri) e aspiranti venditori di organi. Nella confusione del dopoguerra in città è venuto meno il potere dello Stato, si è impennata la criminalità, è dilagata la corruzione. E all'anarchia nepalese fanno riscontro appena al di là del confine le moderne cliniche private indiane, dove molti medici (retribuiti 'a cottimo' per ogni intervento) accettano i certificati fasulli prodotti in Nepal, pur consapevoli della loro fraudolenza.
Con una matita da trucco mi appesantisco le occhiaie e vado al National Kidney Center, la più nota struttura privata locale per la cura dei reni. Qui, senza bisogno di mostrare alcunché, scopro subito che basta rivolgersi a un qualsiasi paramedico - ma va bene anche un guardiano o un barelliere - per mettere in giro la voce che si ha urgentemente bisogno di un rene nuovo, lasciando il proprio numero di cellulare e una mancia. Nessuno si stupisce, nessuno chiede alcunché, molti promettono aiuto.
Nemmeno tre giorni dopo arrivano le prime telefonate, con i nomi, i numeri e gli indirizzi di due intermediari. Così inizia il mio viaggio nella malavita di Kathmandu, riconvertita dallo spaccio di droga al più remunerativo business degli organi.
Il primo 'middle man' che mi fissa un appuntamento si chiama Krishna Kanki e ha la sua base accanto a un negozio di pashmine sulla Tridevi Marg, uno stradone pieno di mendicanti a due passi dal quartiere turistico di Thamel. Per maggiore sicurezza, vado a trovarlo accompagnato da Sudarshan, un amico nepalese il cui fratello un anno fa si è comprato un rene e che quindi ha un po' di esperienza nel giro.
Krishna che ci aspetta davanti al negozio. Ha una trentina d'anni, i baffetti curati e una polo viola. Ci fa cenno di seguirlo e - senza voltarsi - ci porta in una piazzetta appartata, la Bhagwan Bahal. Sotto un ombrellone aperto davanti a un baretto malconcio ci sono quattro sedie di legno bianco che costituiscono evidentemente il suo informale ufficio. Krishna parla solo con Sudarshan, in nepalese, a voce bassa e senza mai guardarmi. Non sembrano interessargli granché le mie condizioni di salute - a parte il gruppo sanguigno - e dopo le rassicurazioni sulla robustezza dei suoi ragazzi ci spiega la procedura successiva, a sentir lui semplicissima e rodata: "Lo sapete, per la legge indiana bisogna che tra il donatore e il paziente ci sia una relazione di consanguineità. Con i malati di qui facciamo un paio di falsi certificati e diciamo che sono fratelli. Per gli occidentali invece il sistema migliore è quello di inventarci un figlio". Un figlio? "Sì, certo. Diciamo che tu sei venuto in Nepal una ventina di anni fa e hai avuto una storia con una ragazza locale. Bene, il bambino non te lo sei portato a casa ma l'hai sempre aiutato da lontano, mandandogli soldi e vestiti. Ora lui è diventato grande, vuole sdebitarsi e ti dà il suo rene. è facile, funziona sempre. Basta costruire un documento di paternità con il timbro del ministero, che noi ovviamente sappiamo come procurarci". E la mamma chi sarebbe? "Non è un problema. Troviamo una donna più o meno della tua età che certifica la vostra vecchia relazione e garantisce la paternità del ragazzo...".
L'estrema facilità con cui il broker descrive i vari passaggi ha un che di irreale, come se fossi lì a comprare un souvenir. Tuttavia, di fronte alla sua irritante sicurezza, cerco di mostrare le paure e l'incredulità proprie del paziente occidentale timoroso che qualcosa vada storto: "Ma sono documenti credibili? E se poi in India il medico li rifiuta?". Krishna sorride appena, senza mai rivolgere lo sguardo a me: "Vedete, non importa a nessuno se sono credibili o no. Certo, noi produciamo dei falsi perfetti, ma è solo per sicurezza. In realtà in India i chirurghi sanno benissimo che è tutto fasullo e fanno solo finta di crederci". E ancora, sempre con una punta d'ironia: "A volte sono loro stessi a telefonarci per dirci che cosa dobbiamo scrivere su quei fogli, in modo da non avere problemi con i loro consigli di amministrazione o magari con qualche collega invidioso. Ricordatevi bene una cosa: se il dottore in India vi fa qualche domanda di troppo, è solo per avere un sovrapprezzo in nero sulla parcella della clinica, che pure gli dà il 50 per cento di ogni operazione. Voi passategli una buona mancia e vedrete che tutto finisce lì".
Dopo un po', Krishna sembra perfino scocciato dalle nostre ansiose domande, quasi che queste possano mettere in dubbio la sua professionalità e le sue connessioni con i medici di là del confine. E a fronte dei miei timori sulle capacità dei chirurghi indiani, il mediatore fa già, tranquillamente, il primo nome: "Io lavoro con i migliori trapiantologi del Paese. A Chennai mando la gente al St.Thomas Hospital, dal dottor Ravichandran, il capo del dipartimento di nefrologia. Bravissimo, un luminare mondiale. Mi ha già fatto diversi occidentali come te, e sono tornati tutti a casa felici e contenti".
Il tremore pauroso di Daniel Rai
Dopo una mezz'oretta di rassicurazioni e chiacchiere, inevitabilmente il discorso cade sui costi. E qui Krishna snocciola senza imbarazzi le sue parcelle: "Servono subito 160 mila rupie (circa 200 euro) per fare gli esami del sangue ad almeno due possibili donatori. Poi, se va tutto bene, il rene costa 1.800 euro: un terzo subito, un terzo appena hai fatto l'operazione, l'ultima parte dopo le dimissioni dall'ospedale". Altre spese? "Al donatore non devi dare niente, ci penso io. Semmai compragli qualche vestito per renderlo decente quando lo presenti al dottore. Il ricovero in India e tutte le medicine sono naturalmente a tuo carico. Poi calcola tre biglietti aerei per Chennai: per te, per il donatore e per il mio watchman". E chi sarebbe questo watchman? "Ci vuole sempre un mio uomo che controlli tutto. Mettiamo che al donatore salti in testa di scappare all'ultimo minuto: bene, il mio watchman è lì per impedirglielo. Questi ragazzi a volte sono strani, si prendono paura all'improvviso, è sempre meglio tenerli d'occhio...". Poi si ferma, guarda l'orologio d'oro e finalmente alza lo sguardo: "A proposito, ne volete conoscere un paio?".
Così Krishna sfodera la sua arma a sorpresa: un numero digitato in fretta al cellulare, poche frasi secche in nepalese e tre minuti dopo da dietro l'angolo si materializzano, a passi lenti e in silenzio totale, due ragazzi già reclutati. "Naturalmente prima dobbiamo verificare il gruppo sanguigno", dice il mediatore, "ma loro sarebbero già pronti".
Uno è poco più di un bambino. Ha tratti tibetani, una magrezza impressionante sotto la T shirt lurida. La gamba sinistra gli trema, non solleva lo sguardo dal tavolo. Sembra terrorizzato dalla situazione che pure ha scelto di vivere. L'altro è molto più tranquillo, ha un inizio di barba sul mento e si siede accanto al suo carnefice. Bevono una Sprite, sempre senza aprire bocca. Io li guardo in faccia, loro fissano l'asfalto sotto le loro infradito di plastica.
È lo stesso Krishna, pochi minuti dopo, a farli un po' parlare: forse ha paura che risultino antipatici al ricco cliente venuto dall'Europa. Inizia il ragazzo più piccolo, quello spaventato. Si chiama Daniel Rai e dichiara vent'anni: una palese bugia, probabilmente è minorenne. Proviene da un piccolo villaggio del Terai, l'afosa pianura lungo i confini meridionali del Nepal. Sua madre - dice - è morta quando lui aveva otto anni. Papà ha trovato un'altra donna e ha cominciato a bere, facendo debiti per l'alcol, per poi andarsene dal villaggio con la nuova compagna. Lasciando lui - primo figlio maschio - a difendersi dai creditori. Allora Rai è venuto nella capitale, ha trovato qualche lavoretto. Ma i soldi raccattati qua e là non bastano, deve tornare in fretta al villaggio per pagare gli usurai: gli interessi sono del 30 per cento l'anno. Altrimenti quelli gli prendono la casa e sbattono in strada tutti i suoi fratelli.
L'altro ragazzo, il più grande, si chiama Sonam, dice di avere 25 anni e viene dal villaggio di Kavre, sempre nel Terai. A Kathmandu fa l'aiuto meccanico, porta a casa una quarantina di euro al mese ma ora la moglie si è ammalata di cuore e "in Nepal le medicine si pagano care, senza i miei soldi muore".
Quando hanno finito, Krishna fa un mezzo sorriso ironico rivolgendosi a noi in modo complice: "Raccontano tutti storie strappalacrime, poi non lo saprai mai che cosa ci fanno davvero con i soldi. Io sono onesto, gli dò sempre metà di quello che prendo, ma quando vedono tutte quelle rupie in una botta sola non capiscono più niente. Qualcuno se le beve, qualcuno si compra la moto: una bella Hero Honda con cui tornare al villaggio a fare il gradasso. Poi sì, ci sono anche quelli bravi, che magari si comprano un campo per coltivare il riso, ma sono sì e no due su dieci. Comunque, fatti loro".
Già, fatti loro. L'importante, per me, è che siano davvero disposti a vendersi un organo. Come faccio a sapere che sono d'accordo con quello che stiamo per fare? Alle mie perplessità Krishna si volta verso i ragazzi e dice qualcosa in nepalese. Daniel risponde con un semplice cenno di sì con la testa, tenendo sempre gli occhi bassi; Sonam - forse più bravo a recitare - si dice addirittura "felice" di poter salvare la mia vita.
In tutto, il primo incontro con Krishna e i suoi ragazzi da macello dura quasi un'ora, in un'atmosfera vagamente irreale: Daniel Rai, Sudarshan e io molto tesi, Krishna e l'altro donatore tranquilli. Poi lui spedisce via i due ragazzi e ci fornisce gli ultimi dettagli: "Se ci state, datemi subito i soldi per gli esami, così li facciamo domattina. Poi preparo i documenti, in un paio di giorni sono pronti. Se è tutto okay, tra una settimana siete a Chennai e fra un mese tu torni a casa col rene nuovo". Le 160 mila rupie passano di mano in mano, Krishna le infila rapido nelle tasche dei jeans senza nemmeno contarle. Mi dà appuntamento per il giorno dopo alla Pathology Laboratory Clinic, nella zona di Kalanki, in modo che io possa verificare che i ragazzi fanno davvero i test del sangue. Poi si alza di scatto e si dilegua verso la folla di Thamel.
Non lo rivedrò più, perché la mia compravendita avverrà attraverso altri canali. Probabilmente, in questo momento, Daniel Rai avrà già venduto il suo rene a un altro paziente straniero. Sonam, chissà: l'impressione - condivisa dal mio amico Sudarshan - è che fosse solo un complice del mediatore, portato lì per far numero e darci l'apparenza di una scelta, mentre la vittima predestinata pareva comunque l'altro ragazzo.
I bambini sepolti in giardino
L'appuntamento con il secondo mediatore avviene il giorno dopo, nel pomeriggio. Hari Tamang, una cinquantina d'anni, corporatura tozza e occhiali azzurri di marca, ha un negozio di copertura - fotocopie e fax - in un vicolo sulla strada commerciale del Bagh Bazar. Dentro, una sola fotocopiatrice, un vecchio computer, una grande foto del defunto re Birendra e un tavolo di finto legno.
Hari sa perché sono lì, mi fa sedere e parla per primo, soprattutto di sé: "Qui mi conoscono tutti, sono il migliore in città. Ho avuto pazienti canadesi e tedeschi, i miei documenti sono sempre perfetti. Adesso qui in Nepal c'è il boom e si improvvisano tutti mediatori, ma non devi fidarti. Io faccio questo mestiere da dieci anni, mi sono venduto un rene anch'io e mia moglie pure". Poi indica un adolescente con un orecchino turchese cha sta ascoltando musica al desktop lì accanto: "E quello è Prakash, mio figlio: appena ha l'età, mandiamo in India anche lui".
Il suo punto di forza, racconta orgoglioso Hari, sono i rapporti con i chirurghi indiani, coltivati in due lustri di corruzione. Hari fa il nome di Ravichandran, a Chennai: lo stesso medico indicato da Krishna. Sempre a Chennai, il mediatore dice di lavorare anche con un'altra clinica privata, il Medical Madras hospital, dove il suo riferimento - dice - è "un medico famoso, Georgi Abraham". Ma nel mio caso, dice, la cosa migliore è puntare sull'Apollo Gleneagles Hospital di Calcutta dove - sostiene lui - conosce tutto il reparto di nefrologia: "Lì hanno appena fatto il trapianto a tre occidentali, giusto la settimana scorsa", spiega, "e poi in questo periodo il West Bengala è il posto migliore". Fino a pochi mesi fa, racconta, la sua base preferita era invece Madurai, nel Tamil Nadu: all'Apollo Hospital locale lavorava senza problemi con tale dottor Palani Rajan, anche lui nefrologo esperto in trapianti. Ma "ora su Madurai la polizia ha gli occhi puntati, meglio starci lontano". Perché? Hari fa una smorfia e spiega che nel Tamil Nadu - la regione indiana più colpita dallo tsunami del 2004 - negli ultimi due anni la vendita degli organi è esplosa oltre ogni misura perché la gente aveva bisogno dei soldi per ricostruirsi le case. Il mercato dei pezzi di ricambio umani ha raggiunto dimensioni tali da costringere a muoversi perfino la pigra polizia locale. Così sono partite un po' di inchieste e ora i dottori devono stare quatti. Del resto anche a Delhi - si lamenta Hari - non si lavora più bene come una volta: nel dicembre scorso a Noida, un centro industriale non lontano dalla capitale, hanno trovato gli scheletri di 15 bambini nel giardino di una casa privata e il giudice sospetta che siano stati ammazzati per estrarne i pezzi. I cadaveri erano conciati troppo male e sepolti da troppo tempo per capire se gli organi ne erano stati asportati o no. Ma intanto a Delhi i medici stanno in campana e il mercato dei reni è quasi bloccato.
Per fortuna a Calcutta, invece, continua tutto come prima.
Dopo il racconto sulle cliniche, Hari passa finalmente alla parte economica: il rene da lui costa circa 2 mila euro, metà prima e metà dopo il trapianto. Provo un po' a contrattare ma lui non si smuove ("Sorry, fixed prices", e "per un occidentale è la tariffa minima"). Interviene anche Prakash, il figlio adolescente già destinato a un prossimo espianto, che molla per un attimo il pc e si rivolge a me con impavida arroganza: "Guarda che mio papà è il migliore sulla piazza, lui fa una telefonata in India e il trapianto è già fatto...".
Alla fine Hari accetta solo una diversa distribuzione delle rate, un terzo alla volta come Krishna. E anche lui mi dà appuntamento è per il giorno dopo per conoscere i donatori e fargli fare i test del sangue.
Una mazzetta per uscire di galera
Se l'incontro con Krishna era stato pieno di silenzi e tensioni, la trattativa con Hari si è svolta invece in modo molto diretto, magari un po' rude ma senza alcuna emotività: come esige una qualsiasi transazione commerciale da concludere in fretta, per il bene di tutti.
La sera, a cena con un paio di amici nepalesi, chiedo notizie sui due mediatori incontrati in giornata e scopro che in città sono ben conosciuti. Krishna Kalki - il primo che ho incontrato - è un emergente del settore: cresciuto alla scuola di Hari, ora si è messo in proprio e sta cercando il suo spazio in un mercato in rapida crescita. Non ha mai voluto vendersi direttamente un suo rene, ma l'ha fatto fare al suo vice, Ashok, che usa anche come watchman da spedire in India.
Hari Tamang invece è un veterano, considerato davvero il numero uno a Kathmandu, con una media di dieci clienti al mese. Mille euro netti di profitto l'uno, e il calcolo di quanto si porta a casa è presto fatto. Ogni mattina i suoi uomini fanno il giro della città - ma a volte vanno anche fuori Kathmandu, nei sobborghi della vallata - a cercare nuovi ragazzi da squartare. Hari ha avuto anche i suoi problemi con la giustizia: tre anni fa ha litigato con un donatore - pare per una percentuale non pagata - e quello l'ha denunciato. Lui è finito in galera ma ne è uscito sette mesi dopo, pagando una cauzione e aggiungendo una stecca al magistrato. Quindi ha ripreso l'attività, che ora gira a pieni motori.
Il giorno dopo, al negozio, Hari dà prova di efficienza facendo arrivare in pochi minuti i tre donatori che in meno di 24 ore ha trovato per me, sulla base del mio gruppo sanguigno. Entrano nel vicolo un po' ciondolanti, uno accanto all'altro, e - richiesti dal mediatore - si presentano al loro acquirente europeo come alunni disciplinati.
Uno si chiama Dinesh, ha 24 anni e viene da Hetauda, cittadona del sud nepalese. Dice di essersi sposato a 13 anni, ora ha tre figli e con il suo stipendio di 35 euro al mese - fa l'operaio in una fabbrica di tappeti - non riesce a mantenerli.
Il secondo, Bikran, 22 anni, con un cappellino da baseball e una T-shirt di Kurt Cobain, sorseggia una Fanta e parla pochissimo: dice solo di venire dal Terai e di avere bisogno di soldi.
Il terzo, più giovane di tutti, si chiama Deepak Lama: ha un volto timido e pulito, l'aspetto apparentemente curato, anche se la maglietta che indossa è poco più di uno straccio. E nato in un villaggio del Terai, sempre nell'area di Hetauda, e spiega che la sua è una famiglia di 'sukumbashi': parola nepalese che si potrebbe tradurre come 'rifugiati', ma qui indica semplicemente quelli che non hanno nemmeno una casa di frasche e quindi dormono per strada.
Anche Deepak lavora alla fabbrica di tappeti - la stessa di Dinesh - e questo consente al mediatore di cantare le lodi della sua merce: "Sono tutt'e tre di etnia Lama, come la mia. Gente robusta, fisici sani, per questo li prendono nelle carpet factories. Credetemi, sono i donatori migliori, ve lo dico io che ho esperienza".
Poi Hari, di buon umore, esce dal negozio e ferma un taxi, per andare tutti insieme al Siddharta Hospital a fare gli esami. Io devo restare fuori, in un baretto di strada. Lui entra insieme ai i ragazzi e mezz'ora dopo si riappalesa con le ricevute in mano, per farsi restituire subito i soldi. Indica i buchi sulle braccia dei donatori, a dimostrare che i prelievi li hanno fatti davvero. Poi mi dà appuntamento nel pomeriggio - quando avrà i risultati - sempre nel negozietto di fotocopie.
Puntuale, poche ore dopo, nel vicolo sulla Bagh Bazar arriva il verdetto. Il primo, Dinesh, ha un paio di valori sballati ("Si vede che mangia male", sentenzia Hari): in un paio di mesi sarà pronto per un altro cliente, ma per adesso è fuori gioco. Di Biktan - quello che parlava poco - neanche a parlarne: "Ha i calcoli, tanto vale rimandarlo al villaggio che qui ci fa solo perdere tempo". Meno male che c'è Deepak, il ragazzino. Lui ha tutto in regola: sangue, reni, fegato, Hiv, Tbc, epatite e così via. Quindi, dice Hari, me lo posso portare via anche subito, dopo aver versato ovviamente il 30 per cento del totale pattuito, cioè quasi 700 euro.
Lì per lì resto un po' sorpreso: non pensavo che le cose si sarebbero concluse così in fretta. Portarmelo via? E dove? Per fare che? Hari sorride, quasi bonario: "Da questo momento lui è tuo figlio no? Beh, allora dovete conoscervi, familiarizzare. Portalo al mercato e rivestilo, offrigli una cena al ristorante, fallo dormire nel tuo hotel. Intanto io preparo i documenti e fra due o tre giorni andiamo tutti a Calcutta. Guarda, invece di mandarti il mio watchman per questa volta vi accompagno io in persona, così vi faccio vedere com'è tutto semplice e veloce. Però tu in cambio quando torni in Europa spargi la voce su di me, okay? Dici in giro che a Kathmandu c'è il buon Hari pronto a salvare la vita a chi ha bisogno di un trapianto...".
Poi il buon Hari allunga la mano e il rotolo di rupie che gli passo finisce subito nel cassetto del tavolo in finto legno.
Davanti al telaio 15 ore al giorno
Così, poco dopo, mi ritrovo con Deepak all'Hong Kong Bazar di Kathmandu, un mercato popolare a due passi dal palazzo reale, cercando di immaginare che cosa devo comprare al ragazzo per affrontare il viaggio a Calcutta. Lui non apre bocca e guarda le merci con gli occhi sgranati. Sudarshan lo prende, anche letteralmente, per mano. Davanti a ogni bancarella quello sorride incredulo. Io penso a uno zainetto per il viaggio e lui entusiasta sceglie un falso Diesel a 250 rupie, circa tre euro. Poi mi rendo conto che in effetti non ha niente - ma proprio niente - da metterci dentro, allora gli compriamo pantaloni, camicie, calze, mutande, spazzolino, tagliaunghie, sapone... Alla bancarella delle false Nike (quattro euro il paio), Deepak agguanta le scarpe ancora allacciate e cerca di infilarsele così. Gli spieghiamo che prima deve slacciare le stringhe e lui sorride imbarazzato: in vita sua non ha mai indossato altro che infradito di plastica. Chiudiamo lo shopping con un orologino digitale - quello con le lancette non sa leggerlo - e una cintura simil Gucci a tre euro, su cui il calzolaio deve fare tre buchi in più perché Deepak sarà anche di robusta etnia Lama, ma è pure magro da far spavento.
Nel taxi che ci porta in albergo, appena fuori città, il ragazzo si guarda intorno spaesato senza chiedere niente. Alla guest house fa una doccia ed esce dalla stanza orgoglioso dei nuovi vestiti, prima di accettare da bere - una Sprite, naturalmente - e di sedersi nel giardino del Planet Bhaktapur per iniziare quel rapporto di conoscenza tra paziente e donatore tanto auspicato da Hari.
Deepak ha lasciato il suo villaggio in autobus, a 14 anni, perché tanto lì - appunto - viveva per strada. Nella capitale ha iniziato a lavorare subito alla fabbrica di tappeti ed è quello che fa ancora adesso che di anni ne ha 19 - o almeno così dice lui, chissà se è davvero maggiorenne. Attacca al telaio alle cinque del mattino, alle 10 fa una pausa di un'ora per mangiare, poi riprende e va avanti fino alle otto di sera, con un'altra mezz'ora di pausa nel pomeriggio. Questo sei giorni a settimana, dalla domenica al venerdì. Il sabato gran vita: si lavora solo dalle cinque alle dieci, poi la giornata è libera per bighellonare in giro con gli amici. Guadagna poco più di 3 mila rupie nepalesi al mese (35 euro) ma in tasca gliene resta poco più di metà, perchè 1.300 sono detratte dal padrone della fabbrica in cambio del vitto (riso e lenticchie) e dell'alloggio (una camera senza bagno divisa con altri tre). Con le rupie che gli avanzano, Deepak compra qualcosa in più da mangiare o da bere e parla con i suoi una volta al mese: da un apparecchio pubblico chiama un conoscente al villaggio, quello va a chiamargli la mamma e dopo dieci minuti Deepak ritelefona. Ovviamente ha una nostalgia struggente ("Non torno a casa da tre anni") ma pensa che non lascerà più Kathmandu: "Con i soldi del rene apro un negozietto qui, di quelli che vendono sigarette sfuse, saponi, shampoo, cose così. Mi basta un metro quadro, non chiedo di più, pur di non stare tutto il giorno davanti al telaio. Se poi mi avanza qualcosa lo mando alla mamma e ai miei fratellini, che almeno si costruiscano una baracca di legno e non dormano più o davanti al tempio".
Nei due giorni successivi - mentre Deepak resta in albergo a guardare la tv - Hari prepara come promesso i documenti in cui il donatore si dichiara mio figlio e un'ignota signora locale assicura di essere sua madre confermando la mia paternità. Il primo foglio che arriva - pur con tutti i timbri ministeriali - è francamente imbarazzante per gli errori di grammatica e sintassi inglese. Ne parlo con Sudarshan e lui ci ride su: "Beh, meglio se ci sono un po' di strafalcioni: i documenti del governo nepalese sono tutti così. E poi si sa che gli indiani ci considerano degli analfabeti, se vedono un documento di qui scritto in un buon inglese pensano che sia falso...". Alla fine, tuttavia, conveniamo che forse gli svarioni sono un po' troppi (il mio anno di nascita, '62, si è trasformato nell'età, 62 anni; la parola 'son', figlio, è stata confusa con 'husband', marito... ) e quindi chiediamo a Hari una nuova edizione, appena più corretta, che arriva il giorno dopo con gli stessi timbri e la stessa carta intestata. Forse un po' piccato per essere stato bocciato al suo primo tentativo, il broker ci aggiunge due differenti versioni del documento sulla falsa madre, con altrettante foto di donne che avrei frequentato alla fine degli anni Ottanta. In entrambe le varianti, le signore confermano che il ragazzo è nostro figlio e si dicono d'accordo con la sua decisione di donarmi un rene. Alla fine scegliamo il certificato firmato da tale Seti Maya, forse la più credibile in termini di somiglianza con il mio donatore.
Chi sono? Un benefattore dell'umanità
A Calcutta, con Hari e Deepak, viene anche il mio amico Sudarshan: formalmente per aiutarmi durante il ricovero, di fatto per gestire una situazione che a quel punto è un po' più delicata. Per giustificare la mia condizione di malato - sia con Hari sia con i medici - so che devo dare segni di frequente stanchezza: in fondo dovrei essere già in dialisi, e se non l'ho ancora iniziata è solo perché voglio tornare dall'Asia con il mio rene nuovo. Cammino sempre con lentezza e mi siedo appena posso, ma la recita è più difficile passando tutto il tempo con un intermediario abituato a frequentare pazienti veri. La sera, dovendo far cena tutti insieme, mi attengo alla dieta di un malato di reni: solo acqua, poche verdure e riso bianco. Probabilmente è tutto superfluo, perché Hari non sembra avere il minimo sospetto e anzi si lascia andare a racconti orgogliosi sul suo lavoro: "Non capisco perché questa cosa sia vietata, è una vergogna", dice. Poi indica Deepak: "Se lui ha bisogno di soldi e tu di un rene nuovo, perché non potete combinare? Mah!". Poi, arrivato al dolce, tira fuori di tasca la foto di un monaco buddista di nemmeno vent'anni: "Guarda, è il mio prossimo paziente. Per lo Stato potrebbe morire, io lo porto qui in India e lui campa un altro mezzo secolo. Dimmi tu perché deve essere vietato!". E ancora: "La verità è che io non lavoro per soldi, lavoro per fare felice la gente. Guarda com'è contento Deepak, e pensa come sarai felice tu quanto sarai tornato in Italia e invece di quel riso bianco potrai mangiarti una bella pizza!". Infine ritorna pragmatico: "Però quando torni a casa ricordati di parlare di me ai tuoi amici. Chissà quanti ne hai conosciuti di malati di reni, in ospedale...".
Il giorno dopo, venerdì, arriva finalmente il momento dell'incontro con il chirurgo. Hari esce dall'hotel il mattino presto e prende il taxi per andare all'ospedale - l'Apollo Gleneagles - e incontrare il medico prima di me, in modo che poi tutto fili liscio. Mi spiega che il suo referente abituale, il dottor Mishra, quel giorno non può vederci: è a un congresso o qualcosa di simile. Però c'è il suo vice, tale dottor M. H. Raibagi: "Non ti preoccupare, conosco bene anche lui ed è un ottimo chirurgo". Dopo un paio d'ore arriva la telefonata: tutto a posto, possiamo andare.
Apollo Hospital, stanza numero 25
Attraversando l'insopportabile caldo umido di Calcutta, arriviamo all'Apollo Gleneagles, un grande complesso moderno in cemento, a pochi metri dalle 'bustees' della periferia in cellophane e bambù. Hari resta fuori con Deepak ("Se il dottore vuole vedere subito il donatore, chiamatemi al cellulare o venite a qui a prenderlo, ma per adesso è meglio che noi stiamo qui"). Io dunque entro solo con Sudarshan.
è a pian terreno, reparto di nefrologia, stanza numero 25, che il dottor Raibagi riceve i clienti. è un uomo di mezza età, in camice bianco e cravatta, con un inglese fluente e un sorriso mellifluo. Gli spiego brevemente la mia situazione, fingendo di non sapere che ha già parlato con Hari. Gli racconto della mia malattia e della dialisi che non voglio affrontare perché "in Italia ho una vita brillante, un lavoro nel marketing che mi impegna tutto il giorno, sono sempre tra taxi, aerei e riunioni, non posso stare per ore attaccato a una macchina sennò mi rovino la carriera". Lui conviene con me ("Eh sì, la dialisi è molto noiosa..."), non chiede niente di più e pensa solo a vendere bene il suo prodotto: "La nostra media di successo, nel trapianto dei reni, sfiora il 99 per cento. Abbiamo i migliori farmaci antirigetto, stanze private con aria condizionata e un secondo letto per l'accompagnatore". Quanto ai tempi, non sono un problema: "Naturalmente dobbiamo ripetere gli esami, a lei e al donatore, ma in tre o quattro giorni si conclude tutto. Poi lei si fa solo una settimana di dialisi, qui da noi, ed è pronto per il trapianto. Quindici-venti giorni di convalescenza e può tornare a casa con il suo rene nuovo". I costi? Il dottor Raibagi non ha falsi pudori: "Tra operazione, test clinici e ricovero siamo attorno ai 5 mila euro, tutto compreso. Deve aggiungere soltanto i soldi per le medicine, che gli ospedali indiani non passano...".
Dopodiché, finalmente, il chirurgo chiede di vedere i documenti: le mie analisi del sangue - quelle truccate al computer prima di partire dall'Italia - e i certificati falsi del donatore. Prende in mano i fogli preparati da Hari e li guarda per pochi secondi. Solleva gli occhi rassicurante: "Tutto okay, possiamo ricoverarla anche lunedì". Poi sospira: "Certo, se questo ragazzo fosse veramente suo figlio, le possibilità di successo sarebbero del 100 per cento...". A questo punto sono io a provocarlo: "E se invece non lo fosse, mio figlio?". Raibagi mi guarda: "Beh, in questo caso dovrò prescriverle una terapia antirigetto un po' più potente, ma vedrà che andrà bene lo stesso". Per lui, l'ipotesi che Deepak non sia mio consanguineo costituisce solo un ostacolo tecnico, non certo un impedimento etico o legale.
Sbalordito dall'assurda facilità con cui il tutto sta avvenendo, provo a immaginare qualche possibile ostacolo: "Ma che cosa succede se il rene di Deepak non risulta compatibile? C'è qualcuno che può aiutarmi a trovarne un altro qui?". Il dottore sorride ancora: "Affronteremo la questione solo al momento, ma vedrà che non ce ne sarà bisogno. Comunque ci arrangeremo ('Anyhow we'll manage it')".
Alla fine del colloquio, il dottor Raibagi si offre anche di visitarmi subito, sul lettino. Lo ringrazio ma declino accampando stanchezza, caldo, una gran voglia di tornare subito in albergo. La cosa non gli sembra strana: "Allora venga lunedì, quando vuole. Basta che bussi alla mia porta, senza fare la coda. Iniziamo subito le analisi e poi la ricoveriamo. Vedrà, andrà tutto benissimo...".
Sudarshan e io usciamo dall'ospedale un po' frastornati. Hari non c'è, ma ha lasciato detto di aspettarlo: è andato "un attimo a salutare un altro dottore", cioè probabilmente a corromperlo. Deepak beve una spremuta di canna da zucchero sotto il sole. Se fossi davvero un malato, nel giro di dieci giorni il suo rene sarebbe nel mio corpo. Invece è arrivato il momento di chiudere tutto.
Lascio a Sudarshan un po' di soldi per Deepak, poi salgo su un taxi e sparisco nel torrido caos di Calcutta.
Polizze milionarie nella
Sanità
in Sicilia lo sponsor di partito
Da Micciché a
Lombardo, da Mannino al fratello di Cuffaro, molte società di brokeraggio
hanno rapporti con la politica
Grandi società multinazionali regolarmente perdono contro le piccole. E
spesso a nulla valgono i loro ricorsi al Tar
di ANTONELLO CAPORALE

PALERMO - Se un pappagallo urta il becco contro una barella al pronto soccorso o un cane inciampa tra i corridoi della chirurgia generale dov'è ricoverato il suo padrone, un asino collassa avanti l'ambulatorio oculistico, un cavallo viene investito nel parcheggio del policlinico, il costo delle cure è garantito e, soprattutto, assicurato. Traumi, invalidità permanente o anche morte del povero animale.
A Messina il massimale per cani e gatti e ogni altra specie dell'universo è fissato a 5 milioni e 164mila euro, l'Università di Bari, meno previdente, si è coperta da polizza fino a tre milioni, l'ospedale di Enna per due milioni e 500 mila, idem il Civico di Palermo. "Nemmeno se porti in sala operatoria la renna di Babbo Natale e te la mangi con tutti i sonagli è giustificata una simile cifra", dice Pier Carmelo Russo, oggi dirigente della Regione Sicilia, ma ieri avvocato che provò innanzi al Tar come l'Azienda sanitaria trapanese Sant'Antonio Abate avesse assicurato l'ospedale con tutto quel che conteneva (medici, infermieri, beni strumentali e anche animali) per una superpolizza dall'esorbitante costo di un milione 176mila euro. Provò che era carissima, e soprattutto inutilmente dispendiosa. Massimali altissimi, premi alle stelle. Il Tar (sentenza 3034/05) annullò il contratto.
L'ospedale, limando e ripulendo, rifece la gara per trovare una congrua assicurazione e spese 676mila euro, quasi la metà, per di più sestuplicando nella polizza il valore dei risarcimenti a cui si obbligava la compagnia assicuratrice rispetto alla precedente.
Nel bilancio dello Stato somme importanti sono destinate a coprire la cosiddetta responsabilità civile delle migliaia di dipendenti, e poi la sicurezza di edifici e palazzi, scuole e consultori, acquedotti e strade. Ma il vero salasso per le casse pubbliche è la cifra che le aziende ospedaliere devono mettere da parte nei bilanci per assicurare i dipendenti, cioè i medici, per responsabilità connesse al proprio lavoro. Un intervento chirurgico che non va bene, l'artroscopia fatta male, il bypass difettoso. Gli incidenti purtroppo sono molti, le richieste di risarcimento altrettanto numerose, gli indennizzi certi ed elevati.
Una fortuna! Per alcuni più incidenti uguale più premi. Più premi uguale più soldi. Ecco, le polizze costano care. Anche perché si assicura tutto oltre limite estremo della ragione. Il chirurgo è naturalmente coperto da polizza ma anche il ferrista di sala operatoria. Ed è giusto. Oltre al ferrista la caposala, l'infermiere, professionale e generico. Ed è giusto. Ma gli stessi massimali valgono per il portantino e giù giù fino al cuoco, allo sguattero da cucina e, appunto, al pappagallo. Cinque milioni di euro di premio massimo se dovesse all'animaluccio occorrere qualcosa. Polizze fantascientifiche che solo un matto potrebbe stipulare. Ma qui paga lo Stato.
Alcuni nosocomi sottoscrivono impegni con le assicurazioni in cui il limite che esclude la compagnia dall'obbligo di pagare è posto a livelli incredibili: a Palermo l'ospedale, benché assicurato, si ritiene direttamente coinvolto (quindi paga di tasca sua) danni fino a cinquecentomila euro. Prima che l'assicurazione si ritenga coinvolta bisogna giungere alla soglia lunare del mezzo milione di euro. Fosse finita qui! In tutte le polizze c'è la clausola del limite temporale del risarcimento postumo. Altra fregatura. Mettiamo una semplice operazione al ginocchio fatta oggi. Il malato va a casa, dopo qualche settimana i dolori post-operatori non cessano, decide di indagare e dopo qualche mese si fa rioperare accorgendosi che la prima operazione è stata condotta male. Chiede i danni all'ortopedico per colpa professionale. L'ortopedico è coperto dall'assicurazione stipulata dal suo ospedale.
Ma l'assicurazione che ha intascato il premio rifiuta il pagamento perché la richiesta è stata inoltrata fuori tempo massimo. Alcune compagnie fissano a tre mesi, altre a sei mesi, altre a un anno il limite temporale della loro copertura postcontratto. E dunque? E dunque, e ancora una volta, l'ospedale pagherà con i suoi soldi ciò che ha già pagato. La polizza è morta, è vuota. Pagata. E pagata quanto?
Bella domanda. La sanità italiana è così malmessa che le maggiori compagnie non vogliono correre rischi e si tengono alla larga dal rispondere alle richieste. Trovare una assicurazione è un'impresa, purtroppo.
Rispondono i Lloyds di Londra, o piccole compagnie estere, leggere ma audaci. In Sicilia la parte del leone la fa l'australiana Qbe, un solo ufficio italiano e tutto il resto in Oceania e a Londra.
Per raggiungere la Qbe gli ospedali, come tutti gli enti pubblici e anche i grandi gruppi privati italiani, si fanno aiutare da un broker. E chi è il broker? Un professionista che, valutata la mappa del rischio dell'azienda cui presta la sua consulenza, va sul mercato delle assicurazioni e prende quel che gli serve: le migliori polizze teoricamente al minor costo. Il broker dunque gestisce (dovrebbe gestire) la qualità del rischio e il suo mantenimento al livello più basso. Se è bravo e onesto e il suo cliente, per esempio un municipio, è oggetto di ripetute richieste risarcitorie per incidenti stradali che percentualmente sono concentrati a un incrocio, chiederà tempestivamente che il bivio venga messo in sicurezza (ad esempio con una rotatoria). La riduzione del rischio provocherà la riduzione del premio che l'assicurazione riterrà di pretendere. Questo se il broker è serio.
Il broker però guadagna in percentuale sul premio pagato dal cliente: più è alto il costo dell'assicurazione più la provvigione (che varia dal 3 all'8 per cento) risulta elevata. E il broker per lavorare deve superare una gara pubblica indetta dalla Asl. E dunque? Avete pensato bene: una conoscenza è meglio di niente, due è meglio di una. La politica da poco ha scoperto questo nuovo mercato. E se lo coccola. In Sicilia (come in tutto il Paese) le società di brokeraggio si fanno una guerra spietata per raccogliere incarichi, vincere gare, intercettare commesse sempre più sontuose.
Grandi società multinazionali di brokeraggio (Aon e Marsh) e medie (Sgr, Viras), piccole (consulbrokers), piccolissime (Assisicilia). A Palermo, a Catania, a Trapani, a Mazara le grandi perdono sistematicamente, le piccole e piccolissime vincono quasi sistematicamente. Migliore offerta, miglior progetto operativo, miglior punteggio. A Catania (Ausl 3) il progetto Marsh-Aon viene giudicato migliore ma gli viene assegnato lo stesso punteggio di Consulbrokers. Ricorso al Tar, annullamento della gara. L'Asl invece di modificare i punteggi, modifica i giudizi: chi aveva vinto invece di perdere rivince grazie a un giudizio che da buono raggiunge l'ottimo.
Intendiamoci, nulla di male e solo una coincidenza se per esempio la Sgr, società di brokeraggio, custodisce una limpida amicizia con Silvio Cuffaro, fratello di Totò, il governatore. E nulla di male se i titolari di Consulbrokers si ritengono, o sono ritenuti, amici di Raffaele Lombardo, padrone di Catania. Se la Viras è molto stimata dall'ex assessore alla Sanità Sanzarello, la Sicurmed da Lillo Mannino, la Reale Mutua da Micciché. Sono aziende. Ognuna ha diritto di sostenere il partito del cuore e, nei limiti consentiti dalla legge, anche di finanziarlo. Lo fanno i migliori imprenditori che in Parlamento depositano le cifre dei loro bonifici.
L'assicurazione, poi, è un obbligo di legge. E, come si dice?, una buona polizza allunga la vita.
Denunciate anche due persone con redditi da mezzo milione di euro
Finti poveri per truffare
la sanità
Intero paese nel mirino della Gdf
Già a dicembre dello scorso anno erano state scoperte altre 310 false dichiarazioni

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le persone denunciate sarebbero riuscite ad ottenere, grazie a false autocertificazioni, l'esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e per l'acquisto di medicinali, senza averne diritto. L'ipotesi di reato che viene loro contestata è di truffa e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Le indagini hanno preso il via da alcune anomalie riscontrate dalla verifica dei redditi dichiarati da alcune delle persone coinvolte nella maxi-inchiesta. Il limite per godere dell'esenzione del ticket sanitario è di 12 mila euro l'anno ma i denunciati dichiaravano di guadagnare una cifra inferiore. Rischiano una condanna da 3 mesi a tre anni di carcere.
18 maggio
Francia modello da seguire
di VINCENZO
BORGOMEO

Voti alla sicurezza stradale: li dà l'European Transport Safety Council, sostenuto da tutti i governi del Vecchio Continente. E l'Italia è dietro la lavagna con il con il cappello da asino: siamo sopra la media della mortalità europea (di circa il 13 per cento, circa 900 morti in più sulla media e 2700 in più rispetto ai migliori della classe). Ma non è tutto: da noi le due ruote valgono solo il 3,6 per cento della mobilità ma incidono per il 26% sulla mortalità generale da incidenti stradali. Il che significa che i morti " da due ruote" sono in continuo aumento e che l'Italia ha il maggior numero di vittime di Europa.
Insomma un quadro disastroso, reso ancora più preoccupante per il fatto che abbiamo le città più pericolose fra tutte quelle del vecchio continente.
In città fra l'altri aumentano incidenti, morti e feriti, mentre su tutte le altre strade diminuiscono (qui avvengono il 45% dei morti e il 79% dei feriti totali). In più c'è un incredibile divario fra la situazione delle varie città (chi riduce la mortalità del 30% e chi la aumenta del 40%). E nessuno sa perché questo accada.
L'ETSC è indubbiamente severo, ma sono numeri, statistiche, impossibile da contestare. Il tutto è contenuto nel famoso Safety Performance index, che prende in considerazione due parametri principali: l'utilizzo delle cinture di sicurezza e la riduzione del numero di vittime. La Francia è al primo posto, noi complessivamente siamo al 14esimo posto di una classifica fatta da 27 paesi realizzata su statistiche 2002-2005. Ma c'è poco da gioire perché come abbiamo visto prima abbiamo record davvero poco invidiabili.
Ma come si arriva al record francese? "Innanzitutto da un forte impegno del governo - spiegano all'ETSC - perché Chirac ha posto la sicurezza stradale fra gli obiettivi primari del suo mandato, e questo è stato adottato soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità. In Francia oggi hanno 2000 telecamere fisse che fanno qualcosa come 30 mila verbali al giorno...
Molto importante, sempre secondo l'ETCS, poi il controllo degli incidenti che riguarda la guida in stato di ebbrezza. I dati vanno dal 1996 al 2005 e qui i Paesi che hanno fatto registrare la diminuzione più grande del numero di morti per guida in stato di ebbrezza sono Repubblica Ceca (meno 12,5%), e poi seguono Germania, Olanda e Polonia. Il trend di riduzione è importantissimo perché alla fine incide enormemente sul trend complessivo. Ma ci sono poi anche paesi come Spagna, Ungheria, Slovenia, Finlandia e Gran Bretagna che hanno invece avuto un aumento di vittima. E L'Italia? Mon si sa: da noi non è stato possibile registrare nulla. Il problema è enorme, e non a caso scorrendo le statistiche europee i nostri dati sono sempre i più carenti, i meno aggiornati e i più vecchi. Sulle tabelle accanto alla voce Italia c'è sempre un asterisco, così diventa davvero molto difficile poi fare qualsiasi tipo di stima e di investimento sul futuro.
In tutti i casi è in arrivo un disegno di legge per alcune azioni molto urgenti, c'è il progetto del nuovo Codice della Strada, e il Ministero è al lavoro per cercare di ridurre in tutti i modi incidenti e numeri di morti. Ma la strada appare onestamente completamente in salita.
Molto possono comunque fare le stesse case automobilistiche perché alla fine, poi, in una situazione di carenza legislativa, di strade dissestate e segnaletica improbabile, una macchina piena di tecnologia aiuta a salvarsi la pelle. Massimo Nordio, ad Toyota Motor Italia che a livello europeo sostiene il progetto ETSC è stato chiaro: "Watanabe, il nostro presidente, ha un sogno, quello di potere arrivare ad avere una macchina che più la usi e più migliora l'ambiente, e con faccia zero vittime. Quindi salvaguardia dell'ambiente, ma anche salvaguardia totale delle persone.
Va detto - continua poi Nordio - che poi il nostro impegno può arrivare fino a un certo punto, perché poi la sicurezza stradale riguarda tutti, dalle autorità ai costruttori passando per ogni singolo automobilista. Per questo è fondamentale lavorare insieme. Aziende, strutture e istituzioni e consumatori". E torniamo al tema del dibattito di oggi.
E proprio alla Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale istituita nel 2001 proprio per dare in coordinamento generale ai 21 governi regionali e agli oltre 8000 comuni e, soprattutto, per incentivare con importanti finanziamenti progetti vari. Fino a oggi ci sono stati realizzati 4 programmi nazionali, 42 regionali e 1.122 interventi specifici. "Ma ogni volta che abbiamo dato un euro - spiegano alla Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale - lo abbiamo fatto a fronte di un impegno: avere una scheda che ci spiega i risultati della spesa".
A proposito di trasparenza, però non tutto funziona: "Nel nostro stato diritto abbiamo la possibilità di tutelare la vita di ognuno di noi" spiega Cassaniti Mastrojani dell'Associazione Vittime della Strada "e secondo noi dobbiamo tener conto anche delle responsabilità sociali, oltre che strade, veicolo e conducente. Ossia quelle folli libertà che si prendono le istituzioni di fare un lavoro sbagliato senza che venga mai sanzionato da nessuno. La società - continua ancora Cassaniti Mastrojani - deve rispondere alla salvaguardia dei cittadini, che devono essere ascoltati dalle istituzioni. Le mancate risposte che i cittadini hanno sono la cartina di tornasole del nostro livello di democrazia".
Cessate il fuoco
Il bollettino settimanale delle guerre e dei conflitti in corso n.20 -
2007 dal 10 al 16/5
Questa settimana, in tutti i paesi ancora in guerra, sono morte almeno 1.203 persone
Colombia
Questa settimana sono morte almeno 19 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 159.
Questa settimana sono morte almeno 17 persone.
Questa settimana sono morte almeno 96 persone.
17 maggio
Centro sinistra in Sicilia
UNA VITTORIA RETROATTIVA
di Agostino Spataro
Come il solito, più che il voto il vero rompicapo è il dopovoto. Almeno per la gente che cerca di capire cosa sia effettivamente successo a Palermo e in Sicilia a seguito delle votazioni del 13-14 maggio.
Stiamo assistendo alla solita pantomima: tutti vincitori e nessun vinto. Soprattutto, nel centro sinistra, invece d’interrogarsi sui motivi di questa ennesima sconfitta, ci si arrampica sugli specchi per dimostrare che si è vinto, se non proprio nel recente confronto, almeno rispetto a quelli precedenti. Vittorie dal sapore retroattivo, meramente consolatorie, che non modificano di un millimetro l’amara verità uscita dalle urne.
Se qualcuno ammette la sconfitta ne addossa la colpa ad altri, all’avversario che ha imbrogliato le carte o, addirittura, all’elettorato che non ha capito il “messaggio” (quale?).
C’è, addirittura, chi ha chiamato in causa le recenti dichiarazioni di Padoa Schioppa su pensioni e concertazione, forse, senza accorgersi che, così facendo, si accredita la tesi degli esponenti del centro destra che vorrebbero far discendere dalle scelte e dagli indirizzi del governo Prodi tutti i guai della Sicilia e perciò affidano al voto isolano (in gran parte scontato a loro favore) una funzione destabilizzante del governo, senza, nemmeno, attendere lo svolgimento della più impegnativa tornata del 27 maggio che vedrà alle urne circa 10 milioni di elettori nel resto del Paese. Ai quali bisogna aggiungere quelli di una ventina di medi centri siciliani che ri-andranno a votare per i ballottaggi. Fra questi, molto atteso è l’esito dell’interessante tentativo, largamente premiato al primo turno, del giovane Zambuto, ex segretario provinciale dell’Udc di Cuffaro, che nella città di Agrigento si è messo alla testa di una “rivolta” contro il predominio di certi poteri forti, politici e d’altra natura.
Ma torniamo ai risultati del 14 maggio ancora sommersi dentro il tourbillon di un’acqua resa torbida da analisi frettolose, parziali e, talora, molto propagandistiche.
Quando l’acqua si schiarirà gli esponenti della Cdl s’accorgeranno dell’erosione subita dal loro blocco elettorale a Palermo e altrove e quelli del centro sinistra, forse, la smetteranno di eludere le vere cause della sconfitta e di propinarci improbabili concause sulle quali s’illudono di costruire un nuovo alibi per tirare a campare per un altro lustro.
Anche Leoluca Orlando, che a Palermo ha fatto una battaglia generosa e conseguito un risultato davvero ragguardevole, si potrà convincere che, certo, vi saranno stati brogli, pressioni illecite e perfino compravendite di voti, ma l’incidenza di tali fenomeni non può esser stata tale da determinare un risultato così netto a favore della CdL.
Poiché se questa è la logica, bisognerebbe domandarsi: cosa sarà mai successo d’illecito a Trapani e nella rossa Ragusa dove la CdL ha conseguito una vittoria ancor più pesante?
L’inadeguatezza del centrosinistra siciliano: una grande questione nazionale
La verità, i fondo, è quella uscita dalle urne e da questa bisogna partire per fare, finalmente, il punto sulla realtà e sulle prospettive del centro sinistra nell’Isola, poiché se il voto siciliano non chiama in causa Prodi chiama sicuramente in causa partiti e dirigenti del centro-sinistra, i quali dovrebbero decidersi ad affrontare questa debolezza, ormai, strutturale come questione prioritaria e decisiva per la prospettiva politica ed elettorale nazionale.
Si facciano, dunque, i necessari ricorsi presso le sedi competenti, ma in sede politica si apra una riflessione severa e puntuale, una grande discussione democratica per individuare idee e proposte mobilitanti per un’alternativa che si può conseguire solo mediante atti di rottura col sistema di potere dominante in Sicilia, e a Palermo in particolare, che solo nuovi gruppi dirigenti, animati da sincero spirito di cambiamento, possono realizzare.
Se ci fate caso, è dai tempi di Mattarella, di De Pasquale, La Torre che non si riflette su una prospettiva di questo tipo. Un quarto di secolo, durante il quale sono cambiate tante cose e poteri ibridi si sono insediati nei gangli vitali della Regione e degli enti locali.
Durante questo tempo, il centro sinistra, la sinistra comunque aggettivata, hanno vissuto di rendita e dilapidato il patrimonio elettorale ereditato che, oggi, dovrebbe attestarsi almeno intorno al 40%, mentre in molti comuni non supera il 10%.
Insomma, mentre nel mondo, in Europa e in Italia tutto cambiava, qui tutto languiva nel pantano di un trasversalismo mirato a tenere la Sicilia fuori del cambiamento.
In queste condizioni, la sinistra ha preferito avvitarsi su se stessa, ripiegare sull’autoreferenzialità dei suoi gruppi dirigenti, dismettendo pratiche e concezioni che, nel passato, avevano prodotto un ruolo dirompente sul fronte sociale e politico e anche interessanti esiti elettorali.
Il trionfo del comunista Crocetta insegna che l’esser di sinistra paga, quando ben si governa
Questa situazione ha generato una ben strana (per non dire comoda) teoria secondo la quale l’esser di sinistra restringe l’area del consenso, perciò meglio affidarsi in certe competizioni a nomi prestigiosi della cosiddetta “società civile”. Da qui è invalsa una pratica discutibile, un’incomprensibile dicotomia di comportamenti nella scelta delle candidature: affidarsi a candidati indipendenti o provenienti da altre militanze per la conquista della presidenza della Regione, di molte province e dei municipi delle grandi città siciliane, mentre così non è stato in occasione di elezioni regionali e nazionali nelle cui liste si sono sempre ben piazzati soltanto dirigenti di partito, anche con svariate legislature.
Tale comportamento ha fatto sì che, per i sindaci delle grandi città o per la presidenza della Regione, mai un esponente blasonato della sinistra si è misurato con i candidati della CdL.
Per averne conferma, basta guardare le candidature nelle più recenti consultazioni: a Palermo Orlando, a Catania Bianco, a Messina Genovese, a Trapani Boscaino, ad Agrigento Zambuto; così alla Regione: prima Orlando e poi la Borsellino.
Eppure questa stessa sinistra ha espresso ed esprime posizione di prestigio, parlamentare e di governo, ai livelli regionale e nazionale.
E non regge l’argomento che l’essere di sinistra restringa l’area del consenso. A Gela, si dimostra il contrario: il comunista Rosario Crocetta, è stato riconfermato sindaco col 65% dei voti.
Parliamoci chiaro: quello di Gela non è solo un risultato in controtendenza rispetto alla vittoria generalizzata della CdL, ma lo è anche rispetto a un certo modo di fare politica e di governare del centrosinistra in Sicilia.
Anche a Gela imperversano mafia, pizzo, disoccupazione, precari e quant’altro eppure il risultato è venuto senza bisogno di sporcarsi le mani, anzi all’insegna della buona amministrazione e della legalità.
16 maggio
Segreto di Stato: a Genova ci fu un disegno repressivo, prima condanna per la Polizia al G8 del 2001
La censura da parte dei media è stata
rigida ed assoluta: della sentenza di Genova non si doveva parlare.
Infatti incredibilmente non ne ha scritto neanche il Manifesto e
dovrebbe spiegare perché.
Alzi la mano chi ha saputo che la settimana scorsa a Genova c'è
stata la prima condanna per i pestaggi della Polizia durante
il G8 del 2001. Eppure la sentenza di Genova è un passaggio capitale
per la ricostruzione della verità e la giustizia di quello che
successe nel capoluogo ligure oramai 6 anni fa. E ci spiega anche
molto del disegno politico sotteso alla repressione.
Lo Stato è stato condannato a risarcire Marina Spaccini, 50 anni,
pediatra triestina, volontaria per quattro anni in Africa, per il
pestaggio che subì da parte della Polizia in via Assarotti, nel
pomeriggio del 20 luglio 2001. Marina, come decine di migliaia di
militanti cattolici della Rete
Lilliput, era seduta, con le mani alzate dipinte di bianco, gridando
"non violenza", quando fu massacrata dalla Polizia. Questa si è
difesa sostenendo (sic!) che non era possibile distinguere tra le
mani dipinte di bianco di Marina e i Black Block. Per il giudice
Angela Latella invece la selvaggia repressione genovese -e la
cortina di menzogne sollevata per coprirle- è stata una delle pagine
più nere di tutta la storia della Polizia di Stato e per la prima
volta ciò viene scritto in
una sentenza. Non solo, è ben più grave quello che è scritto nella
sentenza genovese. Quelle dei poliziotti non furono né iniziative
isolate né eccessi, ma facevano parte di un disegno criminale.
Si inizia a confermare in via processuale quello che chi scrive
sostiene e scrive da sei anni. A Genova vi fu un disegno criminale
selettivo da parte di apparati dello stato. Tale disegno era teso a
terrorizzare non tanto la sinistra radicale ma il pacifismo
cattolico, in particolare la Rete Lilliput, che per la prima volta
in maniera così convinta e numerosa scendeva in piazza saldandosi in
un unico enorme fronte antineoliberale con la sinistra.
Le ragazze e i ragazzi delle parrocchie furono quelli che pagarono
il prezzo più alto, soprattutto sabato. I loro spezzoni di corteo
furono sistematicamente bersagliati dai lacrimogeni e centinaia di
loro furono pestati selvaggiamente. Ma,
soprattutto decine di migliaia di loro, e le loro famiglie, furono
spaventati a morte in una logica pienamente terroristica. Quanti
dopo Genova sono rimasti a casa?
Di fronte all'immagine sorda data dai grandi della terra, Bush,
Blair, Berlusconi, quel movimento pacifico, colorato, credibile,
fatto di persone serie e non dei pescecani rinchiusi nella città
proibita, che si era riunito intorno alle
proposte concrete per un nuovo mondo possibile del Genoa Social
Forum, doveva essere schiacciato. Non lo sapevamo, ma mancavano 50
giorni all' 11 settembre.
L'articolo di
Massimo Calandri è apparso SOLO sulle pagine genovesi di Repubblica
lo scorso 29
aprile.
Prima condanna per le violenze delle forze dell'ordine contro
i manifestanti: "Non furono iniziative isolate"
G8, condannato il Ministero - Missionaria picchiata, risarciti
invalidità e danni morali
"Ho solo ottenuto quello che attendevo da 6 anni: giustizia"
MASSIMO CALANDRI
LA PRIMA condanna nei confronti del Ministero dell'Interno per le
illecite e gratuite violenze dei suoi poliziotti è arrivata nei
giorni scorsi, e cioè circa sei anni dopo la vergogna del G8
genovese.
Ma le parole con cui il giudice istruttore Angela Latella ha
motivato la sua decisione rinfrescano la memoria.
Ricordando a tutti che quelle cariche sanguinarie,quelle teste rotte
a manganellate, quei lacrimogeni sparati contro le persone inermi,
non erano frutto dell'iniziativa isolata o dell'autonomo eccesso di
qualche agente. Facevano invece parte di un più ampio disegno -così
come le menzogne raccontate più tardi per coprire le nefandezze - ,
che rappresenta una delle pagine più buie nella storia della Polizia
di Stato.
Il tribunale del capoluogo ligure ha dato ragione a Marina Spaccini,
pediatra cinquantenne di origine triestina, pacifista che per
quattro anni ha lavorato in due ospedali missionari del Kenia. Alle
due del pomeriggio del 20 luglio, era il 2001, venne pestata a
sangue in via Assarotti.
Partecipava alla manifestazione della Rete Lilliput, era tra quelli
che alzava in alto le mani dipinte di bianco urlando: "Non
violenza!".
Gli agenti e i loro capi avrebbero poi raccontato che stavano dando
la caccia ad un gruppo di Black Bloc, che c'era una gran confusione
e qualcuno tirava contro di loro le molotov, che non era possibile
distinguere tra "buoni" e "cattivi": bugie smascherate nel corso del
processo, come sottolineato dal giudice. I cattivi c'erano per
davvero, ed erano i poliziotti che a bastonate aprirono una vasta
ferita sulla fronte della pediatra triestina. Dal momento che quegli
agenti, come in buona parte degli episodi legati al vertice, non
sono stati identificati, Angela Latella ha deciso di condannare il
Ministero dell'Interno. La cifra che verrà pagata a Marina Spaccini
non è certo clamorosa - cinquemila euro tra invalidità, danni morali
ed esistenziali - , ma il punto è evidentemente un altro.
«Se risulta chiaramente che la Spaccini sia stata oggetto di un atto
di violenza da parte di un appartenente alle forze di polizia -
scrive il giudice - , non si può neppure porre in dubbio che non si
sia trattato né di un'iniziativa isolata, di un qualche autonomo
eccesso da parte di qualche agente, né di un fatale inconveniente
durante una legittima operazione di polizia volta e riportare
l'ordine pubblico gravemente messo in pericolo».
Perché l'intervento della polizia non fu «legittimo», è ormai
abbastanza chiaro. Lo hanno confermato i testimoni e in un certo
senso gli stessi poliziotti e funzionari, con le loro
contraddizioni: «Gli aggressori erano diverse decine; l'ordine era
di
caricarli, disperderli ed arrestarli», hanno detto, interrogati. Ma
poi risulta che furono arrestati solo due ragazzi (non feriti), la
cui
posizione fu in seguito peraltro archiviata. La pacifista era
assistita dagli avvocati Alessandra Ballerini e Marco Vano. Il
giudice ha sottolineato come fotografie e filmati portati in aula
«siano stati illuminanti»: «Si vedono ammanettare persone vestite
normalmente; più poliziotti colpire con i manganelli una persona a
terra, inerme. La
stessa Spaccini è una persona di cinquant'anni, di cui giustamente
si sottolinea l'aspetto mite». E poi, le testimonianze come quella
di una signora settantenne che parla di una «manifestazione
assolutamente pacifica e allegra» e di aver quindi visto agenti
«bastonare ferocemente persone con le mani alzate ed inermi come
lei». Marina Spaccini ha accolto il giudizio con un sorriso: «Era
semplicemente quello che attendevo da sei anni. Giustizia».
G8, l´ultima verità
sulla Diaz - L´ex questore Colucci confessa: " Mi sentivo
inadeguato"
Sconcertante deposizione dell´alto funzionario sei anni dopo tra
smentite e "non ricordo più"
MASSIMO CALANDRI
L´IMBARAZZANTE interrogatorio di Francesco Colucci, che in quei
giorni del G8 era ancora il questore di Genova, ha dato ieri mattina
la misura di quanto difficile sia il compito di chi vuole fare
chiarezza sulle sciagurate giornate del luglio 2001. A distanza di
sei anni, quello che allora era la massima autorità di pubblica
sicurezza presente in città (prefetto escluso) è caduto in una serie
di contraddizioni ed amnesie che hanno lasciato a bocca aperta i
presenti. «Non ricordo». «Forse ho sbagliato
nel parlare». «La mia affermazione forse è stata un po´ sprovveduta,
superficiale». «Non sono sicuro, lo giuro davanti a Dio e allo Stato
italiano». «Mi correggo, forse sono stato impreciso». Per sei ore
Colucci ha risposto alle domande del pm Enrico Zucca, smentendo in
alcuni casi quando aveva dichiarato a verbale negli anni precedenti
e regalando un´informazione inedita. La notte dell´assalto alla
scuola Diaz, il funzionario che doveva coordinare gli interventi era
il vice-questore Lorenzo Murgolo. Che per il massacro e l´arresto
illegale dei 93 no-global, così come per le prove fasulle, non è
imputato. «Murgolo era il coordinatore. Ma c´erano La Barbera e
Gratteri accanto a lui...
«. Affermazione che vuole dire tutto e niente, perché - come l´ex
questore di Genova ha poi ribadito - «non so a che punto poteva
contare la scala gerarchica».
In un´intera giornata passata in aula, Colucci non ha chiarito
nulla. Perché si decise di intervenire nell´istituto di via
Battisti? La versione è quella del fantomatico attacco in serata
alle pattuglie della polizia, e di quei tipi sospetti - «Non gente
gioiosa, gente allegra... ma facce brutte, con atteggiamenti
minacciosi, vestiti di scuro» - davanti alla scuola. Lui avrebbe
voluto lasciar perdere, ormai il G8 era finito, «ma poi tutti quanti
abbiamo deciso l´intervento: identificare gli aggressori e trovare
armi
eventuali. Fare una perquisizione». Chi tra i super-poliziotti
spinse per il blitz? Colucci fa alcuni nomi, poi ci ripensa, alla
fine spiega che il prefetto La Barbera - che è morto - era d´accordo.
«Io mi sentivo un po´ inadeguato», confessa quello che in quei
giorni era il questore di Genova.
A suo tempo aveva detto che il capo della polizia, Gianni Di
Gennaro, gli aveva detto di telefonare al capo dell´ufficio stampa,
Roberto Sgalla: ieri ha detto che fu una sua iniziativa. Lui restò
in questura, chi lo avvertì del ritrovamento delle molotov? Colucci
fa almeno tre nomi, ma non ricorda. Ed è in difficoltà quando deve
raccontare di quel poliziotto che gli disse di essere stato colpito
dalla coltellata fantasma di un altrettanto fantasma Black Bloc:
«Indossava un maglione di cotone... no... un giubbotto
antiproiettile». Per non parlare di quando spontaneamente confessa
di aver saputo di un equipaggio di una squadra mobile che era
entrato per sbaglio nella scuola di fronte alla Diaz: ma dimentica
di aver inviato a Di Gennaro una relazione in cui scriveva che quei
poliziotti stavano facendo una «verifica».
«Io so solo che quella notte dovevamo fare qualche cosa, dovevamo
reagire a quella cosa.
Eravamo un po´ pressati, eravamo condizionati. E decidemmo di
intervenire».
|
Spese
distruzione Altri 25 milioni di euro per la guerra in Afghanistan. Quanto i tagli alla scuola fatti da Prodi |
|
 Circa
25 milioni di euro. La stessa cifra che il governo Prodi ha tagliato
dai finanziamenti alla scuola pubblica per il corrente anno
scolastico, ora li investe per finanziare i rinforzi al contingente
militare italiano schierato in l’Afghanistan. Circa
25 milioni di euro. La stessa cifra che il governo Prodi ha tagliato
dai finanziamenti alla scuola pubblica per il corrente anno
scolastico, ora li investe per finanziare i rinforzi al contingente
militare italiano schierato in l’Afghanistan. Il ministro della Difesa, Arturo Parisi, ha annunciato davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato l’invio di otto carri armati ‘Dardo’, cinque elicotteri da attacco A-129 ‘Mangusta’, dieci blindati ‘Lince’ e 145 militari di equipaggio e supporto tecnico e logistico. Costo complessivo, calcolato solo fino a fine anno: 25,9 milioni di euro. “La relativa copertura finanziaria – ha spiegato Parisi – d’intesa con la Presidenza del Consiglio e con il ministero dell’Economia e delle Finanze verrà apprestata in sede di adozione del disegno di legge di assestamento del bilancio per l’anno 2007”. I soldi per l’istruzione non ci sono, ma per la guerra si trovano. Nonostante l’incontestabile natura bellica dei mezzi militari in questione, Parisi ha rassicurato coloro che temono una deriva belligerante della “missione di pace” italiana. “Gli equipaggiamenti aggiuntivi – ha spiegato il ministro – non potrebbero consentire un genere di missione differente da quella già adottata dal nostro contingente in accordo con gli alleati della Nato. I nuovi mezzi permetteranno però di migliorare le capacità di esplorazione, la mobilità e la protezione, quindi la sicurezza attiva e passiva, delle nostre truppe”. Chi si ostina a pensare che carri armati, elicotteri da attacco e blindati siano strumenti di guerra, si sbaglia. Parola di ministro. |
| Il Fronte Sem Terra |
| Marce, mobilitazioni, occupazioni delle terre, azioni di pressione contro Lula per chiedere la riforma agraria |
|
|
Marce, mobilitazioni, occupazioni
delle terre, violenti attacchi della polizia, minacce di morte a
sindacalisti e uccisioni di contadini: si racchiude in questa
vorticosa sequenza di avvenimenti l' "Aprile rosso" ampiamente
preannunciato nei mesi scorsi dai Sem terra e dalle
organizzazioni popolari per chiedere ancora una volta quella
riforma agraria che il Planalto non sembra intenzionato a
concedere.
 Aprile
rosso. Stavolta l'Aprile rosso si è svolto con modalità
diverse rispetto alle mobilitazioni e alle rivendicazioni dei
movimenti avvenute in questi ultimi anni. Le novità principali
sono tre: la prima riguarda il bilancio di questo mese di lotte
che il Movimento sem terra (Mst) farà in occasione del suo V°
Congresso nazionale che si terrà in giugno; la seconda si
riferisce alla nascita del Fronte parlamentare della terra nato
su iniziativa di alcuni deputati e senatori; la terza prospetta
una sorta di alleanza tra tutti i movimenti popolari cui
parteciperanno anche i partiti sorti a sinistra di Inácio Lula
in occasione delle recenti elezioni presidenziali. Aprile
rosso. Stavolta l'Aprile rosso si è svolto con modalità
diverse rispetto alle mobilitazioni e alle rivendicazioni dei
movimenti avvenute in questi ultimi anni. Le novità principali
sono tre: la prima riguarda il bilancio di questo mese di lotte
che il Movimento sem terra (Mst) farà in occasione del suo V°
Congresso nazionale che si terrà in giugno; la seconda si
riferisce alla nascita del Fronte parlamentare della terra nato
su iniziativa di alcuni deputati e senatori; la terza prospetta
una sorta di alleanza tra tutti i movimenti popolari cui
parteciperanno anche i partiti sorti a sinistra di Inácio Lula
in occasione delle recenti elezioni presidenziali. A fare un bilancio, per la verità piuttosto impietoso, su come proceda l'assegnazione delle terre da parte del governo alle famiglie del Mst ci pensa Dom Tomás Balduino, vescovo emerito di Goias che ha passato una vita a lottare con i contadini brasiliani lavorando come consigliere della Commissione pastorale della terra. In un articolo pubblicato dal quotidiano italiano "il manifesto" il 17 aprile scorso, Balduino definisce il Brasile come "il paese dell'antiriforma agraria" sottolineando come nel corso del 2006 siano state insediate non più di 40 mila famiglie e che nel 2007 non è possibile aspettarsi alcun progresso significativo: "L'articolo 184 della Costituzione - scrive - prevede l'esproprio per interesse sociale, ai fini della riforma agraria, degli immobili rurali che non rispondano alla loro funzione sociale, mentre sfortunatamente assistiamo invece all'abbandono della terra da parte del potere esecutivo alla voracità delle privatizzazioni nazionali e estere". Proprio per evitare questa deriva, oltre che per commemorare l'undicesimo anniversario della strage di Eldorado dos Carajas (per il cui massacro, seguente all'attacco immotivato della polizia a un corteo pacifico dei Senza terra occorso il 17 aprile 1996, non sta pagando ancora nessuno) il Mst ha lanciato l'Aprile rosso aprendo stavolta la sua protesta al coordinamento dei movimenti sociali di tutto il paese e raccogliendo anche l'appoggio del governatore di Bahia e di qualche prefetto. La sfida del Mst in vista dell'imminente congresso è rivolta al tentativo di costruire l'unità tra le organizzazioni sociali del paese, peraltro già messa in pratica nell'interessante esperimento denominato "Carta de Belém aos povos da Amazonia", redatto da Via campesina, piccoli agricoltori, contadini senza terra e associazioni ecologiste.  All'insegna
dell'unità. Questo documento, stilato il 20 aprile
durante un seminario intitolato "Contra o imperialismo e pela
soberania popular na Amazonia", denuncia i problemi derivanti
dall'agronegozio, dalla monocultura, dalla privatizzazione di
fiumi e laghi che danneggiano gravemente la biodiversità,
l'agricoltura e la vita dei popoli originari della regione, e
ben si concilia con lo slogan che aprirà il V° Congresso:
"Riforma agraria, per la giustizia sociale e la sovranità
popolare". La riforma agraria, secono il Mst, costituisce la
bandiera storica e permanente del movimento. "Giustizia sociale
perché vogliamo attraverso la riforma agraria contribuire a un
nuovo progetto sociale di sviluppo che elimini le disuguaglianze
economiche, sociali e politiche esistenti. Sovranità popolare
perché, in questa tappa dell'imperialismo, il nostro paese è
attaccato come non mai dagli interessi del capitale
internazionale. La sovranità nazionale non può essere difesa che
dal popolo che prenda nelle sue mani il proprio destino e
difenda il nostro territorio, le nostre ricchezze, la nostra
agricoltura, la nostra biodiversità, la nostra acqua, la nostra
cultura, la nostra lingua e i nostri alimenti". All'insegna
dell'unità. Questo documento, stilato il 20 aprile
durante un seminario intitolato "Contra o imperialismo e pela
soberania popular na Amazonia", denuncia i problemi derivanti
dall'agronegozio, dalla monocultura, dalla privatizzazione di
fiumi e laghi che danneggiano gravemente la biodiversità,
l'agricoltura e la vita dei popoli originari della regione, e
ben si concilia con lo slogan che aprirà il V° Congresso:
"Riforma agraria, per la giustizia sociale e la sovranità
popolare". La riforma agraria, secono il Mst, costituisce la
bandiera storica e permanente del movimento. "Giustizia sociale
perché vogliamo attraverso la riforma agraria contribuire a un
nuovo progetto sociale di sviluppo che elimini le disuguaglianze
economiche, sociali e politiche esistenti. Sovranità popolare
perché, in questa tappa dell'imperialismo, il nostro paese è
attaccato come non mai dagli interessi del capitale
internazionale. La sovranità nazionale non può essere difesa che
dal popolo che prenda nelle sue mani il proprio destino e
difenda il nostro territorio, le nostre ricchezze, la nostra
agricoltura, la nostra biodiversità, la nostra acqua, la nostra
cultura, la nostra lingua e i nostri alimenti". Sebbene i Sem terra abbiano più volte chiarito che il Congresso sarà all'insegna dell'unità tra tutti i movimenti per potenziare le lotte sociali, come spiegato anche dal "Jornal Sem Terra", e non specificamente contro il governo Lula quanto invece contro l'agrobusiness, l'ex deputato José Dirceu (pesantemente coinvolto nel sistema di tangenti per comprare i voti dei partiti alleati al Pt, aveva rischiato di mandare all'aria la rielezione di Lula per l'enorme scandalo suscitato) ha definito la scelta di formare un coordinamento di movimenti sociali aperto anche ai partiti Pstu (Partido socialista dos trabalhadores unificado) e Psol (Partido socialismo e liberdade) come "un fatto molto preoccupante" al solo scopo di creare scissioni e divisioni all'interno della Coordenação dos movimentos sociais in via di formazione.In realtà l'apertura al Pstu e al Psol non è stata decisa perché si pongono alla sinistra di Lula, ma per aprire nuovi spazi di lotta politica e lo stesso Aprile rosso, chiarisce la rivista brasiliana "Carta Maior", proviene dalla volontà della sinistra brasiliana di "pensare a nuove forme organizzative insieme ai senza tetto, agli indigeni, ai movimenti che si battono contro le dighe e a tutti coloro che vogliano creare un processo di trasformazione verso nuove prospettive". In definitiva si tratta di un'unione che nascerà non tanto per mettere in crisi il governo Lula in quanto tale, ma per contrastare la progressiva perdita dei diritti di contadini e lavoratori rispetto al grande capitale.  Fronte
della terra. In questo senso la spinta e la pressione
dell'Aprile rosso ha già ottenuto un primo risultato, cioè la
creazione di un Fronte parlamentare della terra nel pieno della
mobilitazione contadina. Costituito da 175 deputati e 12
senatori, il Fronte ha tre progetti prioritari, ben messi in
rilievo dal Comitato italiano di appoggio ai Sem terra: la
proposta di modifica costituzionale 438 del 2001 che permette
l'espropriazione di aree con comprovata esistenza di lavoro
schiavo; l'attualizzazione degli indici di produttività; la
ripresa delle proposte della relazione del deputato João Alfredo
(Psol), presentate alla Commissione pastorale missionaria
indigena della terra. Fronte
della terra. In questo senso la spinta e la pressione
dell'Aprile rosso ha già ottenuto un primo risultato, cioè la
creazione di un Fronte parlamentare della terra nel pieno della
mobilitazione contadina. Costituito da 175 deputati e 12
senatori, il Fronte ha tre progetti prioritari, ben messi in
rilievo dal Comitato italiano di appoggio ai Sem terra: la
proposta di modifica costituzionale 438 del 2001 che permette
l'espropriazione di aree con comprovata esistenza di lavoro
schiavo; l'attualizzazione degli indici di produttività; la
ripresa delle proposte della relazione del deputato João Alfredo
(Psol), presentate alla Commissione pastorale missionaria
indigena della terra. Il Fronte parlamentare intende spingere il congresso sempre più nelle mani dei gruppi ruralisti e che considera le occupazioni alla stregua di atti terroristici ad affrontare le tematiche relative allo sviluppo sostenibile, all'agricoltura contadina e soprattutto alla revisione di quegli indici di produttività (si tratta di parametri utilizzati dall'Incra - Istituto nazionale per la riforma agraria - volti a stabilire se una terra è coltivata o meno e se può essere affidata ai Sem terra oppure no) che il presidente Lula ha da tempo promesso senza poi riuscire ad attuarla per via delle forti pressioni dei fazendeiros. La prima uscita pubblica del Fronte parlamentare è stata il 3 maggio scorso quando si è costituito l'Alesp (Frente parlamentar pela reforma agraria na asembléia legislativa de São Paulo) ad opera di 19 deputati appartenenti in maggioranza al Pt e al Psol. Nato grazie all'impegno di Raul Marcelo (Psol) e Simão Pedro (Pt), l'Alesp intende incentivare e rafforzare l'agricoltura familiare a scapito dell'agronegozio e della monocoltura della canna da zucchero per evitare che il progressivo indebolimento dei piccoli agricoltori li costringa ad abbandonare le campagne finendo così per aumentare l'enorme numero di disoccupati già presenti nelle grandi metropoli urbane. Se il coinvolgimento di un certo numero di parlamentari per la riforma agraria fa ben sperare, altrettanto positive sono le notizie rivelate dal sito Global Project (http://www.globalproject.info/), che ci parlano dell'impegno del governatore petista di Bahia Jaques Wagner per "l'accelerazione del processo di riforma agraria e, per la fine dell'anno, per la costruzione di 3mila case, la sistemazione di 5mila abitazioni e la creazione di oltre 10mila allacci per l'energia elettrica grazie al programma Luce per tutti" con la promessa di "costruire circa mille chilometri di strade per raggiungere gli insediamenti, fornire assistenza tecnica agricola e stanziare 3 milioni di real per l'acquisto di sementi per le comunità".
Per un governatore che promette di
farsi carico delle richieste dei movimenti ci sono però troppi
casi di repressione e persecuzione contro i contadini senza
terra: nel Rio Grande do Sul sono stati sparati proiettili di
gomma contro di loro dalla Brigata militare dello stato, le
occupazioni negli stati di Pernambuco, Paraiba e São Paulo hanno
ricevuto la visita di poliziotti privati al soldo dei
latifondisti, mentre la sindacalista Maria Ivete Bastos, nel
Pará, ha ricevuto minacce di morte. Sempre nello stesso stato,
il 2 maggio, un accampamento composto da 320 famiglie del Mst
nel municipio di Iritula (a 140 chilometri da Belém) è stato
aggredito da un gruppo di 50 pistoleiros che hanno
ucciso il contadino senza terra sessantenne Antonio Santos do
Carmo.
 Nessuno
riposta. Ai tanti casi di intimidazione, uccisioni e
impunità, il Mst ha deciso di rispondere con un'ampia campagna
di sensibilizzazione basata su iniziative divulgative (ad
esempio la pubblicazione del quaderno sui conflitti nelle
campagne ad opera della Pastorale della terra in cui si denuncia
la grande concentrazione della terra nelle mani di pochi), e su
una catena impressionante di rivendicazioni e marce: grandi
cortei sono sorti a Itapetininga (Stato di San Paolo), ove
alcune centinaia di famiglie si sono stabilite nei territori
dell'impresa Suzano carta e cellulosa; in Pernambuco è stata
occupata l'azienda Xixaim, e ancora nel Rio Grande del Sud,
appoggiati da alcuni sindaci, i contadini hanno chiesto
l'esproprio di una fazenda; in Minais Gerais, nonostante le
minacce di sgombero da parte della polizia, il Mst ha deciso di
non abbandonare i latifondi dove si è insediato, mentre a fine
aprile ha difeso la Comuna da terra Che Guevara (nella regione
del Grande São Paulo) occupata alcune settimane prima e che ha
ricevuto l'ordine di essere sgomberata nonostante la presenza
nell'accampamento di oltre 100 famiglie. Nessuno
riposta. Ai tanti casi di intimidazione, uccisioni e
impunità, il Mst ha deciso di rispondere con un'ampia campagna
di sensibilizzazione basata su iniziative divulgative (ad
esempio la pubblicazione del quaderno sui conflitti nelle
campagne ad opera della Pastorale della terra in cui si denuncia
la grande concentrazione della terra nelle mani di pochi), e su
una catena impressionante di rivendicazioni e marce: grandi
cortei sono sorti a Itapetininga (Stato di San Paolo), ove
alcune centinaia di famiglie si sono stabilite nei territori
dell'impresa Suzano carta e cellulosa; in Pernambuco è stata
occupata l'azienda Xixaim, e ancora nel Rio Grande del Sud,
appoggiati da alcuni sindaci, i contadini hanno chiesto
l'esproprio di una fazenda; in Minais Gerais, nonostante le
minacce di sgombero da parte della polizia, il Mst ha deciso di
non abbandonare i latifondi dove si è insediato, mentre a fine
aprile ha difeso la Comuna da terra Che Guevara (nella regione
del Grande São Paulo) occupata alcune settimane prima e che ha
ricevuto l'ordine di essere sgomberata nonostante la presenza
nell'accampamento di oltre 100 famiglie. Iniziative di questo genere si sono svolte pressoché in tutto il Brasile, ma una risposta del governo che faccia registrare dei cambiamenti profondi in termini di politica agraria, economica e ambientale sembra ben lontana da arrivare: soltanto dopo il congresso del Mst si capirà quali ulteriori prese di posizione saranno adottate in una battaglia che si annuncia sempre più dura tra due visioni del mondo così differenti. |
15 maggio
Riflessioni pre "Family Day"
Lettera di Travaglio a Ruini
Eminenza reverendissima cardinale
Camillo Ruini,
mi rivolgo a lei anche se la so da poco in pensione, anziché al suo successore
card. Bagnasco, perché lei è un po’ l’Andreotti del Vaticano: ha accompagnato la
vita politica e religiosa del nostro paese per molti decenni. Come lei ben sa,
non c’è paese d’Europa che abbia avuto tanti capi del governo cattolici come
l’Italia. Su 60 governi in 60 anni, 51 avevano come premier un cattolico e solo
9 un laico: 2 volte Spadolini, 2 Craxi, 2 Amato, 2 D’Alema, 1 Ciampi, che
peraltro si dichiara cattolico. In 60 anni l’Italia è stata governata per 52
anni da un cattolico e per 8 da un laico. Se la DC e i suoi numerosi eredi
avessero fatto per la famiglia tutto ciò che avevano promesso, oggi le famiglie
italiane dormirebbero tra due guanciali. Sa invece qual è il risultato? Che
l’Italia investe nella spesa sociale il 26,4% del Pil, 5 punti in meno che nel
resto d’Europa a 15, quella infestata di massoni, mangiapreti, satanisti e -per
dirla con Tremaglia- culattoni. Se poi andiamo a vedere quanti fondi vanno alle
famiglie e all’infanzia nei paesi che non hanno avuto la fortuna di avere in
casa Dc e Vaticano, scopriamo altri dati interessanti. L’Italia è penultima in
Europa col 3,8% della spesa sociale alle famiglie, contro il 7,7% dell’Europa,
il 10,2% della Germania, il 14,3% dell’Irlanda. Noi diamo alla famiglia l’1,1%
del Pil: meno della metà della media europea (2,4). Sarà un caso, ma noi siamo
in coda in Europa per tasso di natalità: la Francia ha il record con 2 figli per
donna, la media europea è 1,5, quella italiana 1,3. E il resto d’Europa ha i
Pacs, noi no: pare che riconoscere i diritti alle coppie di fatto non impedisca
le politiche per la famiglia, anzi. Lei che ne dice?
Lei sa, poi, che per sposarsi e fare figli, una coppia ha bisogno di un lavoro
stabile. Sa quanto spendiamo per aiutare i disoccupati? Il 2% della spesa
sociale, ultimi in Europa. La media Ue è il 6%. La Spagna del terribile Zapatero
spende il 12,5. I disoccupati che ricevono un sussidio in Italia sono il 17%,
contro il 71 della Francia, l’80 della Germania, l’84 dell’Austria, il 92 del
Belgio, il 93 dell’Irlanda, il 95 dell’Olanda, il 100% del Regno Unito. E per i
giovani è ancora peggio: sotto 25 anni, da noi, riceve il sussidio solo lo
0,65%; in Francia il 43, in Belgio il 51, in Danimarca il 53, nel Regno Unito il
57. Poi c’è la casa. Anche lì siamo penultimi: solo lo 0,06% della spesa sociale
va in politiche abitative (la media Ue è il 2%, il Regno Unito è al 5,5). Se in
Italia i figli stanno meglio che nel resto del mondo, anche perché sono
pochissimi, per i servizi alle madri siamo solo al 19° posto.
Forse, Eminenza, visto il rendimento dei politici cattolici o sedicenti tali,
avete sempre puntato sui cavalli sbagliati. O forse, se aveste dedicato un
decimo delle energie spese per combattere i Dico e i gay a raccomandare qualche
misura concreta per la famiglia, non saremmo i fanalini di coda dell’Europa:
perché i nostri politici le promesse fatte agli elettori non le mantengono, ma
quelle a voi le mantengono eccome. Sono proprio sacre.
Ora speriamo che il Family Day faccia il miracolo. A questo proposito, vorrei
mettere una buona parola per evitare inutili imbarazzi. Come lei sa, hanno
aderito all’iniziativa moltissimi politici così affezionati alla famiglia da
averne due o tre a testa. Come Berlusconi, che ha avuto due mogli, senza contare
le giovani e avvenenti attiviste di Forza Italia con cui prepara il Family Day
nel parco di villa Certosa. Le cito qualche altro esempio da un bell’articolo di
Barbara Romano su Libero. Vediamo la Lega, che fa fuoco e fiamme per la sacra
famiglia. Bossi 2 mogli. Calderoli 2 mogli (la seconda sposata con rito celtico)
e una compagna. Castelli, una moglie in chiesa e l’altra davanti al druido. Poi
c’è l’Udc, l’Unione democratico cristiana, dunque piena di separati e
divorziati. Divorziato Casini, che ha avuto due figlie dalla prima moglie e ora
vive con Azzurra. Divorziati l’ex segretario Follini e il vicecapogruppo
Giuseppe Drago, mentre la vicesegretaria Erminia Mazzoni sta con un divorziato.
D’Onofrio ha avuto l’annullamento dalla Sacra Rota. Anche An è ferocissima
contro i Dico. Fini ha sposato una divorziata. L’on. Enzo Raisi ha detto:“Io
vivo un pacs”. Altro “pacs” inconfessato è quello tra Alessio Butti e la sua
compagna Giovanna. Poi i due capigruppo: alla Camera, Ignazio La Russa, avvocato
divorzista e divorziato, convive; al Senato, Altero Matteoli, è divorziato e
risposato con l’ex assistente. Adolfo Urso è separato. L’unico big in regola è
Alemanno:si era separato dalla moglie Isabella Rauti, ma poi son tornati
insieme. Divorziati gli ex ministri Baldassarri (risposato) e Martinat
(convivente). La Santanchè ha avuto le prime nozze annullate dalla Sacra Rota,
poi ha convissuto a lungo. E Forza Italia? A parte il focoso Cavaliere, sono
divorziati il capogruppo alla Camera Elio Vito e il vicecapogruppo Antonio
Leone. L’altro vice, Paolo Romani, è già al secondo matrimonio: «e non è finita
qui», minaccia. Gaetano Pecorella ha alle spalle una moglie e “diverse
convivenze”. Divorziati anche Previti, Adornato, Vegas, Boniver. Libero cita tra
gli irregolari persino Elisabetta Gardini, grande amica di Luxuria, che ha un
figlio e (dice Libero) convive con un regista. Frattini, separato e convivente,
è in pieno Pacs. Risposàti pure Malan, D’Alì e Gabriella Carlucci, mentre la
Prestigiacomo ha sposato un divorziato. E al Family day ci sarà pure la Moratti
col marito Gianmarco, pure lui divorziato.
Ecco, Eminenza, personalmente sono convinto che ciascuno a casa sua sia libero
di fare ciò che vuole. Ma è difficile accettare l’idea che questi signori, solo
perché siedono in Parlamento, abbiano dal ‘93 l’assistenza sanitaria per i
conviventi more uxorio e vogliano negarla a chi sta fuori. E che lei Eminenza
non abbia mai tuonato contro i Pacs parlamentari. Ora però non vorrei che
qualche Onorevole Pacs disertasse il Family Day per paura di beccarsi una
scomunica. Perciò mi appello a lei: se volesse concedere una speciale dispensa
almeno per sabato, ne toglierebbe d’ imbarazzo parecchi. Potrebbe pure
autorizzarli a sfilare ciascuno con tutte le sue famiglie, magari entro e non
oltre il numero di 3. Per far numero. Ne guadagnerebbe la partecipazione. Si
potrebbe ribattezzare l’iniziativa Multifamily Day.
Marco Travaglio
Lettera pervenuta a Ultimissime
Riflessioni post "Family Day"
Se chiesa e destra vanno in piazza insieme
di EDMONDO BERSELLI
MAI la Chiesa, negli ultimi vent'anni,
era stata così vicina alla politica, così influente, così ingombrante.
Affiancata dai partiti di destra, e con il centrosinistra scompaginato dal
conflitto interno, non dichiarato e non elaborato, sulla laicità. Se le cose
stanno così, se questa diagnosi è realistica, sabato scorso in Piazza San
Giovanni è avvenuto un disastro politico e civile. E allora vale la pena di
guardarlo in profondità, senza complessi. La prima e fondamentale conseguenza
del Family Day è evidente: si è saldato un fronte tra ampi settori del mondo
cattolico e la destra italiana.
E ciò è avvenuto in un modo e con un'intensità tali da sorprendere gli stessi
vertici ecclesiastici, la segreteria di Stato vaticana, la Conferenza
episcopale. Alla Chiesa post-wojtyliana era ovviamente utile una dimostrazione
di forza, anche per esibire uno di quegli spettacoli di mobilitazione che senza
il carisma di Giovanni Paolo II risultano difficili da riprodurre oggi sulla
scena pubblica. Ma è tutto da provare che per la gerarchia cattolica fosse
davvero conveniente quella spettacolare fusione di morale e politica, di alto
magistero e di bassi interessi di bottega, che se da un lato ha esibito
l'adesione popolare ai temi della famiglia, dall'altro ha permesso il sequestro
politico di piazza San Giovanni da parte dei leader del centrodestra.
La presenza di Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini
rappresentava con chiarezza qual era una finalità possibile del Family Day,
almeno nelle intenzioni dei suoi sponsor politici più spregiudicati: e cioè
mettere in rilievo che l'appello per una "politica per la famiglia"
rappresentava invece l'opportunità per una polemica caldissima contro il
riconoscimento legale delle unioni civili. Ossia per dividere in due, con
volontà esplicita, l'opinione pubblica: in modo da poter attestare che da una
parte, a destra, ci sono i buoni cattolici, e dall'altra, a sinistra, c'è una
consorteria di avversari, di "laicisti", di personalità insensibili alle grandi
verità religiose.
In quella compagine ostile alla Chiesa e ai suoi fondamenti, guidata dal Prodi "rovinafamiglie"
immortalato sulle magliette, i cattolici del centrosinistra si trovano in
difficoltà. Secondo l'intonazione psicologica della piazza anti-Dico, il mondo
cattolico non è rappresentato da Clemente Mastella o da Francesco Rutelli, e
meno che mai da Rosy Bindi; costoro non rappresentano nessuno e non sono neppure
la foglia di fico sulle vergogne laiciste del centrosinistra: ne è una riprova a
contrario l'accoglienza entusiastica riservata a Silvio Berlusconi, a
testimonianza che c'è stata una fusione politica, di popolo, fra le posizioni
cattoliche più intransigenti e la scelta per il centrodestra.
Matrimonio d'interesse e d'amore. Sicché è superfluo sottolineare che il raid di
Silvio Berlusconi durante il Family day è stato un gesto politicamente
impegnativo, anche a prescindere dalla violenza delle sue parole, quelle frasi
provocatorie secondo cui non è possibile essere contemporaneamente fedeli
cattolici e di sinistra. Berlusconi ha realizzato uno dei suoi blitzkrieg, e ha
tentato di mettersi in tasca in un colpo solo l'ideologia della famiglia, il
movimento ecclesiale, i sostenitori del matrimonio, gli oppositori del divorzio
e dell'aborto, i contestatori della procreazione assistita, dei Dico e delle
unioni omosessuali.
Ebbene, sarebbe il caso di capire come la pensa la Chiesa, al suo vertice,
dell'appropriazione indebita delle istanze cattoliche e delle masse dei fedeli
convenute a Roma per sostenerle. Riesce incongruo infatti credere che la
gerarchia giudichi utile, cioè politicamente conveniente, e spiritualmente
convincente, il cinismo opportunista con cui Berlusconi e i suoi alleati hanno
confiscato la comunità ecclesiale (almeno quella parte che interpreta
l'appartenenza al cattolicesimo con uno spirito di rivalsa, di rivincita, di
spagnolesca "reconquista"). Vale a dire sulla base di un'idea di divisione,
senza nascondere una chiara inimicizia contro quella parte di società, di
politica e di cattolicesimo che la pensa diversamente.
Va da sé che la Chiesa non possa accettare di essere sequestrata in vista
dell'utilità politica di una parte. E quindi non è del tutto irrealistico
attendersi qualche presa di distanza, fosse anche soltanto una sottigliezza per
smarcarsi. Questo perché monsignor Angelo Bagnasco deve ancora guadagnarsi la
titolarità della sua azione come presidente della Cei, uscendo dalla definizione
ristretta di successore di Ruini. E il segretario di Stato, Tarcisio Bertone,
deve curare anche le diplomazie con il governo attuale e con i ministri
cattolici che ne fanno parte. E va rilevato nel frattempo che Bagnasco ha
taciuto sostanzialmente sul Family Day: ciò è un sintomo di quanto sia arduo
rinnovare in modo originale la linea dell'episcopato, ma anche un indizio della
sua prudenza.
Tuttavia il punto cruciale è evidente di per sé: comunque si sia verificata, non
si è mai vista, in tempi di bipolarismo, una collocazione così netta ed
esclusiva della Chiesa a fianco di una parte politica. Al di là dei riverberi
più evidentemente confessionali, si prospetterebbe una conseguenza politica di
estremo rilievo, cioè un attrito vistoso con l'intera evoluzione del sistema
politico: la formula bipolare infatti doveva consentire la libera collocazione
politica dell'elettorato cattolico.
Viceversa, una variante estremistica come quella prospettata sabato da
Berlusconi, i cattolici di qua e i miscredenti di là, assomiglia più a un'eresia
manichea che a un criterio di ragionevolezza politica. Altro che suggestioni
neoguelfe: qui è potenzialmente in gioco la "cattura" della Chiesa da parte di
uno dei giocatori politici. E dunque, se il mercante sequestra il tempio,
sarebbe interesse della comunità ecclesiastica che emergessero voci e figure
indisponibili a schiacciarsi su una soluzione politica confessionale, con le
ripercussioni politiche che si possono immaginare. Di tutto infatti avrà bisogno
la Chiesa, ma non di una guerra di religione. E neppure di diffidenze e ostilità
speculari sul piano del governo e delle istituzioni.
Tanto più che sullo sfondo del Family day (e delle contrapposizioni tra Vaticano
e sinistra, dal referendum sulla fecondazione assistita ai Dico), sono entrati
in gioco principi basilari in materia di laicità dello Stato, suscettibili di
favorire contrasti pesanti dentro il centrosinistra. Per ora nell'Unione il
conflitto non è esploso, ma non c'è dubbio che sulla piazza del Family Day si
sono compiuti sacrifici politici pesanti: si è sacrificata in primo luogo una
parte della presenza e credibilità pubblica dei Ds.
Il silenzio dei Ds è una scelta obbligata, dettata dall'impossibilità di
parlare, perché parlare equivarrebbe a innescare la contrapposizione con il
proprio alleato, la Margherita, proprio mentre si sta avviando il processo che
conduce alla nascita del Partito democratico. Ma la rinuncia effettiva a
qualificare la propria presenza nel Pd, da parte diessina, è già di per sé
un'abdicazione; e anzi l'effetto della distorsione prodotta dalla
politicizzazione della religione, dall'abbandono di un criterio comune di
laicità.
Il Family Day, insomma, ha avuto conseguenze sui due lati della struttura
politica italiano: ha reso asimmetrici gli schieramenti, ha squilibrato il
bipolarismo, dà un'inflessione clericale al giudizio sull'azione di governo.
Sarà il caso che tutto il centrosinistra, da Romano Prodi in giù, valuti con
attenzione queste ripercussioni e le risposte possibili. Ma anche da parte
ecclesiastica dovrebbe esserci la percezione che il nuovo integralismo, la
comunanza indistricabile e "simoniaca" fra destra e Chiesa, è una distorsione
del meccanismo democratico, e potenzialmente una perdita grave in termini di
ricchezza e libertà della convivenza civile.
Filippine, sangue sul voto
Il paese alla urne. Almeno cento morti in quattro mesi di campagna elettorale
Più di cento morti e quasi
trecento feriti in quattro mesi: è il tragico bilancio della campagna elettorale
nelle Filippine. Il paese oggi va alle urne per rinnovare la Camera dei
Rappresentanti e metà dei seggi del Senato, nonché per eleggere più di 17 mila
funzionari amministrativi a livello nazionale e locale. Dall'inizio dell'anno,
secondo le cifre diffuse dalla polizia, sono stati uccisi 52 fra candidati e
politici, 36 loro sostenitori, e undici civili che si sono trovati nel posto
sbagliato al momento sbagliato. Che le campagne elettorali finiscano nel sangue
non è cosa nuova nell'arcipelago delle Filippine: nell'ondata di violenza e
omicidi politici che aveva preceduto le presidenziali del 2004 erano morte
almeno 189 persone. I candidati assoldano milizie private per proteggersi e per
intimidire gli avversari, la tensione viene esasperata dalle reciproche accuse
di brogli. E l'infinita disponibilità di armi – perlopiù provenienti dal mercato
nero, quindi vendute e comprate senza nessun controllo - non fa che aumentare le
violenze.
Gli oppositori del governo della presidente Arroyo hanno già iniziato a
denunciare i tentativi di manipolazione del voto. Ma accuse del genere piovono
anche dagli ambienti che al governo dovrebbero essere più favorevoli: un gruppo
di generali dell'esercito in pensione, ad esempio, si è riunito sotto il nome di
Bantay Boto, letteralmente 'le guardie del voto', per denunciare che alcuni
ufficiali dell'esercito – proprio quelli che sono stati incaricati da Gloria
Arroyo di vigilare sulla sicurezza e la trasparenza della campagna - starebbero
lavorando sottobanco insieme ai funzionari elettorali per falsarne l'esito. Il
broglio, accusano i Bantay Boto, potrebbe investire sedici province, con
quattordici milioni di voti che potrebbero essere dirottati a favore dei
candidati alleati della presidente Arroyo.
Intanto non si fermano gli scontri e le violenze sui tre fronti interni
che il governo di Manila, ormai da decenni, combatte con scarsi risultati.
Martedì scorso a Mindanao, nel sud musulmano, un'esplosione in un mercato – per
cui il governo ha subito accusato i fondamentalisti islamici – ha ucciso otto
civili. Mentre a Jolo i gruppi musulmani festeggiano la decisione di un
tribunale di Manila, che ha concesso a Nur Misuari, leader del Fronte Moro di
Liberazione Nazionale (Mnlf), di candidarsi alla carica di governatore,
nonostante sia da anni agli arresti domiciliari. Dal 1971 a oggi, il conflitto
indipendentista islamico nel sud del paese ha causato la morte di almeno 150
mila persone. Nell'isola di Mindoro, invece, giovedì mattina i combattenti
comunisti del Nuovo Esercito Popolare (Npa) hanno ucciso cinque poliziotti
filippini facendo detonare una mina al passaggio del loro convoglio. Contro l'Npa,
attivo nell'arcipelago da trentotto anni, la presidente Arroyo e il suo esercito
usano il pugno di ferro: bombardamenti, sparatorie sui civili, assedii di stampo
medievale per stanare i guerriglieri, per cui non sono mancate le critiche delle
organizzazioni per il rispetto dei diritti umani.
L'ultimo episodio che ha sconvolto la popolazione ha avuto come
protagonista una bambina: Grecil Buya, nove anni, uccisa il 31 marzo scorso
dall'esercito filippino durante uno scontro a fuoco con gli uomini dell'Npa. La
rabbia della popolazione era esplosa quando i comandanti dell'esercito di Manila
avevano liquidato la morte di Grecil in modo molto semplice: era un bambino
soldato, sparare era legittimo. Alla fine di aprile, l'ammissione: non era un
soldato, era solo una bambina, ed è stato un “tragico incidente”. Come aveva
notato un giornalista filippino, non poteva essere un soldato: era alta quanto
il fucile.
Cecilia Strada
11 maggio
Irlanda, la sofferta scelta di Miss 'D'
Incinta di un bambino gravemente malato, fa ricorso contro il divieto di abortire e riaccende un annoso dibattito
Un caso di coscienza. Una
ragazza irlandese di 17 anni ha fatto appello all'Alta Corte di Dublino contro
il divieto di recarsi in Gran Bretagna per abortire. La ragazza, proveniente
dalla contea di Leinster, è incinta di 4 mesi di un bambino affetto da
anencefalia e pertanto condannato a morire entro una settimana dall'eventuale
parto. La vicenda riaccende il dibattito sull'aborto in un Paese che, insieme a
Polonia, Portogallo e Malta, considera perseguibile penalmente chi decide
volontariamente di porre fine alla gravidanza. Dal 1861, infatti, il governo
irlandese nega alle donne il diritto di scelta, permettendo loro di abortire
solo in caso di incesto, violenza sessuale o rischio per la loro vita.
 Libertà
di scelta. 'Miss D', come è stata chiamata la ragazza, ha saputo delle
condizioni del feto solo un mese fa. La diagnosi, oltre ad averla sconvolta,
l'ha posta brutalmente di fronte a una scelta: portare comunque a termine la
gravidanza, o interromperla. Miss D ha deciso che sarebbe stato inutile e penoso
far nascere il proprio bambino per vederlo morire qualche giorno dopo. Così, ha
fatto domanda al Servizio sanitario nazionale (Hse), che la sta assistendo, per
potersi recare in Gran Bretagna ad abortire. L'autorità sanitaria irlandese ha
chiesto alla polizia di emettere un divieto di espatrio, ma l'avvocato della
ragazza, Eoghan Fitzsimons, ha dichiarato che tale proibizione sarebbe stata
nulla senza una sentenza da parte del tribunale. Così ha fatto appello all'Alta
Corte, massimo organo giuridico irlandese. Oltre a ricorrere contro
l'interdizione all'espatrio, il legale della ragazza ha denunciato
l'interferenza da parte dello Stato nei confronti dei diritti, sanciti dalla
Costituzione, all'autonomia personale, all'integrità del proprio corpo e alla
sfera privata.
Libertà
di scelta. 'Miss D', come è stata chiamata la ragazza, ha saputo delle
condizioni del feto solo un mese fa. La diagnosi, oltre ad averla sconvolta,
l'ha posta brutalmente di fronte a una scelta: portare comunque a termine la
gravidanza, o interromperla. Miss D ha deciso che sarebbe stato inutile e penoso
far nascere il proprio bambino per vederlo morire qualche giorno dopo. Così, ha
fatto domanda al Servizio sanitario nazionale (Hse), che la sta assistendo, per
potersi recare in Gran Bretagna ad abortire. L'autorità sanitaria irlandese ha
chiesto alla polizia di emettere un divieto di espatrio, ma l'avvocato della
ragazza, Eoghan Fitzsimons, ha dichiarato che tale proibizione sarebbe stata
nulla senza una sentenza da parte del tribunale. Così ha fatto appello all'Alta
Corte, massimo organo giuridico irlandese. Oltre a ricorrere contro
l'interdizione all'espatrio, il legale della ragazza ha denunciato
l'interferenza da parte dello Stato nei confronti dei diritti, sanciti dalla
Costituzione, all'autonomia personale, all'integrità del proprio corpo e alla
sfera privata.
Referendum. Nonostante negli ultimi anni la legislazione sull'aborto sia
stata resa meno rigida, e in alcune circostanze le donne abbiano potuto recarsi
all'estero per l'operazione, il Primo ministro irlandese Bertie Ahern ha
dichiarato che nessun progetto di legge è stato elaborato per modificare la
legislazione, anche in un caso così delicato come quello di 'Miss D'. Dal 1980
al 2002, oltre 100 mila donne hanno deciso di porre termine alla loro gravidanza
nel Regno Unito. Ciò è consentito solo se la gravidanza pone un 'serio e
sostanziale rischio per la vita della donna. Secondo l'Information Act del 1995,
informazioni sulle cliniche che praticano l'aborto in Gran Bretagna sono
accessibili solo tramite un colloquio nei centri di consulenza. Nel 1983 è stato
indetto un referendum per emendare la Costituzione introducendo un nuovo
articolo, chiamato l'emendamento 'pro-vita', che riconosce al feto gli stessi
diritti della donna incinta. Nel 2002, un analogo referendum ha visto nuovamente
la vittoria degli anti-abortisti, con un margine di poco meno di un punto
percentuale. Nel settembre 2005, un sondaggio commissionato dall'Irish Examiner
si è rivelato soprendente: in Irlanda, solo il 36 per cento della popolazione è
favorevole alla legalizzazione dell'aborto, contro il 37 per cento degli
antiabortisti.
Nigeria, nulla è cambiato. Il governo richiami l'Eni
In Nigeria c'è una guerra e come
sempre a pagarne il prezzo è la società civile. Per appropriarsi delle immense
risorse energetiche del paese più popoloso d'Africa le multinazionali portano
avanti un sistematico sterminio degli ecosistemi del Delta del Niger, fanno
accordi o sostengono direttamente governi militari o assolutamente corrotti e
tengono in ostaggio la possibilità di sviluppo dei 20 milioni di esseri umani
che abitano le zone ricche di petrolio e gas. Interi popoli che vivono con meno
di due dollari al giorno e che non hanno mai né visto né conosciuto i vantaggi
dello «sviluppo», pur essendo da sempre «proprietari» di immense fortune
destinate ad «emigrare» sui conti correnti delle grandi transnazionali, ma che
sicuramente ne pagano il prezzo.
Anche l'Italia fa la sua parte, ma in negativo. Attraverso la sua impresa di
stato, saccheggia e inquina la Nigeria, continuando a portare avanti pratiche
illegali come quella del «gas flaring», contribuendo a far diventare il paese
africano il primo inquinatore al mondo per Co2 da «gas flaring». E tutto ciò
avviene proprio mentre qui in Europa si discute dell'urgenza di intervenire per
frenare i cambiamenti climatici, di rispetto dei diritti umani e di cooperazione
con i paesi del sud del mondo. Un controsenso e un'ipocrisia aggravata dal fatto
che l'Eni è ancora (e per fortuna) una compagnia controllata dallo stato e
quindi dal nostro governo, che da un lato dice di voler cambiare la sua politica
energetica, estera e ambientale e dall'altro non riesce nemmeno a impedire che
la sua più importante azienda porti avanti una politica che è l'esatto opposto
delle parole «pace e cooperazione».
Ormai da tempo in Italia la società civile ha maturato una coscienza e
realizzato un'analisi sui temi della pace, dei diritti umani, dello sviluppo
sostenibile, della difesa dei beni comuni e della cooperazione tra i popoli. Da
anni le associazioni, i sindacati, i movimenti e molti media indipendenti
denunciano le gravi responsabilità dell'Eni su questi temi e i suoi
comportamenti scorretti o incompatibili con la difesa dei valori di pace e
rispetto della sovranità dei popoli, che tutti dovremmo condividere e che
rappresentano l'essenza stessa della nostra Costituzione.
Nello scorso febbraio l'Osservatorio Eni, che raggruppa proprio la rete di
associazioni, sindacati e comitati costituitasi in Italia, ha incontrato i
capigruppo alla Camera di Rifondazione Comunista e dei Verdi, il ministro
dell'Ambiente e il presidente della Camera, durante le concitate fasi del
rapimento dei dipendenti italiani dell'Eni in Nigeria. Sapevamo bene, allora
come adesso, che non sarebbe bastato impegnarci per riportare a casa i nostri
connazionali ma che ci sarebbe servito uno sforzo più grande per risolvere la
situazione. Non si può pensare di salvare la vita ai nostri connazionali e nello
stesso tempo non far nulla per decine di milioni di persone verso le quali siamo
responsabili per le violazioni e lo sfruttamento irresponsabile compiuto dalla
nostra azienda e alle quali dobbiamo delle risposte. Liberare gli ostaggi,
disinquinare il Delta del Niger: era l'appello rivolto alla politica
istituzionale per capovolgere un'impostazione ancora colonialista
nell'affrontare le relazioni con i paesi del sud del mondo e in particolar modo
verso l'Africa.
Tutti i politici che hanno voluto incontrarci si sono impegnati, a parole, ad
agire affinché l'Eni cambi la propria politica ambientale, energetica e di
rispetto dei diritti umani nella regione del Delta del Niger. A oggi ancora
nulla è cambiato.
Il primo obiettivo, riportare a casa gli italiani rapiti, è stato raggiunto con
l'impegno di tutti quando il 14 marzo i guerriglieri del Mend hanno rilasciato
gli ultimi due ostaggi trattenuti, Cosma Russo e Francesco Arena, facendo tirare
un sospiro di sollievo a tutti noi. Lo stesso portavoce del Mend aveva
sottolineato che sul rilascio pesava soprattutto il lavoro positivo delle
associazioni italiane e africane che finalmente avevano fatto luce e detto la
verità sulla situazione nella quale vivono venti milioni di nigeriani e sulle
responsabilità enormi dell'Eni.
Dopo la liberazione dei nostri concittadini, purtroppo, nulla è stato fatto e
nulla sembra essere mutato. La regione del Delta del Niger rimane una delle zone
più inquinate del pianeta e le condizioni in cui vivono le popolazioni locali
sono subumane: senza acqua potabile, fognature, luce elettrica e con un reddito
medio di 1-2 dollari al giorno, mentre le multinazionali del petrolio, tra le
quali l'Eni, estraggono 2,5 milioni di barili di greggio al giorno dagli stessi
territori in cui è a rischio la sopravvivenza di milioni di persone.
Oggi ci troviamo di nuovo a discutere della vita di altri italiani sequestrati
in Nigeria alcuni giorni fa proprio a causa della sciagurata politica portata
avanti dalle multinazionali petrolifere, che continuano a trattare l'ambiente e
decine di milioni di persone come un mero ostacolo ai loro bisogni di profitto.
Per questo non possiamo più accettare che il governo italiano si interessi dei
quattro italiani disinteressandosi allo stesso tempo del debito storico ed
ecologico contratto con la Nigeria attraverso le attività che le imprese
italiane hanno portato e continuano a portare avanti sul Delta del Niger e non
solo.
Chiediamo ancora una volta che il governo, in quanto azionista di controllo,
richiami l'Eni a un comportamento ecologicamente responsabile e al rispetto dei
diritti umani e dei trattati internazionali.
Chiediamo l'istituzione di una commissione aperta a esperti scelti dalla società
civile che verifichi la situazione, il comportamento dell'Eni e i livelli
d'inquinamento del Delta del Niger, che sta mettendo a rischio la vita di intere
popolazioni che vivono nell'area.
Speriamo almeno su queste elementari questioni di democrazia e rispetto delle
regole, di ricevere dalla politica un rapido riscontro. Se la politica non è in
grado di darci risposte e ascoltare le esigenze di milioni di cittadini, a
partire da coloro che partono da una situazione di svantaggio, smette di essere
uno strumento di governo del popolo e per il popolo, e diventa una élite tesa
solo alla sua autoriproduzione, esattamente come i cda delle multinazionali.
Alex Zanotelli, Giuseppe De Marzo (A Sud), Vincenzo Miliucci (Cobas), Fulvio Vescia (RdB Energia), Alessandro Marescotti (Peacelink), Franco Ottaviano (Casa delle Culture), Antonio Tricarico (Crbm), Marco Bersani (Attac Italia), Fabio Alberti (Un ponte per...), Beatrice Bardelli (Comitato contro il Rigassificatore Offshore Livorno-Pisa), Claudio Avvisati, Stefano Fossati, Edo Dominici (delegati Cgil Rsu Eni)
Morti di Portopalo, una strage impunita
Assolto l'armatore della nave Iohan, che nel '96 speronò una piccola imbarcazione con a bordo più di 300 persone. Ne morirono 283. Accusato di omicidio volontario, per la Corte «non ha commesso il fatto»
Assolto «per non aver commesso il
fatto». Si conclude così, dopo undici anni, il processo presso la corte d'assise
di Siracusa contro Turab Ahmed Sheik, l'armatore della nave Iohan. Rimane dunque
- almeno per ora - senza colpevoli il cosiddetto «naufragio di Natale», la più
grande strage della migrazione illegale, in cui morirono 283 persone. Cingalesi,
indiani, pakistani, tutti giovanissimi, che da mesi viaggiavano con la speranza
di poter raggiungere l'Italia. Era la notte della vigilia di Natale del 1996. Al
largo della costa di Portopalo si inabissò la piccola imbarcazione (la F-147) su
cui erano state fatte calare più di trecento persone nonostante le cattive
condizioni metereologiche. La Iohan, guidata dal libanese Youssuf El Hallal,
entrò in collissione con la barca almeno due volte: la prima, poco dopo il
trasbordo. La seconda, quandò tornò indietro. Per aiutare i giovani asiatici -
visto che la F-147 stava imbarcando acqua - o per speronarla come sostengono
alcuni testimoni?
Tourab era accusato di concorso in omicidio volontario plurimo. Dello stesso
reato è accusato El Hallal, attualmente sotto processo a Catania. Quello di ieri
era lo scoglio più difficile della vicenda giudiziaria. Per un motivo: Tourab,
che vive a Malta e che dopo la strage ha continuato a trafficare migranti, ha
sempre sostenuto di essere rimasto a terra quella notte. Gli avvocati
dell'accusa hanno cercato in tutti i modi di provare che, invece, Tourab era
presente, basandosi su alcune testimonianze. Hanno, inoltre, cercato di
sostenere che organizzare il traffico implica una responsabilità. Tutte cose
che, però, non hanno convinto la corte, presieduta dal giudice Romualdo Benanti.
Nonostante l'amarezza, i legali cercano di mettere in luce il lato positivo.
Osserva l'avvocato Paolo Reale: «Leggeremo le motivazioni, ma intanto la formula
scelta dalla Corte non è "il fatto non sussiste", bensì "non ha commesso il
fatto"». Ovvero, un filo di speranza per la condanna del comandante El Hallal
(pare rientrato in Libano dopo che la Francia non concesse l'estradizione). Se
«sussiste il fatto», certamente quella notte il comandante c'era e ha preso
tutte le decisioni del caso. Esprime «profonda amarezza» anche l'altro
difensore, l'avvocata romana Simonetta Crisci. La delusione, d'altronde, viene
da lontano, visto che l'assoluzione di Tourab si deve innanzitutto a una cosa:
«Le lacune della nostra legislazione», sottolinea Reale. Inizialmente, infatti,
l'armatore era imputato anche per altri reati, come il traffico internazionale
di clandestini. Tutti decaduti quando venne ritrovato il relitto della nave,
fuori dalle acque nazionali. «E non essendo avvenuto il traffico in acque
nazionali, paradossalmente non può essere perseguito. Come se una persona
trafficata lo fosse soltanto quando fa ingresso nel nostro paese. Assurdo.
Dobbiamo rinnovare la nostra legislazione», denuncia Reale. Si dice
«soddisfatto», invece, l'avvocato di Toruab, Giuseppe Cristiano: «Il processo
non si conclude con un giudizio politico o etico, la sentenza esprime un
giudizio sul piano strettamente giuridico e, vista da questo punto di vista,
ritengo che si tratti di una sentenza corretta».
Parlano di «assoluzione vergognosa», invece, le associazioni che in tutti questi
anni hanno seguito il caso e chiedono giustizia anche per le famiglie di vittime
e sopravvissuti, che non hanno mai ricevuto alcun risarcimento. Senza confine,
Arci, Attac, Rete Antirazzista siciliana, Unione dei lavoratori pakistani in
Italia, ora sono preoccupati. Non soltanto per l'assoluzione di Tourab. Ma
perché sembra che stia naufragando anche la possibilità di recuperare in tempi
brevi il relitto dell'imbarcazione affondata. Impegno che aveva preso in prima
persona il presidente del consiglio Romano Prodi. Un recente sopralluogo della
Protezione civile, infatti, avrebbe rilevato che la F-147 è seppellita da decine
e decine di reti di pescatori: il recupero è difficile. Inoltre, dovrà
probabilmente essere bandita una gara d'appalto. «In pratica tempi lunghissimi -
denuncia Alfonso di Stefano della Rete antirazzista - ma il recupero del relitto
è fondamentale per studiare come l'imbarcazione è stata speronata, e verificare
ciò che sostengono numerosi testimoni: e cioè che la Iohan speronò
volontariamente l'imbarcazione carica di persone».
Cessate il fuoco
Questa settimana, in tutti i paesi
ancora in guerra, sono morte almeno 934 persone
Iraq
Questa settimana sono morte almeno 684 persone (503 civili, 25 soldati Usa,
un britannico, 102 poliziotti iracheni e almeno 53 miliziani).
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 11.974.
Afghanistan
Questa settimana sono morte almeno 83 persone (43 civili, 18 talebani o
presunti tali, 15 militari afgani e 7 soldati della Nato).
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 1.718 (404 civili, 988 talebani o
presunti tali, 268 militari afgani, 58 soldati della Nato).
Israele - Palestina
Questa settimana è morta almeno una persona.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 121.
Cecenia (Russia)
Questa settimana sono morte almeno 14 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 316.
Colombia
Questa settimana sono morte almeno 9 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 130.
Thailandia del Sud
Questa settimana sono morte almeno 24 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 175.
Filippine-Mindanao
Questa settimana sono morte almeno 13 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 148.
Filippine-Npa
Questa settimana sono morte almeno 2 persone.
Almeno 75 morti dall’inizio dell’anno.
Sri Lanka
Questa settimana sono morte almeno 46 perone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 1.091.
India Nordest
Questa settimana sono morte almeno 12 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 384.
India Naxaliti
Questa settimana sono morte almeno 4 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 206.
India Kashmir
Questa settimana sono morte almeno 13 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 243.
Pakistan Aree Tribali
Questa settimana sono morte almeno una persona.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 704.
Kenya
Questa settimana sono morte almeno 10 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 177.
Somalia
Questa settimana sono morte almeno 4 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 171.
Nigeria
Questa settimana sono morte almeno 3 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 296.
Rep. Dem. Congo
Questa settimana sono morte almeno 11 persone.
Dall’inizio dell’anno i morti sono almeno 464.
La destra che avanza
Rossana Rossanda
Ségolène Royal non ce l'ha fatta,
sei punti la separano da Nicolas Sarkozy, eletto presidente della repubblica in
Francia con i voti della destra, di metà del centro e quasi tutta l'estrema
destra lepenista. La partecipazione al voto è stata massiccia, il suo segno
inequivocabile. Nicolas Sarkozy, duro ministro degli interni del governo
uscente, era arrivato primo fin dal primo turno, e tale è sempre rimasto. La
candidata socialista era giunta al ballottaggio in difficoltà, con François
Bayrou che le sbarrava la strada, un elettorato centrista perplesso e con le
sinistre alla sua sinistra in briciole - cosa di cui i commentatori si sono
gloriati. La campagna di Ségolène era stata assai moderata, all'insegna
dell'incontro diretto con la gente, e appena ha alzato il tono nell'unico faccia
a faccia con Sarkozy (intendiamoci, niente a che vedere con le pesantezze
nostrane) è scesa di colpo di tre punti. Per amor del cielo, s'è allarmata la
Francia, basta con gli estremismi - la stampa scritta, Le Monde in testa, l'ha
rimproverata e perfino il Nouvel Observateur, che invitava a votare per lei,
aggiungeva che in ogni caso Sarkozy non sarebbe stato il peggiore dei
presidenti. Morale, l'ex ministro degli interni ha vinto alla grande. Adesso ci
sono le legislative per il parlamento, si voterà il 12 giugno, ma è da dubitare
che gli elettori, confusi e pentiti, diano a Sarkozy una buona lezione dopo
averlo promosso.
Che cosa ha indotto su questa strada i nostri vicini, che molto ci avevano
sbertucciato per via di Berlusconi? Primo, la «rottura» promessa da Sarkozy:
basta con l'uguaglianza, basta con le 35ore, detassazione degli straordinari per
le imprese, proibizione degli scioperi senza previo referendum fra tutti i
lavoratori, fine dell'assistenza ai disoccupati che non accettino la seconda
proposta di lavoro, riduzione a metà del turnover nella funzione pubblica, soldi
all'impresa come sola e sufficiente garanzia di crescita e quindi
dell'occupazione, immigrazione «scelta», difesa dell'identità nazionale,
un'Europa senza costituzione e senza bisogno di referendum, ripristino di tutte
le autorità e si finisca una buona volta con la nefasta eredità del maggio '68.
Queste ripetute dichiarazioni non hanno incontrato nessun movimento di protesta.
Quanto sia profonda la «rottura», anche culturale, dimostra lo spiattellamento
delle sinistre, la cui litigiosità è stata nuovamente suicida. Insomma, l'onda
di destra è mobilitante: chi parla di crisi della politica? La politica funziona
ancora a contrastare un riemergere della sinistra, per morbida che si presenti.
Secondo, mai una donna presidente della Repubblica! Bisogna essere stati qui per
crederlo, ma in un paese così moderno, prospero e avanzato è diffuso il dubbio
che una donna possa dirigere lo stato. Una stampa attenta al minimo errore o
presunto tale, le crudeli vignette (la satira sarà sacra, ma lavora sulle
pulsioni sicure), la scarsa propensione delle donne a votare per una di loro, il
defilarsi delle femministe: è stata esplicita l'intenzione di sbarrare la strada
a una donna, ancorché moderata e sostenitrice dell'ascolto, perdipiù avvenente e
così sicura di sé da non farsi cooptare da nessuno, piacesse o no ai leader del
suo partito. I quali sono già partiti per farle la festa. Il sacerdozio,
ecclesiatico o civile, non è cosa da femmine. Su questo la laicissima Francia
raggiunge piuttosto il Vaticano che la Germania o il Regno Unito.
In breve, nell'Europa del terzo millennio la parola «rinnovamento» suona: a
destra tutta. Viene in mente Breznev che, a chi osservava che quello dell'Urss
non era socialismo, ha ribattuto: questo è il solo che ci sia, il socialismo
reale. E questa, ci dicono nel 2007 le urne transalpine, è la democrazia reale.
Fiori avvelenati
Bajo Flores, 'favela' argentina, dove il narcotraffico la fa da padrone
scritto da Serena Corsi
Bajo Flores è la più grande Villa
Miseria - equivalente argentino delle favelas- della città di Buenos Aires. Il
nome proviene dalla locazione geografica: la Villa è sorta sotto a Flores, uno
dei quartieri residenziali più vecchi e popolari della città. Ma a nessuno
sfugge l’ironia nera che nasconde il nome: sotto i fiori c’è il fango – il
letame, lo stesso che invade le strade sterrate della Villa ogni volta che
piove, mescolando l’acqua piovana a quello che fuoriesce dalle fogne
artigianali. In questo quadro si innesta una delle questioni più dolorose
dell’attualità sudamericana: il narcotraffico e la diffusione di una droga di
infima qualità fra chi non può permettersi quelle di prima; per il mercato
argentino lo scarto della lavorazione della cocaina (detto paco) proviene
soprattutto dal Perù , e viene prodotto ad hoc per gli ultimi consumatori della
catena. Sono i figli delle Villas, giovanissimi, disoccupati, destinati alla
strada, presto costretti a divenire corrieri del paco per poterlo consumare . E
si ingrossa la lista delle vittime , non solo della droga , ma anche dei
regolamenti di conti delle bande che detengono il potere della distribuzione e
che si spartiscono le zone della Villa , meticolosamente numerate come i settori
di un carcere.
Anche l'omertà. In una notte di qualche tempo fa, sono stati accoltellati due
fratelli : il più giovane , Lucas, è morto. Erano entrambi figli di Susana
Acosta, delegata di quartiere- praticamente l’unica forma di rappresentanza
delle istituzioni in queste terre di nessuno . Susana: una che , quando si è
trattato di rompere il silenzio sullo strapotere della criminalità organizzata ,
non si è mai tirata indietro: “Questi assassini, profughi della giustizia , si
nascondono certi della protezione della polizia”. L’omertà copre come una nebbia
le baracche di Bajo Flores : ognuno, almeno una volta, ha visto uno spacciatore
vendere droga accanto a un poliziotto indifferente, o peggio ancora, corrotto
alla luce del sole. Denunciare è inutile, oltre che molto pericoloso. E non si
tratta solo della paura di ritorsioni: come tutte le mafie del pianeta , anche
quella peruana che controlla la Villa sa che il potere passa anche attraverso il
consenso . E non è raro che gli abitanti considerino i capi della criminalità
come dei benefattori: Salvador, come chiamano qui a Marcos Estrada Gonzalez
–secondo la polizia, il cervello della banda più potente- ha provveduto a pagare
l’albergo a diverse famiglie che hanno dovuto lasciare la casa perchè minacciate
da una banda rivale. Ma Susana è sempre rimasta fuori da queste logiche. “ Con
il tema della droga sono sempre stata molto sincera : io non ci sto. Altri
delegati non erano della stessa opinione : l’unico modo per avere più
sicurezza,dicevano, è allearsi coi cartelli. Ma io sono contraria, ora più di
prima ” .Questo coraggio gli è valso la riconferma puntuale del suo ruolo nel
quartiere, anno dopo anno . E , forse, ha qualcosa a che fare con la morte di
suo figlio. “ Non so. Il giorno della veglia funebre un uomo mi si è avvicinato
e mi ha detto: ‘ sicuramente è stato un errore, sorella. Cercavano
qualcun’altro. Però possiamo rimediare con del denaro’ ”. Susana ha risposto con
un uno sguardo inorridito, racconta. Ma questa pratica- indennizzare le famiglie
delle vittime accidentali della guerra tra Narcos – già diffusa in altri paesi,
probabilmente ha già preso piede anche qui. Una giustizia triviale che rinvia a
chissà quando l’intervento di quella ordinaria .
Il parere. Secondo Gabriela Cerruti, ministro dei Diritti Umani , l’unico modo
di controllare la violenza prodotta dal narcotraffico “è ricostruire e affermare
la presenza nel quartiere, in tutte le forme possibili”; ad esempio, se gli
abitanti non possono denunciare quello che succede, creare una rete che bypassi
la polizia locale e faccia arrivare le denunce, da parte dei rappresentanti del
governo, direttamente alla Camera del Crimine. Questa proposta fa i conti con un
problema profondissimo della società argentina : lo Stato sa che non può
controllare la polizia. Almeno non in tempi brevi. Inoltre, l’Argentina è ancora
piuttosto disarmata perchè la diffusione massiva del paco nelle Villas è
cominciata non prima della fine degli anni ’90, e il cartello peruano si
manifesta ormai come il più potente del Sudamerica . Perciò, è una battaglia che
si può vincere solo combattendola dal basso. Qualche passo può già essere fatto
, investendo su un cambio di mentalità generale che agisca in seconda battuta
anche sui singoli poliziotti: una catena umana , sociale, intorno al
narcotraffico.
4 maggio
Inviato ai politici il rapporto
redatto a Bangkok da un gruppo di esperti provenienti da 120
Paesi
Per evitare un disastro ecologico le emissioni mondiali di gas
serra devono decrescere a partire dal 2015
Clima, l'allarme degli esperti
Onu
"Cruciali gli sforzi nei prossimi 20-30 anni"
 Lo sviluppo dell'energia eolica indicata per ridurre
l'emissione di gas serra
Lo sviluppo dell'energia eolica indicata per ridurre
l'emissione di gas serraBANGKOK - I prossimi venti, trent'anni saranno cruciali negli sforzi per attenuare il riscaldamento del Pianeta: lo ha indicato il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, l'Ipcc creato dall'Onu, in un testo di sintesi su cui esperti di 120 Paesi riuniti da lunedì scorso nella capitale thailandese hanno raggiunto stamani un accordo dopo una maratona negoziale durata tutta la notte.
"Gli sforzi di attenuazione del riscaldamento nei prossimi 20/30 anni avranno un vasto impatto sulle possibilità di raggiungere livelli più bassi di stabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra", ha affermato l'Ipcc nel suo rapporto destinato ai politici incaricati di prendere le decisioni.
"Le emissioni mondiali di gas che causano l'effetto serra devono decrescere a partire dal 2015 se si vuole mantenere l'aumento della temperatura media del pianeta fra i 2 e i 2,4 gradi centigradi", affermano gli esperti del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'Onu. Contenere entro i due gradi il riscaldamento globale costerebbe appena lo 0,12% del Pil mondiale ma eviterebbe un disastro climatico.
Il rapporto elaborato è il terzo reso noto quest'anno dall'Ipcc: i primi due hanno approfondito le prove dell'effetto-serra e i possibili impatti sull'ambiente. Una bozza del rapporto letta dall'agenzia France Presse esortava ad un maggiore uso di energie rinnovabili, come quella solare e idrica, e a una maggiore efficienza nei consumi.
Posti esauriti da mesi in
classici e scientifici: secondo il ministero arriveranno 6mila
studenti
in più, ma sono a rischio centinaia di cattedre. I sindacati:
"Colpa della Finanziaria"
Licei, posti in
piedi per il nuovo anno
di SALVO INTRAVAIA
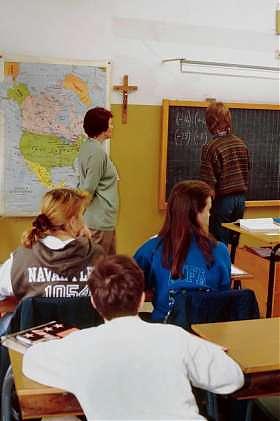
Del resto, non è un segreto che trovare un posto in un liceo classico o scientifico è diventata un'impresa titanica: tutto esaurito da mesi. Ma andiamo con ordine.
L'anno scolastico 2007/2008, in base ai dati raccolti dal ministero della Pubblica istruzione sulle iscrizioni già effettuate dai genitori (il cosiddetto organico di diritto), nelle aule italiane occorrerà fare posto a circa 6 mila alunni in più con un incremento di appena 42 classi. Se le previsioni del ministero saranno confermati basta confrontarli quelli, questa volta reali (alunni e classi effettive), di quest'anno per fare emergere una situazione diversa. La prospettiva è di ritrovarsi a settembre con 37 mila studenti in più a fronte di un calo delle classi che si abbatte pesantemente proprio nella scuola secondaria di secondo grado. Quasi mille classi in meno rispetto all'anno che volge al termine con migliaia di cattedre Aa rischio. Del resto, la Finanziaria varata dal ministro dell'Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, lo scorso dicembre ha previsto, per assottigliare l'organico degli insegnanti, un incremento del rapporto alunni-classi.
Dispersione, sicurezza e stress degli insegnanti subiranno un ulteriore peggioramento? Se la matematica non è un'opinione, sembrerebbe proprio di sì. Basta dare un'occhiata alle statistiche per capire che la dispersione scolastica (abbandoni, ma soprattutto bocciature) aumenta nelle classi più affollate, soprattutto le prime che hanno il delicato compito di accogliere i ragazzini provenienti dalle media. Stesso discorso per la sicurezza, questione di fatto irrisolta. Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ammettono, nella migliore delle ipotesi, un limite massimo di 28 alunni per classe: con 35 potrebbero crearsi situazioni di estremo pericolo, per esempio, in caso di incendio. E lo stress degli insegnanti? Se la normativa in materia di composizione delle classi ha stabilito un tetto massimo al numero degli studenti non è certo per sperperare denaro pubblico. Anzi. E' chiaro a tutti, anche a coloro che non hanno messo mai un piede in una aula da docente, che gestire un gruppo di 30/35 alunni non è la stessa cosa di gestirne 20. Dove va a finire l'insegnamento individualizzato di cui c'è traccia in mille documenti ufficiali? "Le disposizioni sulla formazione delle classi non hanno subito variazioni - spiega Giuseppe Fiori, direttore generale per il Personale - e eventuali classi con 30/35 alunni non sono giustificate da nessuna normativa vigente".
Ma non basta. Al taglio operato i questi giorni si dovrebbe aggiungere un ulteriore colpo di forbici a settembre: in organico di fatto. Dove 'sistemeranno', soprattutto i presidi degli istituti ubicati nelle regioni del Nord, gli alunni?
"E' la prova del disastro della Finanziaria - dichiara Enrico Panini, segretario generale della Flc Cgil - Non esiste paese al mondo in cui aumentano i ragazzi, e la richiesta di formazione qualificata e di alto livello, e il governo risponde riducendo gli insegnanti e le classi", un atto pesante d'accusa che non lascia spazio a troppe giustificazioni. "Finora, alle forti richieste avanzate dal mondo della scuola e dai sindacati - continua Panini - il governo ha risposto con buone ma vuote parole". "La situazione economica e strutturale della scuola pubblica - incalza Piero Bernocchi, coordinatore nazionale dei Cobas - diviene ogni giorno più drammatica, al limite della catastrofe e del degrado più inaccettabile. Quello che fa rabbia è che era tutto già scritto in una Finanziaria che, invece di rispettare l'impegno elettorale dell'Unione a invertire il trend sulla riduzione dei finanziamenti nell'istruzione pubblica, addirittura la accelera". E sui tagli l'affondo finale. "I tagli alla superiore - continua Bernocchi - sono i più evidenti e vistosi, resi ancor più gravi dall'aumento delle iscrizioni a livello nazionale: quello che già accade ora, 30-32-34 alunni per classe, diverrà la norma, con ripercussioni sulla didattica, aumento della selezione e ulteriore logoramento di docenti già molto provati".
3 maggio
La banca dei bambini
Un fenomeno in crescita nei paesi poveri: piccoli lavoratori, imprenditori di se stessi
Rinunciare all’idea che certe regole e
valori debbano essere comuni a ogni latitudine, trasformando quelli
che nell’ottica occidentale sembrano abusi e illegalità nel loro
esatto contrario. E’ quanto successo in India per la questione dei
bambini lavoratori quando, non potendo abolire il lavoro minorile in
una terra tanto povera, per evitare che questi subissero le
prevaricazioni degli adulti si è cominciato a dare ai baby
lavoratori vere e proprie garanzie sindacali. Da questo si è passati
alla creazione di istituti bancari dedicati ed è così che oggi
migliaia di ragazzi “costretti” a lavorare possono far valere i loro
diritti e le loro necessità.
La Children’s Development Bank. L’esperimento nasce grazie al
Collettivo di bambini lavoratori e di strada di Delhi, Bal Mazdoor
Union, ma la sua azione ha provocato una serie di interventi a
catena che, naturalmente, hanno attecchito in paesi, come lo Sri
Lanka e l’Afghanistan, dove da qualche tempo opera la Children's
Development Bank. Una banca voluta e realizzata da soci che hanno
tra i 6 e i 18 anni e che, proprio nella loro qualità di bambini e
adolescenti, hanno diritto non solo a depositare il denaro
guadagnato con la propria fatica, ma anche ad avere un proprio
libretto di risparmio, a chiedere prestiti e far parte dei Consigli
di Amministrazione.
Si tratta di un modello di banca gestita dai ragazzi come una
cooperativa in cui gli adulti hanno solo il ruolo di garanti e
facilitatori. Un modo per prendere in mano la propria vita che
funziona, a giudicare dai risultati.
Due storie esemplari. Sono stati alcuni di questi ragazzi e
ragazze a spiegare direttamente la loro esperienza nel corso della
visita in Italia.
Tra i “piccoli imprenditori” Gayan Madhushanka e Kosalle
Madhurangika entrambi provenienti dallo Sri Lanka, un paese dove la
povertà si somma a una guerra civile semisconosciuta al mondo.
Kosalle, 15 anni, con il prestito ottenuto è riuscita a mettere su
una piccola produzione agricola e, con l’aiuto di altri coetanei
porta avanti un’attività che la ripaga di un recente passato fatto
di povertà e privazioni.
A Gayan, 16 anni, il prestito della Children’s Develomment Bank è
servito per comprare l’equipaggiamento per giocare a cricket. Il
padre per anni è stato soldato nell’esercito regolare, ma lui di
armi non ne voleva sapere e ha avuto ragione perché grazie al
prestito e a tanto, tanto allenamento, ha vinto, nell’ambito degli
istituti scolastici, il premio per il migliore giocatore del paese e
ora è in attesa di entrare a far parte della squadra nazionale dello
Sri Lanka under 17.
Un po’ di denaro per grandi speranze. E non importa che si
tratti di aprire un negozio, comprare degli animali o semplicemente
conservare i pochi spiccioli guadagnati. Ciò che conta per questi
ragazzi è credere di potercela fare da soli, autonomamente, con le
proprie forze e con pochi, ma semplici diritti garantiti.
Antonella Sinopoli
Missione placebo
A Rio è sempre più violenza e il governo manda 900 militari. Peccato che non potranno intervenire
Aveva 23 anni e una brillante carriera
universitaria davanti. È morta ammazzata da una pallottola vagante
sparata da chissà quale pistola fra quelle impugnate da orde di
narcotrafficanti impegnati, da ore, a spararsi contro per ottenere
il controllo del territorio. A Rio de Janeiro è sempre peggio e il
governo di Brasilia ha finalmente deciso di ascoltare le accorate
richieste di aiuto del governatore dello stato: novecento uomini dei
reparti speciali dell'esercito brasiliano saranno inviati nella
capitale carioca e schierati in quelli che sono stati definiti i
“punti strategici della città, ma il loro mandato sarà alquanto
limitato”.
 Far West. Si chiamava Juliana Perreira da Silva. È stata
colpita all'inguine mentre in auto percorreva l'Avenida Brasil, fra
le arterie principali della zona est di Rio. L'unica sua colpa:
trovarsi nel punto sbagliato al momento sbagliato. Sì, perché quella
lunga strada per alcuni tratti costeggia zone di favelas e
disperazione, dove lo stato è presente solo nelle pistole della
polizia che cerca di avere la meglio sui criminali, in vere e
proprie terre di nessuno. Questa volta però, nel duello scatenatosi
di prima mattina, i poliziotti non c'entrano: a scaricarsi addosso
raffiche di proiettili, in scene da far west, erano i
narcotrafficanti. Due gruppi rivali l'uno contro l'altro armati:
l'uno, gli Amici degli Amici, intento a difendere la loro zona di
spaccio, l'altro, niente di meno che il Comando Vermelho - il più
antico e temuto clan del Brasile - impegnato a conquistare un'altra
golosa fetta di città.
Far West. Si chiamava Juliana Perreira da Silva. È stata
colpita all'inguine mentre in auto percorreva l'Avenida Brasil, fra
le arterie principali della zona est di Rio. L'unica sua colpa:
trovarsi nel punto sbagliato al momento sbagliato. Sì, perché quella
lunga strada per alcuni tratti costeggia zone di favelas e
disperazione, dove lo stato è presente solo nelle pistole della
polizia che cerca di avere la meglio sui criminali, in vere e
proprie terre di nessuno. Questa volta però, nel duello scatenatosi
di prima mattina, i poliziotti non c'entrano: a scaricarsi addosso
raffiche di proiettili, in scene da far west, erano i
narcotrafficanti. Due gruppi rivali l'uno contro l'altro armati:
l'uno, gli Amici degli Amici, intento a difendere la loro zona di
spaccio, l'altro, niente di meno che il Comando Vermelho - il più
antico e temuto clan del Brasile - impegnato a conquistare un'altra
golosa fetta di città.
I fatti. Erano le sette del mattino di giovedì. Juliana
viaggiava con due amici, uno di 26 e uno di 23 anni, su un'auto,
destinazione: università. All'improvviso il panico: pallottole da
ogni dove sono piovute da ogni parte, ferendo a morte lei e
leggermente i suoi due compagni. Disperata la corsa all'ospedale,
dove poche ore dopo è morta. La sparatoria ha scatenato il panico
fra tutti i passanti della trafficata Avenida Brasil, gente ormai
sempre più stressata da una violenza senza fine.
Dal primo febbraio 2007, si contano 802 morti e 438 feriti, una vera
e propria guerra, con una media di nove persone uccise al giorno.
 Arrivano i nostri. Il giovane governatore dello Stato, Sergio
Cabral, ha accoratamente chiesto al governo federale l'intervento
dell'esercito: “Non voglio passare quattro anni del mio Governo
assistendo a funerali di agenti e civili assassinati nelle strade”,
aveva detto poche settimane fa. Un appello che ha toccato il
presidente Luiz Inacio Lula da Silva che da subito aveva promesso di
aiutare "l'amico Cabral”. E così si è mosso. Il governo brasiliano
ha, infatti, messo a disposizione di Rio de Janeiro circa novecento
unità, destinate al controllo della sicurezza, con un piano ideato
dal ministro della Giustizia, Tarso Genro, che ha coinvolto uomini
di Esercito, Aeronautica e Marina. Eppure un “ma” resta: i militari
non faranno, almeno per ora, operazioni dirette nelle strade di Rio.
Questi sono gli ordini. La loro è una missione di presenza, mirata
ad "aumentare la sensazione di sicurezza in città. "Le forze armate
- ha spiegato Genro - avranno un ruolo di sostegno alla polizia",
non di sostituzione. Il compito delle forze armate, quindi, sarà
solo di appoggio logistico e d'intelligence, tanto che qualcuno ha
commentato: “sempre meglio di niente”. Il piano, che scatterà in
quindici giorni, prevede un primo utilizzo di 600 militari, a cui
verranno poi aggiunti altri 300 uomini. Ma al di là dei numeri,
resta da chiedersi se questa missione “effetto placebo” basterà a
migliorare la qualità di vita di una città ormai teatro di una
guerra interna.
Arrivano i nostri. Il giovane governatore dello Stato, Sergio
Cabral, ha accoratamente chiesto al governo federale l'intervento
dell'esercito: “Non voglio passare quattro anni del mio Governo
assistendo a funerali di agenti e civili assassinati nelle strade”,
aveva detto poche settimane fa. Un appello che ha toccato il
presidente Luiz Inacio Lula da Silva che da subito aveva promesso di
aiutare "l'amico Cabral”. E così si è mosso. Il governo brasiliano
ha, infatti, messo a disposizione di Rio de Janeiro circa novecento
unità, destinate al controllo della sicurezza, con un piano ideato
dal ministro della Giustizia, Tarso Genro, che ha coinvolto uomini
di Esercito, Aeronautica e Marina. Eppure un “ma” resta: i militari
non faranno, almeno per ora, operazioni dirette nelle strade di Rio.
Questi sono gli ordini. La loro è una missione di presenza, mirata
ad "aumentare la sensazione di sicurezza in città. "Le forze armate
- ha spiegato Genro - avranno un ruolo di sostegno alla polizia",
non di sostituzione. Il compito delle forze armate, quindi, sarà
solo di appoggio logistico e d'intelligence, tanto che qualcuno ha
commentato: “sempre meglio di niente”. Il piano, che scatterà in
quindici giorni, prevede un primo utilizzo di 600 militari, a cui
verranno poi aggiunti altri 300 uomini. Ma al di là dei numeri,
resta da chiedersi se questa missione “effetto placebo” basterà a
migliorare la qualità di vita di una città ormai teatro di una
guerra interna.
Stella Spinelli
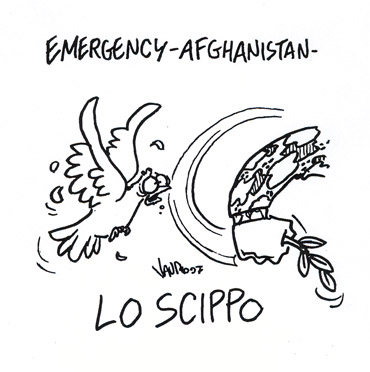
 Una
storia italiana. C’è un Vajont che non riguarda la spaventosa
notte di 40 anni fa. E nemmeno l’avidità umana, l’imperizia, la
criminale leggerezza con la quale vennero ignorati gli
inequivocabili avvertimenti lanciati per anni dalla natura
violentata dagli uomini. E’ il Vajont del “dopo”. Dopo che dal Monte
Toc si staccò la gigantesca frana che scavalcò la diga. Dopo che
l’onda rubò la vita a 1910 esseri umani. Dopo che tutto quello che
poteva essere fatto per evitare la strage non fu fatto. E’ la storia
di come lo Stato si comportò con i superstiti. E’ la storia di come
si riuscì a fare un business anche della disgrazia, di come in nome
del Vajont venne pianificato lo sviluppo industriale di tutto il
Triveneto, di come si fecero leggi per elargire miliardi ad aziende
e privati che non avevano perso nulla nella disgrazia. Di come
invece si trovarono cavilli legali per liquidare con quattro soldi
chi aveva perso tutto, casa, affetti e persino ricordi. E’ la storia
di come gli stessi meccanismi che avevano portato alla tragedia si
riproposero nel dopo, umiliando i deboli e le vittime, favorendo
chi, non avendo morti da piangere, poteva farsi avanti per reclamare
la sua fetta di torta. Il dopo Vajont è una storia italiana
esemplare, non a caso ignorata dai media. “E’ stato ancora peggio
della tragedia” si sfogano da anni molti superstiti.
Una
storia italiana. C’è un Vajont che non riguarda la spaventosa
notte di 40 anni fa. E nemmeno l’avidità umana, l’imperizia, la
criminale leggerezza con la quale vennero ignorati gli
inequivocabili avvertimenti lanciati per anni dalla natura
violentata dagli uomini. E’ il Vajont del “dopo”. Dopo che dal Monte
Toc si staccò la gigantesca frana che scavalcò la diga. Dopo che
l’onda rubò la vita a 1910 esseri umani. Dopo che tutto quello che
poteva essere fatto per evitare la strage non fu fatto. E’ la storia
di come lo Stato si comportò con i superstiti. E’ la storia di come
si riuscì a fare un business anche della disgrazia, di come in nome
del Vajont venne pianificato lo sviluppo industriale di tutto il
Triveneto, di come si fecero leggi per elargire miliardi ad aziende
e privati che non avevano perso nulla nella disgrazia. Di come
invece si trovarono cavilli legali per liquidare con quattro soldi
chi aveva perso tutto, casa, affetti e persino ricordi. E’ la storia
di come gli stessi meccanismi che avevano portato alla tragedia si
riproposero nel dopo, umiliando i deboli e le vittime, favorendo
chi, non avendo morti da piangere, poteva farsi avanti per reclamare
la sua fetta di torta. Il dopo Vajont è una storia italiana
esemplare, non a caso ignorata dai media. “E’ stato ancora peggio
della tragedia” si sfogano da anni molti superstiti.  Fanno
paura a prima vista. Ma sono innocui, anche se un po’ petulanti.
Mentre, con la sua piccola cassetta di legno piena di arnesi da
lavoro si appresta a pulire le mie scarpe sporche, Luis racconta il
perché del suo viso coperto. “Mi copro il volto perché non voglio
che la gente mi riconosca. Ho molti amici e amiche qui in città e mi
vergogno. Sono povero e questo lavoro, anche se umile, mi aiuta a
sopravvivere e a portare soldi a casa. Lo faccio soprattutto perché
mi devo pagare gli studi”.
Fanno
paura a prima vista. Ma sono innocui, anche se un po’ petulanti.
Mentre, con la sua piccola cassetta di legno piena di arnesi da
lavoro si appresta a pulire le mie scarpe sporche, Luis racconta il
perché del suo viso coperto. “Mi copro il volto perché non voglio
che la gente mi riconosca. Ho molti amici e amiche qui in città e mi
vergogno. Sono povero e questo lavoro, anche se umile, mi aiuta a
sopravvivere e a portare soldi a casa. Lo faccio soprattutto perché
mi devo pagare gli studi”.  Cumuli di spazzatura in provincia di Napoli
Cumuli di spazzatura in provincia di Napoli